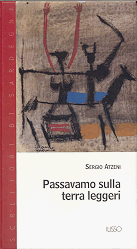
|
|
|
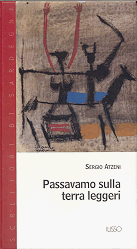
|
|
|
| << | < | > | >> |Indice5 Nota introduttiva 9 Passavamo sulla terra leggeri 161 La lingua degli antichi |
| << | < | > | >> |Pagina 5Passavamo sulla terra leggeri è il titolo dell'ultimo romanzo di Sergio Atzeni. Secondo la testimonianza di Giovanni Dettori, l'autore lo aveva concluso nell'agosto del 1995, «il trenta metto il punto finale, spedisco e parto». Alcuni giorni dopo, era il 6 settembre 1995, il viaggio in Sardegna per Sergio si concludeva drammaticamente nel mare dell'isola di San Pietro. Questa testimonianza assume il valore emblematico di un doppio commiato: dalla sua ultima opera e dalla vita. Il romanzo, pubblicato nel 1996 da Mondadori, è una sorta di viaggio nel tempo, la lettura in filigrana dei segni di una identità che si chiarifica a conclusione di un percorso narrativo centrato sulla Sardegna («non riesco a immaginare storie che non siano ambientate qui»). L'abilità dell'affabulatore, sostenuta da una competenza antropologica e linguistica — che è del poeta e del traduttore -, si piega alle ragioni della scrittura, vissuta come esperienza ludica e insieme come impegno etico, non senza studio e fatica nel costante confronto con modelli letterari di una solida e variegata tradizione. Domina in apertura un io narratore, alter ego dell'autore, a cui Antonio Setzu, «custode del tempo», aveva affidato il 12 agosto del 1960, quando era un bambino di otto anni, le antiche memorie dei sardi perché le trasmettesse, a sua volta, oralmente. Ma, dopo trentaquattro anni, nel mantenere l'impegno l'autore sceglie, per raccontarle, la forma scritta, codice di più lunga durata, rispettando tuttavia la matrice orale delle storie nei modi, nei ritmi, nell'espressività del parlato. La trama copre un arco temporale amplissimo: l'inizio introduce il lettore nella dimensione astorica del mito che evoca gli antichissimi abitatori dell'isola. Sono i S'ard «danzatori delle stelle», provenienti dall'Oriente, che approdarono nell'isola senza nome, spinti fortunosamente dal mare in tempesta. Erano uomini pacifici e colti; avevano una religione, conoscevano i numeri, scrutavano le stelle, misuravano le orbite celesti; "danzavano e cantavano" e vivevano felici nella nuova terra. Il percorso temporale disegnato dal racconto termina in epoca storica, nel 1409, data di un evento drammaticamente significativo che pone fine alla civiltà giudicale e alla libertà, col passaggio della Sardegna alla Corona d'Aragona. Entro questi confini temporali la narrazione dispiega con andamento rapsodico una miriade di microstorie: mito sacro, apologo, leggenda, aneddoto, idillio, racconto storico o pseudostorico, avventuroso o grottesco. Lo scrittore varia sapientemente i ritmi, mescola tipi narrativi diversi, accentua con forti ibridazioni l'espressività del linguaggio, armonizza in una coralità le voci del racconto (evidente nel noi, "magico e solenne"; presente fin dal titolo), che scorre con il fascino di un narrare antico, epico, e con la presa comunicativa di un linguaggio moderno che mescola schegge monosillabiche dell'antica lingua (ur, ja, jan, kar) e parole del sardo d'oggi (istrangius, ragas, mendula marigosa) con vari e differenti idiomi. A luoghi, grotte, rocce, fonti, sono legati miti e leggende. La prima è la leggenda di Sul la bambina «più bella dei nati nell'isola», che diventa giudice, il «migliore nella lunga storia dei giudici danzatori». È lei che istituisce il culto dei morti, scavando nella roccia le domus de janas per custodire le ceneri di Mir, che «fece per primo gli ometti di bronzo con le corna, molti occhi e molte braccia»; e per primo mise in salvo le sue genti dall'aggressione della «masnada piumata», in una caverna inaccessibile chiamata nell'antica lingua, «t'Is kal'i», luogo consacrato alla Luna e simbolo di libertà. Il modello dell'idillio dà leggerezza e colore alle storie di Eloe e Aràr, di Eleonora e Mattia: a cui fanno da contrappunto racconti crudeli od orgiastici delle feste di Karale. Col variare degli scenari compaiono e scompaiono i protagonisti delle molte storie (custodi del tempo, giudici e judikisse, episcopi e monaci, genti del luogo, genti straniere). Accelera la dinamica degli eventi: nascono villaggi e città, si celebrano nuovi riti, feste e giochi, cambiano i costumi e le istituzioni. La direttrice della Storia si muove sotto la spinta delle invasioni di vari popoli che sbarcano senza tregua, a cui si oppone la resistenza ostinata di un popolo che difende la sua libertà. Diventano inevitabili violenze e spoliazioni; ed è ugualmente inevitabile che gli uomini s'incontrino, che si scambino conoscenze e saperi, tecniche e arti, doni, che si mescolino costumi e linguaggi, musiche, canti, danze. Lo spartiacque nel romanzo è segnato dalla dominazione romana e dalla diffusione della parola di Jesus, di cui è protagonista l'episcopo Lucifero. La maturità e l'autonomia politica conquistata dal governo dei giudici decretano l'ingresso dell'isola nella Storia. Per questo l'avvento del dominio aragonese è dolorosamente inaccettabile per i custodi del tempo che decidono di interrompere a questa data le memorie del passato. Resta solamente il mito, che trasfigura gli ultimi protagonisti, Mariano e Eleonora, e li immortala nella dimensione incorruttibile della finzione letteraria, sottraendoli agli insulti della Storia. Romanzo suggestivo, che sfida e seduce il lettore curioso, disponibile a seguire attraverso «racconti mai narrati», un percorso mosso, ricco di sorprese, libero da schemi rigidi, aperto a sollecitazioni plurilinguistiche e multiculturali. Giovanna Cerina | << | < | > | >> |Pagina 9Non sapevo nulla della vita. Antonio Setzu raccontò la storia e quel che seppi era troppo, era pesante, immaginarlo e pensarlo mi metteva paura dell'uomo, del mondo e della morte. Dimenticai per trentaquattro anni. Ora ricordo, parola per parola.
Nella lingua fra i fiumi. Cento e cento case di canne, paglia e fango.
L'alta zicura di limo e tronchi al limite dell'acqua, trecentotrentatré scalini
per arrivare all'altare dove pulsava il cuore del capro, leggevamo la parola,
interrogavamo il cielo e pronunciavamo oracoli.
Nulla è tanto ordinato e perfetto quanto immotivato e misterioso come il
cielo e la volta stellata che studiavamo ogni notte immersi in calcoli sulle
distanze, le orbite, i cicli.
Distoglievamo il popolo dalle false certezze. Il numero spiega e aggiunge mistero, come la memoria. Il contadino chiedeva: «Avremo un buon raccolto, quest'anno?». Sapendo la casualità della pioggia e del secco, le stagioni consuete e le infinite varianti, rispondevamo: «Oltre i fiumi, in terre non lontane, la notte incombe a mezzogiorno, forse sono nuvole di pioggia, forse nugoli di cavallette». Era difficile sbagliare. Il pastore chiedeva: «Quanti agnelli venderò per la festa della luna nel mese delle mandorle aspre?». Conoscendo il mistero della generazione e quello del gelo rispondevamo: «Il cuore della terra è nero, forse gli agnelli saranno quanti le pecore, forse meno, forse nessuno. Quanti sono i tuoi montoni?». Chiedendo numeri educavamo a contare. Il mercante chiedeva: «Nella stagione del risveglio il barbaro giungerà a depredare o il re guiderà i guerrieri a depredare il barbaro?».
Rispondevamo: «Chi può leggere nella mente del re? Glorioso è il destino del
guerriero, felice il destino del mercante. Ma non tutti i mercanti arrivano a
vecchiaia». Era difficile sbagliare. Il ricco figlio del padrone di capre
chiedeva: «Il guerriero accetterà, per dare in moglie la bella figlia, tredici
capre pregne e tre cavalle o invece riterrà offensiva l'offerta e vorrà
spaccarmi il cuore innamorato con una pietra levigata?». Era difficile
sbagliare: «Chi non tenta non rischia. Chi non tenta non ottiene».
Di un re è stato dimenticato il nome, le domande non sono state dimenticate. «Se muoverò guerra nella stagione del risveglio ai barbari di settentrione, vincerò o perderò la vita?». Un sacerdote rispose: «In primavera a giorni il sole splende, a giorni piove». «Se muoverò guerra in estate vincerò o morirò?». «Ogni volta che il re guida gli uomini alla guerra per tornare carico di preda, rischia la vita. Rischia in misura maggiore il re imbelle che manda all'assalto i guerrieri e guarda dall'alto di un colle». «Chi può impedirmi di spaccarti il cuore per sentire se sa darmi risposta certa?». «Nessuno può impedirtelo». «A che serve un uomo che non si arma per difendere la vita?». «Nessuno può decifrare il disegno». «A che servono le tue parole?».
«Se combatterai difendendo la vita, il tuo braccio sarà forte, l'anima del
lupo ti abiterà. Se pensando d'essere vincitore non baderai alle spalle i tuoi
figli forse ricorderanno il tuo nome e forse ti vendicheranno». Era difficile
sbagliare. Ognuno era pagato o pagava per la qualità dell'oracolo.
Il disegno e il moto delle stelle parola del creatore ignoto, decifrarla
massima sapienza. Solo strumento il numero. Il numero, sacro.
Ogni notte qualcuno leggeva la parola del creatore, all'alba comunicava i
nomi delle sillabe luminose e le distanze all'assemblea che in coro ripeteva
sillabe e misure. Cantando danzavamo.
Da settentrione calarono i barbari che avevano parole di certezza: Rg era
dio. Dovevamo obbedire a Rg o morire. Rg era il loro capo. Era un gigante nero
di pelle, capelli rossi e occhi di fuoco, un fanatico uccisore incapace di
contare fino a tre e di mettere in fila più di dieci parole. Giunse e aprimmo le
porte dell'assemblea, sorridemmo, lo chiamammo Rg il potente, dio degli dèi, ci
prostrammo, gli lavammo i piedi. Scoprimmo che il nero era fango spalmato sulla
pelle, pittura di guerra, come il rosso dei capelli e del volto. N'a la bella
danzò sul ventre del dio antiche danze d'amore, cantavamo.
Offrimmo un banchetto, capre, meloni e un vino colore d'oro vecchio. Rg beveva
in proporzione alla statura e al numero di cosce di capra che divorava a morsi
feroci. Ingoiava quasi senza masticare bocconi che avrebbero soffocato un bue,
circondato dall'ammirazione dei fedeli che anche per tanta voracità lo credevano
dio. Versammo nella decima coppa tre gocce di succo d'erba rossa. Morendo dodici
ore dopo avvelenato Rg dimostrò di essere, per quanto dio, molto meno duraturo
del nostro creatore ignoto e immortale. Fuggimmo con cento cammelli bianchi
verso la costa. Comprammo una nave dagli uomini del mare. Pagammo in oro e
cammelli stanchi. Soltanto il mare che non conoscevamo poteva proteggerci, i
barbari di settentrione lo temevano. Gli uomini del mare ci catturarono, ci
strinsero polsi e caviglie e ci legarono tutti assieme con una sola corda nel
ventre della nave per venderci come schiavi. Uomini e donne arrivavano al porto
da città assalite e depredate, dicevano che era apparso e avanzava verso il mare
Gr, un dio spaventoso che guidava turbe di armati, elevava torri di teste di
uccisi e torturava i non uccisi chiedendo notizie dei sacerdoti danzatori
lettori del cielo, uccisori del padre. Gli uomini del mare temettero di lasciare
la testa ai vermi. Partimmo subito. Il mare era cattivo
Dopo tre giorni e tre notti di mare tumultuoso, paura e maldiventre, S'u la
giovane sfilò gli esili polsi dalla stretta della corda, con abili mani liberò i
piedi, trovò e impugnò un'ascia dalla doppia mezzaluna di pietra affilata. Una
macchia di luce annunciò il nemico. Un uomo scese barcollando. Veniva a
controllare le condizioni del carico o a prendere un vaso d'olive, un'anfora di
vino o sconvolto come noi dalla violenza delle onde cercava riparo nel ventre
della nave o pensava di violare un sacerdote, calpestando leggi sacre e sfidando
la furia del mare e l'odore intollerabile del vomito di cento?
Prima che il nemico riuscisse a abituare gli occhi all'oscurità l'ascia calò e
gli divise il cranio in due parti uguali. La nave saltava, volava, ricadeva,
batteva sul mare ora con la punta ora con la coda, ci scagliava sulle pareti, ci
lanciava uno contro l'altro. S'u recise la corda e ci affacciammo alla luce. Gli
uomini del mare avevano calato la vela. Si tenevano abbracciati all'albero.
Volando, saltando, in equilibrio precario ci gettammo addosso al nemico. Eccetto
S'u e la sua ascia eravamo privi d'armi, avevamo unghie e denti. Molti furono
uccisi dal nemico. Molti finirono in mare. Quando più nessuno combatteva la
tempesta si placò e vedemmo attorno alla nave uomini interi e braccia, gambe,
viscere, cervelli. Galleggiavano. Udimmo urla fino a notte.
Venne il silenzio e scoprimmo che la nave era nostra. Gli uomini del mare
giacevano sul ponte a bagno nel sangue mescolato all'acqua salata. Nessuno di
noi aveva mai navigato, nessuno aveva mai combattuto, prima di quel giorno.
Gettammo a mare i cadaveri.
Al centro del ponte una catasta di casse legate all'albero. S'u con l'ascia tagliò le corde. Aprimmo le casse. Erano piene di gioielli. Nessuno aveva mai visto niente di simile né mai ne aveva sentito parlare. Collari di pietra verde con appese rose d'oro e foglie di pietra nera e spine di pietra rossa come sangue. Serpenti d'argento con occhi di pietre azzurre e scaglie di pietre verdi. S'u disse: «Mi piacerebbe chiedere agli artigiani di questi tesori due cerchi d'oro da cui pendano undici minuscole stelle di pietra nera, due cerchi da infilare nei lobi delle orecchie». M'u il saggio commentò: «Sei abile, coraggiosa, ma vuota: a che servono i tuoi cerchi?».
Per tre giorni un vento forte e continuo ci spinse verso settentrione, ora a
oriente ora a occidente. Attorno soltanto mare. Cercammo di imparare a governare
la nave con la vela e la barra di legno usate dagli uomini del mare. La vela
prendeva poco vento comunque la movessimo e la barra di legno pareva dirigesse
la nave nella direzione opposta a quella desiderata. «Anche se imparassimo a
governare le manovre» disse M'u il saggio «che direzione sceglieremmo? Non
sappiamo dove siamo né dove andare». Rinunciammo a tentare di governare la nave.
Fummo preda di vento e correnti.
Il vento calò. La nave si fermò, il mare era immobile. Non sapendo che fare
guardammo M'u il saggio. Disse: «Preghiamo elencando le sillabe del creatore e
le loro distanze. Er, otto piedi celesti da Uh. Uh, sedici piedi celesti da Is.
Is, nove piedi celesti da Om. Om, nove piedi celesti da Is, da El, da Un, da Se,
da Af, da En, da Mi, da Uv, da Ja». Cantando danzavamo. Un fulmine squarciò il
cielo. Piovve d'improvviso, gocce pesanti, gelide, colpivano come pietre. La
nave ricominciò a volare e saltare. Ci afferrammo all'albero, tremammo,
vomitammo. Vedemmo le casse dei gioielli scivolare avanti e indietro sul ponte
sbattendo sulle basse murate. Il mare saltava come un tappeto di groppe di
cavalli imbizzarriti.
La nave volò, ricadde, il mare saltò sul ponte, afferrò S'u e la portò via. S'u in silenzio sparì fra le onde. Una donna cantò:
«S'u, giovane, bella e di coraggio, fresca di vita, l'astuta».
«Senza S'u saremmo ancora tutti legati là sotto, al sicuro» osservò M'u il
saggio. Lo guardammo. Pareva in punto di morte, stretto all'albero, livido,
esausto. Cominciò: «Era, otto piedi celesti da Uh». Il mare udì la preghiera e
si placò.
Le correnti furono dolci e nominando rurte le sillabe nominammo Le, stella
del mattino, prima stella della notte, favorevole alla fecondità e vedemmo le
scogliere rosse avvicinarsi. Nessuno di noi aveva mai governato un approdo. M'u
disse, nell'antica lingua: «M'ag o m'ad as». Così chiamammo quel luogo e il nome
rimase nei millenni fino a oggi. Il mare gettò la nave contro le rocce. Ventuno
volte, finché la ridusse in cento e cento pezzi. M'u il saggio scomparve fra le
onde, l'acqua gli consumò le ossa. Ventuno sopravvivemmo.
Eravamo gente alta e stando nell'isola siamo diventati piccoli perché tutto
trapiantato nelle isole di questo mare diventa più piccolo, più scuro, più
gustoso? O gente piccola già in origine?
Piccoli di statura, scuri di pelle, abituati a pensare, ragionare, contare, mai concordi fra noi. Così siamo tuttora, fatti salvi gli imbecilli che non mancano e nessuna legge potrà mai limitare.
«Il mare è infido» disse L'a scoprendo d'essere vivo sulla sabbia bianca di
una piccola spiaggia.
Esplorammo un tratto d'isola e scegliemmo per vivere un luogo che riuniva
molte buone cose: era esposto a oriente sulla costa d'occidente, accanto alla
montagna, dove avremmo potuto rifugiarci e difenderci in caso di nemici.
Nella montagna trovammo caverne, nelle caverne la pietra nera e cominciammo a levigare armi da taglio per noi e per i rari naviganti che accostavano e pagavano con tessuti morbidi e colorati di porpora. | << | < | > | >> |Pagina 15Ascoltai la storia il 12 agosto 1960 nella cucina di casa Setzu, a Morgongiori, fra le tre del pomeriggio e il tredicesimo rintocco di mezzanotte, quando Antonio pronunciò l'ultima parola.
Tacemmo come folgorati. La cucina era buia e il maestrale cantava turbinando
nei vicoli.
La moglie di Antonio chiese: «Perché hai accettato di ascoltare?». «Sono attratto dal passato, non so perché» risposi. «Credi in Dio?» chiese ancora. «No» risposi deciso. «No». «Chi ha creato l'universo?» domandò. «E eterno e increato» risposi.
La donna prese dal camino spento un rametto secco, lo accese, lo lasciò
bruciare, soffiò spegnendo la fiamma, tracciò in aria una croce con la punta
rossa di carbone e disse: «Non sai quel che dici, ti benedico, non ti uccidano
ferro, piombo o veleno».
Avevo otto anni, non sapevo nulla della vita, avevo ascoltato la storia, non l'avevo capita, anche ora che la dico non so che senso abbia. Non conoscevo il significato delle parole eterno e increato (forse lo intuivo con vaghezza) rubate a conversazioni famigliari, mi gloriavo di essere ateo. Nell'isola era sinonimo di bandito, a otto anni ero abituato a essere guardato con sospetto, con diffidenza, con paura — molto tempo dopo, scoprendo di essere di stirpe ebrea marrana, oltre che sarda e genovese con sfumature arabe e catalane, ho immaginato che il sangue degli antichi erranti perseguitati vivesse in me facendomi apparire la diversità dagli altri come abituale e perciò non spaventandomi della solitudine che ne veniva, di rado mitigata da amici sempre esclusi dalla comunità perché diversi: scemi, figli di donne non sposate e di bagassa, istrangios e eversori. | << | < | > | >> |Pagina 92Roma diventò memoria che lievitando in menti barbare cominciò a forgiare Europa, disse Antonio Setzu.
Ci trovammo liberi in un mare di predoni.
I corsi, figli dell'incrocio fra etruschi e goti, ebbero una flotta di
paranze e jabecos che faceva contrabbando e pirateria su tutte le coste
dell'alto mediterraneo. Una banda di pirati corsi, comandata da Urtimorio,
famoso per la ferocia, occupò Pausania, porto romano abbandonato nel
settentrione della Sardegna, lo chiamò Torres e ne fece la tana dove riparare
dopo agguati, rapine e omicidi al largo. Per molti anni la pirateria fruttò e
Susorio, figlio di Urtimorio, guidò una banda di pirati ricchi e potenti alla
conquista delle rovine di Genua, più volte nei secoli precedenti distrutta e
saccheggiata dai barbari, abitata da una umanità selvatica e cenciosa. Susorio
conquistò e rifondò Genua facendone una repubblica di marinai rapinatori.
Gli etruschi vivevano da mille anni nella parte orientale di settentrione,
la Gaddura. Imitarono i cugini corsi, si diedero alla pirateria, costruirono un
porto dove nascondersi dopo le scorrerie e lo chiamarono Longone.
L'antica Mu rinata col nome di Bosa fu il primo porto delle genti dei
giudici, oltre che l'unico isolano non in mare aperto ma lungo la foce di un
fiume, il Timur. Gli uomini di Bosa segnarono un confine con pali e pietre fra
monte Arvinu e monte Kera, così che le quattro sorgenti del Timur fossero nella
terra dei giudici. La gente di Torres accettò quel confine. Le navi dirette a
Bosa, tolonesi, genovesi, catalane, erano risparmiate dai pirati di Torres e di
Longone. Fra le terre dei sardi e le terre degli etruschi di Gaddura non c'era
confine segnato, vivevamo come fratelli.
In giorno di mercato un episcopo senza scorta entrò a piedi dalla porta di Arbaré. Nessuno lo notò. La porta era aperta notte e giorno. Non c'erano guardie. L'episcopo si fermò davanti a un venditore di sizigorrus che aveva le ceste sulle scale della cattedrale e chiese: «Dov'è il giudice?». Il venditore indicò una casa di fango dipinta di bianco uguale a tutte le altre, in un vicolo di tufo fangoso uguale a tutti gli altri. L'episcopo era scalzo, non ebbe alcun timore di infangarsi i piedi. Raggiunse la casa del giudice e superò la soglia priva di porta. Nella penombra una lama di luce polverosa scendeva da una feritoia al centro del tetto e illuminava una stuoia stesa a terra. L'episcopo chiamò: «Giudice?». Nessuno rispose. L'episcopo uscì in strada, vide una donna passare e chiese: «Dov'è il giudice?». «Attorno...» rispose la donna e si allontanò. L'episcopo sedette sulla soglia di casa del giudice Guantinu e guardò il passare di uomini, donne, galline sventate, bambini che urlavano correndo, mercanti e mercantesse che gridavano: «Picconi e pale a buon mercato» o «Limoni, i più sugosi di Arbaré, limoni» o «Il vino mio ha vent'anni, è nero come sputo di seppia e forte come galoppo di cavallo». L'episcopo vide vecchie ridenti avvolte in panni neri camminare veloci come frecce lungo i muri. Al centro della via su cavalli magri e scattanti costretti al passo vide cavalieri dai volti coperti di barba nera che lasciava liberi solo gli occhi e il naso. Gli occhi erano fessure scintillanti fra palpebre socchiuse. Al tramonto un cavaliere si fermò davanti all'episcopo che pregava col viso basso sulle mani giunte. L'episcopo sollevò la testa e vide una barba nera e due occhi socchiusi non diversi da quelli di tutti gli altri cavalieri passati nel vicolo durante la lunga giornata, poi notò la mano destra che offriva una bisaccia. L'episcopo si alzò, prese la bisaccia e frugò incuriosito mentre il cavaliere si allontanava. La bisaccia era di pelle di pecora rossa e conteneva un pane farcito d'uva cotta, un pane farcito d'anguille, un pane farcito di capra, tre piccole zucche piene di vino di Riola invecchiato vent'anni e una zucca grande piena d'acqua fresca. L'episcopo sedette sulla soglia e cominciò a mangiare. Diede un morso al pane di uva cotta, masticò, "gusto celestiale" pensò e vide una donna vecchia e gobba che sussurrando strane parole in una lingua sconosciuta gli si avvicinava veloce. La vecchia aveva lunghi capelli bianchi raccolti in cento trecce e continuando a biascicare chissà cosa si piantò davanti all'episcopo e gli diede una torcia di grasso, accesa. L'episcopo prese la torcia, la donna per un attimo smise di brontolare e lo guardò con un mezzo sorriso che pareva soddisfatto, poi urlando come una gatta cui pestino la zampa e con larghi gesti esplicativi delle mani e delle braccia fece comprendere all'episcopo che doveva alzarsi. Lui, sorpreso, obbedì e appena in piedi fu spinto dentro casa dalla vecchia, dotata di molta più forza di quanto l'aspetto permettesse di sospettare o immaginare. L'episcopo entrò nella casa pensando che la vecchia fosse moglie del giudice, che immaginò vecchio. La donna con la punta delle dita staccò dalla torcia un pezzo di grasso acceso e lo gettò al centro della casa, su un ammasso di erbe, legna e carboni che cominciò a fumare e sfrigolare. La vecchia uscì dalla casa, si fermò davanti alla soglia, srotolò una pelle di vacca che aveva il collo inchiodato allo stipite di legno, sparì. L'episcopo ne intuì la presenza perché vide la pelle che dall'esterno veniva sistemata con cura affinché non restassero spiragli o varchi. Pensò che la migliore cosa da fare in casa altrui fosse rispettare la volontà degli ospitanti, per quanto potesse apparire sconsiderato avere un fuoco acceso e la casa chiusa a quell'ora, in quella stagione. Si aggirò con la torcia accesa e vide la stuoia notata al mattino. Il grasso della torcia si esaurì e al buio l'episcopo sedette sulla stuoia, mangiò il pane con l'uva e bevve da una zucca di vino. Si sdraiò. Aveva camminato per tre giorni, a piedi scalzi. Era stanco. Si addormentò. All'alba si svegliò perché la lama di luce dall'alto gli illuminava gli occhi, sbatté le palpebre e vide accanto al giaciglio il pane con le anguille e il pane con la capra. Vide la zucca dell'acqua. Mangiò di buon appetito, bevve con gusto. Scorse più lontano una brocca, si levò, la raggiunse, la scosse, sentì che conteneva un liquido. Assaggiò. Era latte di vacca fresco mielato. L'episcopo bevve a lungo, andò verso la soglia, arrotolò la pelle che faceva da porta, la legò allo stipite, sedette faccia al vicolo. Le ore, le visioni, le voci, la sacca e i viveri consegnati in silenzio dal cavaliere sconosciuto furono identici a quelli del giorno prima. La vecchia al tramonto con suoni gutturali, alti lamenti e un gesticolare forsennato costrinse l'episcopo a finire di bere tutto il contenuto della brocca di latte. Si allontanò con la brocca vuota e tornò con la brocca piena. Chiuse la porta con la pelle di vacca e sparì. L'episcopo addentò il pane all'uva, masticò, "è migliore di quello di ieri" pensò e bevve da una zucca di vino di Riola. Il terzo giorno l'episcopo bevve tutto il latte mielato della brocca prima dell'arrivo della vecchia e fu l'unica differenza dal giorno prima. A mezzo mattino del quarto giorno l'episcopo trattò con un mercante di passaggio l'acquisto di quattro paia di ragas. Le pagò tre volte il prezzo. Il mercante di panni veniva da Seu, come tutti i mercanti sardi di qualunque mercanzia. L'episcopo entrò in casa, abbassò la tenda di pelle, levò la tonaca sporca che aveva da sette giorni e lo faceva simile nell'aspetto a uno schiavo di Karale, infilò un paio di ragas. Sedette sulla soglia con le gambe bianche e il petto bianchissimo. Al tramonto rabbrividì. La vecchia comparve e senza dire una parola posò davanti all'episcopo un corpetto pulito di canapa, una giacca di pecora e sparì. L'episcopo indossò il corpetto. Vide apparire un cavaliere. Uno dei tanti dalla maschera di barba sul viso e dagli occhi socchiusi. Dal nulla sorse la vecchia, corse incontro al cavallo, saltò con agilità inimmaginabile in groppa dietro il cavaliere, lo cinse al fianco e cominciò a berciare in un idioma che all'episcopo parve barbaro e incomprensibile, miscela di strilli di cornacchie, gazze e corvi furenti. La vecchia indicava l'episcopo col dito puntato. | << | < | > | >> |Pagina 100Il giudice Barisone fu bizzarro, viaggiatore e falsario.Rendeva giustizia seduto, con le spalle poggiate al muro della fonte, nel palazzo dei giudici di Arbaré, mentre le donne andavano e venivano in silenzio con le brocche.
Ascoltando i querelanti Barisone masticava i fiori di un'erba chiamata kif,
i semi gli erano stati donati da un moru che aveva messo al sacco Karale, aveva
attraversato al galoppo il Campidano con mille guerrieri e s'era fermato sotto
le mura di Arbaré a riposare prima di ripercorrere in direzione opposta la
strada percorsa. Barisone aveva piantato i semi e pareva soddisfatto dei
raccolti. Il moru gli aveva anche donato un gioco, chiamato shah, cui da allora
i giudici furono fedeli.
Un uomo si presentò al giudice e disse: «Ho un gregge di mia proprietà nelle terre di Seu e mia moglie mi impedisce di mungere le pecore». «Chi munge le pecore?» chiese Barisone. «Mia moglie». «Mandala da me, le dirò la mia decisione». Sette giorni dopo Barisone giocava una partita a shah e per la prima volta nella vita credeva di avere la possibilità di battere Itzoccor che aveva sbagliato mossa per eccesso di fiducia nella propria abilità. Apparve una donna e urlò: «Dov'è il giudice? Mi ha mandato a chiamare? Mio marito dice che il giudice deve punirmi. E per cosa deve punirmi?». Itzoccor impose la patta (Itzoccor, bianco: e4, Cc3, Cf3, Fc4, Cg5, Fxf7, Dxg4, Cd5+, Fe6+, Ff7+, Fe6+, Ff7+; Barisone: e5, Cf6, Cf6, d6, Fg4, Re7, Cxg4, Rd7, Re8, Rd7, Re8, Rd7). Barisone si voltò verso la donna e chiese: «Perché non permetti che tuo marito munga le pecore?». «Le vizia». «Come le vizia?». «A uso di donne. E le pecore credendosi donne danno meno latte». «Tuo marito non ti vizia?». «Quel perdigiorno? Meno lo vedo meglio è». «Se decidessi di fare castrare tuo marito perché non infastidisca più le pecore, che diresti?». «Gli starebbe bene. Ma non chiedo questo». «Cosa chiedi?». «Non voglio che disturbi le pecore».
«Torna da lui e digli di stare lontano dalle pecore. È un decreto del
giudice. Se toccherà le pecore sarà castrato. Tu, donna, sei responsabile del
futuro di tuo marito. Se tornerai da me sai quel che farò».
Barisone dormiva accanto alla fonte, le donne sussurravano piano per non svegliarlo. Arrivarono a Arbaré due vecchi a dorso di mulo. lasciarono i muli fuori da una delle otto porte del palazzo e entrarono. Videro il giudice che dormiva. Gli sedettero accanto e lo guardarono. Barisone aprì gli occhi e vide le facce dei vecchi, identiche. Sembrava lo stesso uomo nello stesso abito, doppio. Barisone guardò a destra e a sinistra per controllare non ci fosse un doppio Barisone. Le giovani con le brocche furono colte da riso e fuggirono quasi danzando. Constatato d'essere l'unico Barisone, il giudice osservò i due e notò la dissomiglianza: uno dei vecchi guardava con un occhio solo, il secondo occhio era invisibile sotto palpebre cucite. «Che volete?» chiese il giudice sedendo spalle alla fonte. «Giustizia!» risposero i due in coro. «Parlate uno per volta, per favore». Battibeccarono in un dialetto orientale stretto e veloce, incomprensibile al giudice, parlando sempre nello stesso momento, in coro o dissonanza e agitando le braccia in ogni sorta di gesti esplicativi. Barisone li fermò con un «Eh» a voce molto alta, come si fa coi buoi. I due tacquero. «Parlate insieme» disse il giudice. Ricominciarono i cori discordi, il giudice non riusciva a capire una parola. Fermò i due con un «Eh» che avrebbe impietrito un branco di cavalli selvatici e chiese se capivano la lingua di Arbaré. Annuirono. «Potete parlare nella lingua di Arbaré?» chiese il giudice. Annuirono. «Se lo farete ve ne sarò grato». Parlarono nella lingua di Arbaré, con velocità doppia del normale e con un ritmo a cantilena che slegava una sillaba dall'altra o univa gruppi di sillabe in una sola indistinta esclamazione modulata che echeggiava rumori di pollaio e di gregge, col risultato di un coro incomprensibile di dissonanze. Barisone non riusciva a capire neppure una sillaba. Si alzò. I due tacquero. «Aspetterete seduti in questo posto fino al mio ritorno». Annuirono. Barisone uscì, si sdraiò nel giardino e si addormentò. Lo svegliò un'ora dopo Itzoccor reduce da una delle sue cavalcate. Quando tutti i cristiani ammazzati dal sole d'estate dormivano all'ombra degli alberi, Itzoccor, nudo eccetto le ragas, cavalcava per valli e monti. Si accostava a ogni fonte per abbeverare il cavallo sperando di trovare una giovane al bagno. Capitava che qualche giovane dei villaggi o di Arbaré sparisse di casa nel russare generale e si spingesse, veloce, nascosta, sola, a bagnarsi alle fonti. Le giovani speravano di vedere comparire Itzoccor. Se chiedevi a una giovane: «Sei stata alle fonti?» rispondeva che no, altre ci andavano. Se chiedevi: «Coiuvan?» la giovane rispondeva: «Jogan». Se chiedevi: «Ma perché queste giovani jogan con Itzoccor?» la giovane rispondeva: «Dicono ch'è cortese di modi e buono d'animo». Pare fossero anche altri i pregi di Itzoccor, ma nessuna giovane mai avrebbe ammesso con un maschio di esserne a conoscenza. Li sussurravano negli angolini bui, fra femmine, con risa soffocate. Itzoccor svegliò Barisone: «Perché dormi fuori?».
«Dentro ci sono due uomini seduti. Vai. Prendine uno e portalo in taverna.
Ordina che gli diano da mangiare e da bere».
Itzoccor usci dal palazzo portandosi in spalla, some fosse agnello appena
nato, un vecchio muto e tremante.
Barisone sedette spalle alla fonte e guardò il secondo vecchio: tremava. Barisone tacque e guardò il vecchio con espressione bonaria finché quello smise di tremare. Il giudice sorrise e disse: «Tuo fratello è al sicuro. Mangia e beve. Ora puoi dirmi che volete». «Mi accusa di avergli cavato l'occhio». «E vero?». «Sì. Ma non con gesto teso a fare il male. Non riuscivo a governare Tumenda, Tumenda ha scalciato e l'ha colpito al viso cavandogli l'occhio». «Perché non ti perdona?». «Dice che ho tentato di ucciderlo per godermi da solo l'eredità del babbo». «Quanti anni avete?». «Più di cento». «E quanto ancora pensate di potere vivere?». «Quando il fatto accadde avevamo diciotto anni». «Da allora discutete di questa storia?». «Tutti i giorni». «Qual è l'eredità?». «Dieci monete d'oro. Le conserviamo in luogo ben nascosto dal giorno che morì nostro padre, avevamo sei anni». «Che sarà delle monete dopo la vostra morte?». «Non importa». «Ti farai cavare un occhio da tuo fratello, appena sarete a casa. Sei d'accordo?». «Gliel'ho già offerto, giudice». «Tuo fratello che ha detto?». «Di essere migliore di me». «Raggiungilo alla taverna. Digli che se non ti caverà l'occhio l'ira del giudice sarà fredda e veloce come il maestrale nel mese della neve». | << | < | > | >> |Pagina 128Nell'anno 1302, dicendosi proprietario dell'isola in virtù della donazione di Costantino (che sapeva falsa) l'episcopo di Roma all'insaputa dei giudici aveva donato la Sardegna ai sovrani di Aragona dietro versamento privato e occulto di settecento fiorini d'oro. L'episcopo di Roma aveva assicurato una conquista facile, pacifica, aveva promesso sardi plaudenti. Il sovrano d'Aragona aveva atteso quarant'anni che gli ultimi giudici morissero. Temendo che Mariano secondo avesse a sua volta figli, Mariani terzi e quarti magari prolifici e rimandanti alle calende l'uso del dono papale, il sovrano chiese indietro i fiorini versati. L'episcopo di Roma invitò allo sbarco nella terra di conquista, giurò che l'isola non avrebbe opposto resistenza, promise rapida morte del giudice Mariano.
Gli aragonesi sbarcarono a settentrione e costruirono la città fortificata
dell'Alguer. Poi con dodici caravelle assediarono Karale che dopo tre ore si
arrese. Aragona approdava e i pisani con una affrettata resa dei conti
lasciavano trentotto morti e centosessantaquattro feriti nei vicoli della rocca
a sanguinare per lo stupore dei conquistadores. Gli aragonesi entravano nella
rocca dalla porta del maiale, sette famiglie pisane uscivano da quella del
leone, al galoppo sfrenato verso la piana. Avevano lasciato molti pugnali fra le
costole dei trentotto uccisi. Temevano vendette. Li guidava Barnaba Pisano, uomo
rude, violento, vendicativo e di anima libera, insofferente del dominio altrui
su di sé. L'idea di doversi trasformare in suddito e cortigiano di un qualunque
don Jaime d'Aragona lo faceva diventare furioso. Aveva lasciato Pisa per lo
stesso motivo: troppi potenti desiderosi d'ossequio. A Karale aveva combattuto e
ucciso per non chinare il capo al passaggio di alcuno. Guidò quarantasette
uomini e donne al galoppo nella piana, fino a Arbaré. Sanguinava dalla spalla
destra. Alle mura scese da cavallo, ordinò ai suoi di attendere con pazienza,
lasciò sull'erba spade e pugnali, oltrepassò la soglia della città e a un
bambino che giocava chiese di parlare col giudice.
«Mi hanno detto che governi la terra degli uomini liberi» disse Barnaba. «Non governo. Giudico. Accompagno» rispose Mariano e aggiunse: «Mi hanno detto che la tua spada ha memoria di sangue d'uomo, di donna, di bambino». «Nemici, giudice. Nemici giurati. Uomini, donne e bambini che trovandomi indifeso nel sonno mi avrebbero soffocato con le coltri, avendomi ospite a una mensa mi avrebbero avvelenato, trovandomi ferito in un fosso mi avrebbero finito». Barnaba parlava con Mariano ma controllava con la coda dell'occhio ogni respiro di Martina e disse: «Tua sorella, giudice, vuole uccidermi. Dille di non farlo». Mariano fece un cenno con la mano. Martina sedette.
Il giudice concesse a Barnaba Pisano due colline e la valle che le divideva,
nelle terre ch'erano state di Torres. Barnaba in cambio si impegnò a controllare
i movimenti della gente dell'Alguer. Sulla collina più alta del nuovo
insediamento i pisani costruirono un castello di pietra nera imprendibile da
qualsiasi banda di predoni, fosse pure il popolo intero in armi dell'Alguer.
|