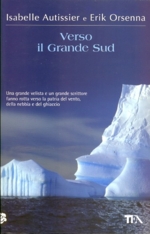
|
|
|
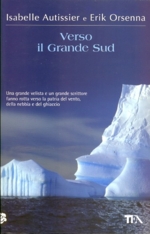
|
|
|
| << | < | > | >> |Indice
Diario di Isabelle. Perché l'Antartide? 7
Diario di Erik. Perché l'Antartide? 10
PRIMA PARTE - Dove inizia il Grande Sud?
1. Rio Gallegos 15
2. Ushuaia 17
3. Puerto Williams 26
4. Diario di Isabelle. Una barca, un equipaggio 30
5. Vocabolario 37
6. Il Drake 38
7. Diario di Isabelle. Autonomia 43
8. Frontiere di vento. Conversazione con Pierre Lasnier 46
9. Frontiere d'acqua I: La convergenza 51
10. Frontiere d'acqua II: La corrente circumpolare 54
11. Il segnale degli uccelli, l'eco dei fantasmi 59
12. Diario di Erik. Evviva la comunità internazionale! 65
SECONDA PARTE - Mare di Weddell
1. Il popolo degli iceberg 74
2. Bahia Esperanza 79
3. Nordenskjöld 82
4. Diario di Erik. Ritratto della paura 90
5. Animali I 92
TERZA PARTE - Le Shetland del Sud
1. L'isola dell'Elefante 102
2. Inganno 111
3. L'ormeggio introvabile 119
4. Melchiorre 123
5. Diario di Isabelle. Tempo di burrasca 125
6. Animali II 128
QUARTA PARTE - La penisola antartica
1. Turismo australe 134
2. Poney tailed girl I 139
3. Isola di D. 141
4. Diario di Erik. Che cos'è un marinaio? 142
5. Sulle tracce di un grande fantasma 144
6. Charcot, di nuovo, e un'altra poney tailed girl 154
7. Base Vernadsky 157
8. Marea 164
9. Botanica 165
10. Diario di Erik. Perché l'Antartide? (seguito) 168
11. Cartografare, nominare 170
12. Diario di Isabelle. Ormeggi antartici (seguito) 172
13. Verso la baia Margherita 175
Ritorno
1. Diario di Erik. Breve cronaca di un Drake ordinario 184
2. Puerto Toro 193
3. L'occhio di Tolosa 195
Bibliografia 199
|
| << | < | > | >> |Pagina 7Sopra il mio letto di bambina era appesa, e vi rimase a lungo, una carta dell'Atlantico nel formato detto «grand aigle», la taglia massima. Nella sua parte inferiore, la più vicina al mio sguardo, correva la linea sinuosa di una terra: l'Antartide. Quella linea era però ben lontana dall'essere oggetto delle mie fantasticherie. Ero molto più attratta dalle isole sperdute che emergevano dalla dorsale oceanica. Sant'Elena, Ascensione, Tristan da Cunha, e naturalmente capo Horn. Molto tempo dopo, un temibile incontro sollecitò la mia immaginazione. Era una limpida mattina nei Quaranta ruggenti. Per una volta la navigazione seguiva tranquillamente il suo corso, senza problemi, senza tempeste. Manovravo distrattamente il timone quando una massa scura all'orizzonte attirò il mio sguardo. Un'isola? Qui? Impossibile. Mi trovavo a nord dell'arcipelago delle Kerguelen, in un punto dell'oceano dove per migliaia di miglia nulla interrompe la superficie delle acque. Lanciai un'occhiata alla carta, presi il binocolo, per qualche secondo provai la vertigine di chiedermi se davvero ero dove pensavo di essere... Si trattava di un iceberg, immenso e solitario. Un colossale blocco di ghiaccio giunto davanti a me dopo mesi, forse anni, di deriva. Lo costeggiai a rispettosa distanza. Misurava più di un chilometro, e il sole pallido sembrava giocare sulle sue superfici ora grigie, ora bluastre, ora scintillanti di luce. Il mare gorgogliava ai suoi piedi. Era lì, quel blocco di ghiaccio, impassibile e condannato a morire. Da lui emanava una grande bellezza mescolata a una strana malinconia. Quella mattina mi resi conto che qualcosa viveva, lontano a sud, oltre la barriera dei Quaranta e dei Cinquanta, che pure a me sembrava già la fine del mondo. Quella terra, capace di produrre un oggetto così contraddittorio, culmine di forza e fragilità, mi sembrò possedere una misteriosa potenza. In principio, dunque, vi fu un'emozione. Un'emozione che non mi ha più lasciata. Poco dopo, sempre al timone, rievocai tutti i miei ricordi, le letture da adolescente, i racconti di incredibili avventure e di eroismi insensati, ma anche di stupefatta meraviglia. Sembrava che chiunque avesse frequentato l'Antartide fosse stato costretto a trovare una dimensione extraterrestre alla propria esistenza, per entrare in sintonia con quell'universo di superlativi. Tornata a terra, mi sprofondai tra i libri per vederci chiaro. Mi fecero scoprire tre cose. Risalendo alla radice dell'emozione che avevo provato davanti al mio primo iceberg stavo per immergermi, secondo tutte le testimonianze, in un mondo di straordinaria bellezza e grandezza; un mondo, tuttavia, nel quale ogni secondo andava conquistato. I Quaranta ruggenti, dei quali avevo già sperimentato le pene e le esaltazioni, altro non erano che una blanda introduzione, una sorta di scuola elementare, se paragonati all'Antartide, ardua come un esame di maturità d'altri tempi. Quel continente era così estremo da non poter essere semplicemente paragonato agli avvenimenti ordinari. Laggiù, avevano luogo fenomeni del tutto nuovi, gli esseri viventi sviluppavano strategie diverse, e la scienza si confrontava con questioni ancora mai formulate. Tutto ciò non fece che stuzzicare la mia curiosità. E dato che ogni cosa giunge a suo tempo, ho trascorso altri dieci anni sul ponte di una barca a vela d'altura prima che mi si presentasse l'occasione di una spedizione antartica. Nel gennaio del 2002 sbarcai sul pontile dell'Afasyn Yacht Club di Ushuaia per trovarvi una svedese, un'inglese, una canadese e altre due francesi, le mie compagne di viaggio, ma anche per fare la conoscenza di una barca, l' Ada, e, poco dopo, dell'Antartide. Quell'anno fu tempestoso, grigio, ventoso, e i ghiacci abbondavano, ma la nostra squadra al femminile se la cavò onorevolmente. Quando i sessanta nodi di vento catabatico ci regalavano una bella nevicata orizzontale noi, saggiamente, rinforzavamo gli ormeggi e restavamo in attesa, ammazzando il tempo con whisky e partite a carte. Nei momenti migliori, invece, vagabondavamo aprendoci la strada tra i frammenti di ghiaccio con il dritto di prua, e cercando di comprendere di cosa fosse fatto quell'universo; eravamo sempre in attesa, e sempre stupite. Ognuna di noi ebbe, in quell'occasione, la sua illuminazione, e anche se curiosamente esse furono tutte diverse l'una dall'altra provammo comunque, per brevi momenti, la sensazione di pulsare all'unisono con una natura immemore, e la consapevolezza che il cuore della vita si mostra a coloro che sanno andare oltre le sue più grossolane apparenze. Quelle settimane ebbero, per me, il gusto di una pietanza appena assaporata. Com'era possibile consacrare così pochi giorni a ciò che mi sembrava un intero universo? L'Antartide non è un capriccio passeggero, il frammento di uno zapping: per coglierne le leggi è necessaria la lentezza, e tutto ciò non faceva che spingermi a ritornarvi. Desideravo però arricchire il mio sguardo con quello di altri. Dovevo rivolgermi alla scienza, l'unica in grado di decifrare questo reale così stupefacente. Eppure, mi sembrava che l'Antartide potesse anche essere cantata, danzata, filmata, scritta, dipinta, messa in scena. Sognavo, insomma, una specie di arca nella quale imbarcare ogni genere di curiosi, e dove le arti si unissero alla scienza, perché l'uomo ha bisogno di entrambi i piedi per andare avanti e fare scoperte. Ma, se davvero volevo riuscire, era necessario semplificare le cose. Bisognava agire e dar vita a un progetto, per quanto piccolo, non limitarsi più solo a sognare. Comprai dunque l' Ada non appena mi fu possibile: mi mancavano ora solo dei buoni compagni, capaci di condividere la mia utopia. Erik fu il primo. | << | < | > | >> |Pagina 10Ricordo che mio padre raccontava una storia di scienziati assai singolari, che avevano deciso di attraversare i ghiacci australi per... trovare uova di pinguino imperatore. Intendevano infatti dimostrare che esiste una relazione tra le squame dei rettili e le penne degli uccelli! Ascoltando questa storia mi dicevo che anch'io, da grande, avrei affrontato ogni sorta di pericoli per spiegare il mondo. In seguito, ho ritrovato traccia di quei valorosi. Il capo della missione, Cherry-Garrard, ha raccontato del loro spaventevole viaggio invernale nel 1911: centocinque chilometri di andata in sei settimane di marcia (e di scalate) con un freddo che oltrepassava i sessanta gradi sotto zero. Erano riusciti a trovare sei uova, di cui tre erano poi finite in pezzi nel corso dei centocinque chilometri del ritorno... e non era comunque stato possibile trarre conclusioni definitive riguardo alla relazione tra squame e piume.
Il giudizio di Cherry-Garrard suonava netto, senza appello: «L'esplorazione
polare è la più radicale, e la più solitaria».
Ricordo una delle innumerevoli storie che raccontava mia madre. C'era una volta la ninfa Callisto, divinità dei boschi. Zeus, sempre vagabondo, la incontrò e l'amò. Nacque un bambino, Arcade. Era, la moglie di Zeus, per vendicarsi, trasformò in orsi entrambi, la madre Callisto e il figlio Arcade. Ed è così che in greco orso si dice arktos. Ma l'ira di Era non si placava e Zeus, temendo per la vita della sua ninfa e del loro piccolo, li spedì a cercare rifugio nel cielo. Da allora, essi ruotano intorno alla stella Polare: sono l'Orsa Maggiore e l'Orsa Minore.
Ecco perché l'Artide è patria degli orsi, mentre l'Antartide,
ante-arktos,
letteralmente l'«opposto dell'Artide», è anche la «terra senza orsi»: questi
animali, d'altronde, sono del tutto assenti dal continente.
Ero già stato, due volte, nella Terra del Fuoco. Sul Baltahazar, il solido sloop di Siv e Bertrand Dubois, avevo seguito con passione le tracce di Darwin lungo il canale Beagle, e sull'isola di Lennox mi ero intrattenuto a lungo con un cercatore d'oro. Poco tempo dopo, doppiando capo Horn sospinto dai quarantacinque nodi di una piacevole brezza da ovest, mi ero rivolto verso il Grande Sud, e mi ero chiesto: «Oserò mai, un giorno, andare ancora più giù? Oserò, un giorno, attraversare lo stretto?» Io non ho una natura temeraria, e mi spavento spesso più del dovuto. Ma soffro di una grave malattia: la curiosità. E questa curiosità l'ha sempre avuta vinta sulle mie paure. È lei, in combutta con il mio odio per i rimpianti, a spingermi ogni volta verso l'avventura. Penso sempre ai momenti che precederanno la mia morte. Già so che, negli ultimi istanti, mi chiederò: «L'ho dunque ben esplorata, questa Terra che ora devo lasciare?» È per questo che, quando Isabelle mi ha proposto: «Vuoi andare in Antartide?», la mia risposta era già pronta, sin dall'infanzia. | << | < | > | >> |Pagina 37Il capo Horn si è appena allontanato nella bruma che già Olivier, il nostro capitano di lungo corso, ci passa il testimone. Ha finito il suo turno. «A voi la cura!» Sin dalla partenza ci ha messo a parte della sua intenzione di rimettere in ordine il vocabolario di bordo. Invece di utilizzare il primo termine che ci passa per la testa, dovremmo impiegare le opportune espressioni marinaresche. In fondo, esse sono state forgiate dall'eleganza della tradizione, ma soprattutto per la necessità di trasmettere in fretta delle informazioni chiare. Così, quando si salpa l'ancora, si succedono ben cinque grida diverse: «Catena!» (Significa che rimangono immersi solo i ventisette metri di catena.) «A picco!» (La barca è a picco sull'ancora.) «Spedata!» (L'ancora si è staccata dal fondo.) «Alta e chiara!» (L'ancora risale senza incontrare ostacoli.) «A posto!» (L'ancora è tornata al suo posto sul ponte.)
Non ci resta altro da fare che
rizzarla.
Siamo nel mezzo della notte, soffia il vento, il mare è agitato. «A te la cura.» Esiste forse un modo più elegante per farvi comprendere che vi è stata affidata la (cura della) barca? | << | < | > | >> |Pagina 38Drake. Un nome che schiocca, un lampo, una fonetica dura e aggressiva. Drake, come drago o drakkar. Stretto di Drake. È quasi peggio. Quando eravamo bambini ci piaceva ripetere «tigre contro tigre», per giocare a farci paura con la magia di uno scioglilingua. Era perché non conoscevamo lo stretto di Drake, uno scioglilingua ben più pericoloso. È lì, davanti a noi, proprio oggi, il famoso passaggio tra capo Horn e la penisola antartica, e le letture che ci tenevano con il fiato sospeso nel tepore dei nostri focolari assumono ora un'inquietante aura di realtà. Cosa avrà mai in serbo, per noi, il cattivissimo Drake? A una latitudine di 56° sud navighiamo lungo la grande arteria delle depressioni atmosferiche; in media ce ne tocca una ogni tre giorni. Su una vasta distesa oceanica si potrebbe sperare di evitare le peggiori salendo o scendendo di latitudine. Ma qui le tempeste convergono nell'imbuto che separa la cordigliera delle Ande dalle montagne della penisola antartica, e in questo punto il mare non è più largo di mille chilometri. Per rendere il luogo ancora più ameno, quasi a voler sottolineare la sua terribile reputazione, i grandi venti occidentali, bloccati dalle montagne sudamericane, vengono deviati, prendono forza e sboccano nello stretto con la furia di un colosso cui abbiano sbarrato la strada. Quando invece le raffiche arrivano da sud, è peggio: provengono dal polo, e il loro alito è ghiacciato. Si dice che abbiano fatto piangere non pochi sbruffoni. Negli antichi velieri, che imboccavano lo stretto anche in pieno inverno per motivi di interesse, questi venti stendevano su alberi, pennoni e cordame, insomma sull'intera attrezzatura, una coltre di ghiaccio, e la nave rischiava di scuffiare sotto un tale peso, troppo alto rispetto al baricentro. Bisognava allora frantumare a colpi di ascia e scalpello il lenzuolo scintillante. Chi tentava di sfuggire a questi pericoli mantenendosi più a nord, cioè a ridosso di capo Horn, passava da Scilla a Cariddi. Infatti intorno alla costa il fondo marino risale praticamente in verticale, passando in poche miglia da quattromila a solo cinquanta metri di profondità. Incontrando questa specie di monte Bianco subdolamente sommerso, l'acqua si impenna come un cavallo che scarta l'ostacolo, e le onde si inarcano, si infrangono, liberando d'un tratto milioni di tonnellate d'acqua cariche di una potenza omicida. Sui pontili di Ushuaia si narrano tristi storie di scuffie, disalberamenti e ogni genere di capriola. Le onde si danno alla pazza gioia, e anche i più esperti tra gli skipper locali non si arrischiano ad affrontare il mare senza che ogni cosa sul ponte sia ben fissata, data volta o avvitata, e le vele antirollio al loro posto. Nelle settimane dedicate ai preparativi, l'angoscia di dimenticare qualche particolare ci teneva svegli la notte. Un dramma, in fondo, non è che il risultato dell'accumularsi di una serie di minuscoli dettagli nei quali, come è noto, si annida il demonio. La scelta del nome di Drake per questo stretto così difficile da attraversare è stata, senza dubbio, azzeccata, soprattutto se si pensa alla personalità e ai fatti d'arme di cui il terribile capitano fu protagonista. Ardito, scaltro, imperioso sino alla crudeltà, Francis Drake, il marinaio preferito di Elisabetta I d'Inghilterra, navigò nelle acque della Patagonia e riuscì ad attraversare lo stretto di Magellano al solo encomiabile scopo di razziare i porti peruviani situati duemila chilometri più a nord. La spedizione, camuffata da viaggio commerciale, non fu altro che una missione di rapina per conto del comandante e della sua regina. Malmenato dalle tempeste, il veliero di Drake, il Golden Hind, scese alla deriva sino alla latitudine di 56° sud, quindi già oltre il capo Horn, di cui senza dubbio furono intravisti gli isolotti. Ciò permise a Drake di formulare per primo l'ipotesi che la Terra del Fuoco fosse un'isola, sotto la quale, proprio là dove i geografi immaginavano si trovasse un prolungamento della loro mitica Terra Australis Incognita, non ci fosse altro che una vasta estensione marina. Ora però, dato che stiamo per avventurarci nei loro domini, rendiamo omaggio ai veri pionieri che riuscirono per primi ad attraversare in direzione ovest l'impossibile stretto: un mercante e un uomo di mare. La ricerca di quel passaggio ossessionava da tempo gli europei, che desideravano accorciare le rotte delle spezie, della seta, dell'oro, delle porcellane... Raggiungere nel modo più veloce le Indie o Cipango: era questa l'ambizione condivisa da Enrico il Navigatore, Colombo e Magellano. Spesso gli Stati, impantanati nelle loro guerre e nei loro intrighi, lasciavano mano libera a mercanti tanto avidi quanto audaci e intelligenti. Isaac Lemaire, onorevole commerciante di Amsterdam, era un uomo di quella razza, che pensò di accordarsi con il comandante Guillaume Schouten per tentare di scardinare il monopolio indiscusso della VOC sulla rotta delle Indie. Se lo stretto di Magellano e il capo di Buona Speranza erano punti di passaggio riservati alla Compagnia delle Indie, perché non cercare più a sud, nell'ancor poco conosciuta America meridionale, un'altra rotta? Fu così che il Confiance, una nave da trecentosessanta tonnellate e diciannove cannoni, fu il primo veliero europeo a trovarsi a tu per tu con il capo Horn, il 31 gennaio del 1616. Sospinti dall'ambizione, i due compari e i loro uomini affrontarono il freddo, le incrostazioni ghiacciate sull'attrezzatura e il maltempo. Non solo, essi riuscirono anche a non farsi troppo impressionare dalle storie di mostri scaturiti dagli abissi e di feroci giganti patagonici, sempre pronti a far la festa ai poveri marinai scesi a terra per rifornirsi d'acqua. E se anche riuscirono a estasiarsi, in quegli sperduti paraggi, del volo degli albatri e degli sbuffi delle balene, nei loro racconti ciò che si avverte è soprattutto il peso della paura. Paura, giorno dopo giorno. Paura al cospetto della selvaggia indifferenza del mare e delle rocce. È questa stessa emozione che attraverso i secoli risorge, intatta, nei nostri spiriti di moderni naviganti. Noi ci facciamo strada ben muniti di previsioni meteorologiche e di fotografie satellitari, eppure lo stretto di Drake continua a essere un vero pericolo. Esso è l'estremità più australe cui giungono le terre abitate, il punto di incontro dei due più grandi oceani, il luogo del mondo in cui si affrontano come nemici immense masse d'acqua e d'aria. Le une giungono dal caldo, ossia dai tropici, le altre dal polo, dall'impero del freddo. E la loro battaglia è provocata dall'altezza delle montagne andine e dal loro lontano prolungamento in Antartide. Qui l'uomo deve ritrovare l'umiltà e imparare, se vuole avere la possibilità di trovare la sua strada nella furia del mondo. Vergogna, dunque, allo spirito meschino della Compagnia delle Indie che, ben lungi dal celebrare la vittoriosa audacia dei suoi compatrioti, non seppe vedervi altro che un rischio di concorrenza, una scoperta che avrebbe potuto danneggiare la sua avidità insaziabile! Non appena giunti a Batavia dopo il loro viaggio, Schouten e Lemaire dovettero rispondere alla giustizia dell'accusa di aver inventato un passaggio inesistente per mascherare il loro scacco, e di aver attraversato senza permesso lo stretto di Magellano. La loro nave fu confiscata e al ritorno in Olanda, in catene, si dice che Lemaire morì di crepacuore. Le crudeltà degli uomini sono a volte di una specie assai più pericolosa di quelle dei Quaranta ruggenti. I due eroi furono quindi relegati ingiustamente nell'oblio della Storia, ma all'estremo capo del continente sudamericano rimase il nome musicale di Hoorne, la città natale di Guillaume, a riprova che ci si sente più protetti nel battezzare i luoghi minacciosi con nomi che evocano pace e sicurezza. Anche il capo di «Buona Speranza» sembra sia stato chiamato così seguendo lo stesso istinto.
Pochi anni più tardi gli spagnoli vennero a sapere del famoso
viaggio, e decisero di fare la ronda anche in questi paraggi, con
l'intenzione di stabilirvi dei forti per proteggere i loro possedimenti
sudamericani. In quell'occasione ripresero il nome di
Hoorne, trasformandolo per assonanza in «Horno», che in
spagnolo significa forno. Non sembra che vi sia alcun rapporto
tra questa parola e il luogo, a meno che non si immagini l'intera zona come un
immenso calderone nel quale venti, correnti, aria e acque danzano un'infernale
sarabanda.
Miglio dopo miglio, ci facciamo strada nel Grande Passaggio. L'acqua è grigia, grigio il cielo. Il ritmo dei turni è ormai ben stabilito: Agnès con Joël, Olivier e Fabrice, Isa con Erik. Ogni volta che è il nostro turno indossiamo il pile e la cerata e posiamo le mani sulla ruota foderata del timone, o avviamo il pilota automatico. Tre ore di veglia sotto la capottina, tre ore di sussurri a mezza voce, di tè e di scatolette di zuppa di asparagi. Poi, tre ore dedicate alla lettura, o ai sogni, nel quadrato. Infine, tre ore di sonno, rannicchiati alla bell'e meglio in cuccetta. Quindi, un bussare lieve e discreto sulla paratia: «A te la cura!» e la cerata è già lì che aspetta, dondolando appesa a un chiodo. Giorno, notte, giorno, notte. In mare il tempo non esiste. È possibile misurarlo solo grazie all'avanzata delle crocette sulla carta. | << | < | > | >> |Pagina 92Si avvicina. Si allunga voluttuosamente su un fianco. Ci osserva con i grandi occhi dolci. A che cosa pensano, le balene? Questa, ci prende forse per loro congeneri, vista la forma del nostro scafo che ricorda quella del suo ventre? Ci riserverà una danza d'amore, o ci impartirà un maligno colpo di coda? In entrambi i casi l'avventura, per noi, finirebbe male. No. Ci guarda, semplicemente. Sotto la vecchia palpebra vi è come un oscuro abisso popolato di bagliori. Si tratta forse solo dei riflessi del giorno appena iniziato. Ma noi, noi vi vediamo i lampi di un'antica collera, il ricordo dei massacri e l'odio per l'uomo. Ora si volta, si immerge con calma, aggraziata nella sua pesantezza. Passano due secondi, e ci offre la vista della coda a ventaglio, come nelle foto delle riviste. Poi, rimane solo qualche cerchio concentrico disegnato sull'acqua, che a poco a poco scompare con un leggero sciacquio. L'impressione di fascino nostalgico dura poco, e sentiamo Fabrice che esclama trionfante: «L'ho presa! Ce l'ho! Finalmente!» In mancanza delle impronte digitali, i disegni, le macchie e le cicatrici sulla coda delle balene permettono di individuare a colpo sicuro uno specifico individuo. E i cetologi (ossia: gli scienziati che studiano le balene) si sono lanciati nell'impossibile pedinamento. I più pignoli (a tendenza scientifica) direbbero che stiamo facendo una fotoidentificazione della pinna natatoria caudale. Si vuole scoprire quali animali si trovano in quali luoghi, in quale epoca dell'anno e, sfiorando l'indiscrezione, in quale compagnia. L'obiettivo è quello di comprenderne le rotte migratorie e l'appartenenza a un gruppo, per poterne stimare la quantità. Fabrice, oltre a essere l'ornitologo ufficiale della spedizione, è pronto a indossare l'abito del cetologo. A sentir lui, avremmo sotto gli occhi un gruppo composto da quattro adulti e un piccolo della specie ormai rara delle balene megattere, di cui solo seimila esemplari solcano ancora le acque del globo. Cinque di quelle seimila megattere sono qui, davanti a noi! Capirete la nostra eccitazione. Ma fare foto-determinazione non è alla portata di chiunque, e saper cogliere una caudale nel momento dell'immersione è uno sport impegnativo, anche con i migliori apparecchi. «Eccola! Soffia! Forza, avvicinati! No, non in controluce! Presto, si immerge! Piano, potrebbe spaventarsi!» Per effetto dei nostri ordini contraddittori, l' Ada comincia a zigzagare a motore. Temo che il nostro contributo alla scienza sarà modesto. Il piccolo sembra lungo almeno quattro o cinque metri... quindi è un maschietto! Non si allontana dalla madre, e del resto non si può che essere molto attaccati a qualcuno che ci fornisce cento litri di latte al giorno. La balena megattera, lenta e placida, ha sofferto ancor più delle altre specie per la caccia di cui è stata oggetto. Qui è doppiamente protetta dalla moratoria internazionale e dal trattato sull'Antartide, eppure la sua sopravvivenza non è garantita. In inverno essa lascia l'Antartide alla ricerca di acque più calde, nelle quali rischia di incontrare i suoi nemici nipponici, norvegesi o islandesi che, con la scusa della ricerca scientifica, aggirano il divieto di caccia alla balena. Vi è poi un pericolo ancor più subdolo che la minaccia, e che riguarda il krill, il suo alimento preferito, del quale consuma svariate tonnellate ogni giorno. Ebbene, l'abbondanza di questi gamberetti dipende dalla temperatura dell'acqua e dall'intensità dell'irraggiamento solare. È sufficiente che intervengano dei cambiamenti dovuti alle trasformazioni climatiche o delle correnti perché le balene siano costrette a cercare altrove il loro pasto... sempre che sia possibile. Ahimè, è davvero difficile essere un grande animale! La contemplazione delle balene è rasserenante. Quella delle foche, invece, suscita un sentimento di provocazione. Questi animali, infatti, sfiorano l'indecenza. Eccole lì, spaparanzate, che vanno in sollucchero sul gelido ghiaccio. Si tratta di un gruppo composto da tre o quattro foche cancrivore (o mangiagranchi), riconoscibili per il bel pelame di un giallo paglia, allungate su una lastra di ghiaccio galleggiante, che dormono beate appoggiandosi l'una all'altra sino a formare un'unica massa. Quando ci avviciniamo girano appena la testa prima di richiudere pigramente gli occhi, come bagnanti disturbate mentre prendono il sole. Sono adagiate sul tappeto di ghiaccio come su una morbida trapunta e non sembrano soffrire per il vento dispettoso. Non fanno nulla, assolutamente nulla, a parte grattarsi il ventre con lascivia e risistemare la testa che di quando in quando scivola sul guanciale di ghiaccio. Ma non sembrerà, a volte, che provino anch'esse paura, fame, freddo? Macché! E quando si immergono, questi grandi sacchi di grasso diventano ancora più scoraggianti, perché si trasformano in sinuose ballerine che ondeggiano con grazia infinita. Le foche di Weddell sono in grado di immergersi oltre i settecento metri di profondità, e di restare sotto il ghiaccio senza respirare per ottantadue minuti. Una tale scioltezza e noncuranza finisce per indispettire noi bipedi, così ansiosi e maldestri. L'unico indizio di conflitto nella loro vita sembrano essere le cicatrici di cui sono cosparse, ricordo delle aggressioni delle orche o dei loro cugini, le foche leopardo. Foca leopardo! Che strana associazione! Cosa avrà mai a che fare il pacifico mammifero marino con la fiera delle foreste tropicali? Ebbene, proprio la foca leopardo, dopo l'orca, è il più grande predatore che i pinguini debbano temere. In un film americano si capirebbe subito che è lei la cattiva: corpo affusolato, palpebra pesante, chiostra di grandi denti. Eccola che gironzola a pelo d'acqua intorno a una colonia di pinguini. Gli uccelli, che la riconoscono dalla sagoma, esitano a tuffarsi. Si accalcano con aria perplessa sul limite del ghiaccio, passeggiando indecisi. «Forza, passa avanti! Ma no, ti prego, dopo di te...» Non vi è nulla che susciti l'antropomorfismo quanto le figurine umanoidi dei pinguini. Infine, uno di essi si decide, si tuffa. La belva è su di lui, lo insegue, lo terrorizza, lo mordicchia, lo lancia per aria, lo trascina verso il fondo. Poi, per divertirsi, gli fa credere di essere riuscito a fuggire, nonostante l'ala ferita, ma infine lo riprende, lo lancia ancora. L'acqua si tinge di rosso. Intanto, gli altri pinguini ne approfittano per correre alla ricerca del cibo reclamato con insistenza dai loro piccoli. Che mestiere pericoloso, fare i genitori! In mancanza di saporiti pinguini, per fare merenda la foca leopardo non disdegna di prendersela con gli Zodiac di gomma. Certo che deve avere la vista un po' debole per confonderli con le giovani foche che sono anch'esse parte del suo menu abituale. E che dire, poi, della foca leopardo che ha pensato bene di sgranocchiare un'inglese? Non è una storia divertente, e la povera ricercatrice è morta per le ferite.
Brigitte Bardot, al contrario, può dormire tranquilla, perché
dalla firma del trattato sull'Antartide nel 1959 ogni tipo di caccia a sud del
sessantesimo parallelo è vietata. E così le foche si
sono moltiplicate, approfittando senza dubbio anche della diminuzione delle
balene e della maggior abbondanza di cibo che ne è conseguita.
Il tratto davvero caratteristico dell'Antartide, però, sono gli uccelli, e tra essi in particolare i pinguini, che costituiscono il settanta per cento degli effettivi piumati del continente. Il pinguino puzza e sbraita. Nulla a che vedere con i placidi peluche con cui giocano i bambini. Ma la natura ha i suoi buoni motivi, e infatti è anche grazie all'intenso odore che questi uccelli ritrovano la loro colonia. Quanto allo strepito, esso non si scatena solo in situazioni di aggressività, paura, o corteggiamento, ed è anzi essenziale anche per il funzionamento delle famiglie. Come fareste voi, altrimenti, per ritrovare i vostri piccoli tra centinaia di pallottole di piumino grigio? Il pinguino ricorre al canto. Una modulazione su due toni diviene una sorta di autografo personale che permette di riservare ai propri piccoli, e solo a loro, la deliziosa minestrina di pesce procurata con tanti affanni. Il pinguino imperatore è senza dubbio l'idolo dei media, ma nella penisola antartica, prediletta dalle specie Papua, di Adelia e pigoscelide dell'Antartide, è piuttosto raro. Ogni specie, poi, ha i propri ghiribizzi. Il Papua, per esempio, deve il suo nome, piuttosto assurdo per un animale del grande freddo, a un semplice errore. I primi esemplari impagliati, infatti, erano stati mescolati ad altre specie catturate in Nuova Guinea... Il Papua è timidissimo, dunque è meglio non avvicinarglisi troppo per evitare che abbandoni definitivamente il suo nido. In una società umana si conquisterebbe l'appellativo di «buon padre di famiglia» per la sua grande fedeltà: il novanta per cento di essi ritrova il rispettivo partner da un anno all'altro. Inoltre, il Papua è un pinguino operoso, che cura assiduamente la costruzione del nido di pietre e fango. Bravi genitori e lavoratori solerti, i Papua pescano per tutto il giorno e tornano a casa esausti, ma con la pancia piena, per nutrire i loro due piccoli. Insomma, dei veri cittadini antartici modello. Il pinguino di Adelia è, al contrario, un brontolone. Intanto, ama solo due colori: ha il dorso nero come l'inchiostro, il ventre di un bianco abbagliante e gli occhi, anch'essi nerissimi, messi in risalto da un cerchio candido. Poi, il pinguino di Adelia ostenta senza pudore la propria intransigenza, dall'alto dei suoi settanta centimetri, affrontando con spavalderia i vicini e ricoprendoli d'insulti per questioni territoriali o di furto di ciottoli. Le piccole pietre necessarie alla fabbricazione dei nidi, infatti, sono piuttosto rare, e il signor Adelia ne omaggia spesso la sua signora, tentando di ingraziarsela. Inutile, infine, sperare di far sloggiare i pinguini Adelia mettendo in piedi, per esempio, una stazione scientifica: essi non esiteranno a fare il nido proprio davanti alla porta, o tra le apparecchiature, riaffermando così il loro feroce istinto di proprietà e l'amore per le comodità conquistate. Vi sono colonie di questi pinguini che risalgono a trentamila anni fa, e non sarà certo qualche grosso umano arrogante a farli sloggiare. Quanto al pigoscelide dell'Antartide, elegantissimo grazie al sottile collarino nero, si tratta di un vero alpinista che ama insediarsi spesso a decine di metri d'altezza, sulle scogliere. Il carattere è quello del ragazzaccio rumoroso è attaccabrighe, aggressivo al punto da tentare di attaccare l'uomo. Questa specie sembra aver saputo approfittare dei nostri errori, e grazie al maggior nutrimento reso disponibile dalla diminuzione dei cetacei è riuscito a triplicare la sua popolazione in soli vent'anni. Per una volta, sembra, la nostra bestialità ha avuto un risvolto positivo. Ma ci permette anche di verificare la lentezza con cui un ecosistema reagisce a una perturbazione. Ci vuole tempo, molto tempo, in particolare in un ambiente freddo, prima che si instauri un nuovo equilibrio biologico. Alcune specie approfittano delle mutate condizioni, altre si estinguono, e noi possiamo solo tener traccia dell'accaduto.
Il pinguino fu uno degli amici più commestibili degli esploratori. Tuttavia,
la gastronomia pigosceliana (anche i pinguini
Papua e di Adelia appartengono al genere dei pigoscelidi) non
brilla certo per varietà. Ecco il menu del naufrago antartico,
sette giorni su sette:
Tutti i miracolati di un naufragio in Antartide ve lo confermeranno:
il pinguino, a condizione che sia fresco, è assai più
gustoso della bistecca di foca. Certo, ha un forte gusto di pesce,
ma la consistenza è simile a quella del pollo. Unico inconveniente sono le sue
piccole dimensioni. Un essere umano di normale costituzione, costretto a
trascorrere miseramente l'inverno ben oltre il circolo polare, avrà la tendenza
a consumare svariate decine di uova al giorno, oltre a numerosi pezzi di carne
di pinguino, per evitare di morire di fame. Per superare la brutta
stagione, dunque, dovrà necessariamente provocare un'ecatombe. Certo, il
frigorifero è enorme, ma il termostato non risulta ben regolato: basta qualche
aumento di temperatura imprevisto per trasformare le riserve pazientemente
accumulate in una poltiglia nauseabonda. Quindi, più il tempo passa, più le
scorte alimentari tendono a imputridire anche se, per una fortunata coincidenza,
nel contempo l'uomo diviene anche sempre più affamato. Lodato sia dunque lo
spirito di sacrificio dei pinguini, che ci ha permesso di ritrovare in vita
Shackleton, Nordenskjöld e tanti altri eroi polari.
Che cosa sarebbe oggi, l'Antartide, senza le insenature nelle quali un mare di piume pigolanti accoglie il visitatore? Cosa ne sarebbe dei fotografi naturalisti, delle agenzie di viaggio e delle pubblicità dei frigoriferi, se non potessero più far conto su questo emblematico uccello? Ma il pinguino, in tutta la sua saggezza, ha saputo adattarsi alle fisime degli umani. E la sua capacità di aumentare e ridurre i depositi di grasso nell'organismo, grazie all'azione di determinate proteine, sembra interessare vivamente i nostri dietologi. Dopo averci nutrito, il pinguino potrebbe ora aiutarci a inventare dei nuovi trattamenti dimagranti. | << | < | > | >> |Pagina 142Osservando Isabelle vivere, mi si impongono alcune distinzioni, che formano anche gerarchie. I modi di amare e di praticare il mare sono infiniti. Iniziato sin da piccolo da mio padre ai misteri dell'acqua salata, posso considerarmi: — un diportista. Nulla eguaglia per me la felicità del destreggiarsi, con la deriva a metà, nelle innumerevoli correnti e controcorrenti del mio arcipelago di Bréhat; - un regatante. Che piacere trionfare sui vecchi amici grazie a una percezione più fine del piano acquatico, a manovre migliori, alla capacità di seguire traiettorie più astute e audaci tra le boe! — un navigatore. Visto che sino a questo momento il mal di mare mi ha risparmiato (tocchiamo ogni ferro possibile), non vi è luogo al mondo in cui io mi trovi meglio a scrivere che nella mia cuccetta. Mi infilo alla meno peggio tra la mensola laterale e il telo antirollio, tento di accordare il ritmo della matita a beccheggio, rollio e altre amenità della barca, accendo la lampadina fissata alla fronte, e il mio cervello, senza dubbio stimolato da un tale campionario di scomodità, si mette a girare a tutta velocità. Eppure queste attività, anche se svolte le une insieme alle altre, non fanno di me un marinaio. Marinaio è colui, o colei, per il quale il mare è l'unico paese che conta, l'unico che abbia valore. Un marinaio si riconosce per le seguenti qualità: — pazienza. Il mare ha i suoi tempi; bisogna saper aspettare che cambi di umore; — forza fisica. Non basta certo l'aiuto dei winch a evitare di sfinirsi per la stanchezza; — capacità di lettura (o preveggenza). Il mare e il cielo sono libri difficili, che il marinaio sa leggere meglio degli altri, a occhio nudo o grazie agli strumenti, così da essere in grado di fare previsioni; — velocità di decisione. Sopra un fondo di lentezza e indifferenza, il mare presenta a volte picchi di violenza ai quali è necessario reagire rapidamente; — genio del bricolage. Ogni uomo di mare è un Robinson Crusoe; la barca è la sua isola ed egli non può contare che sui propri mezzi; — padronanza dell'arte della siesta. Il vero uomo di mare ha fatto suoi i seguenti tre principi: 1. in mare la notte non ha senso (perché è frammentata dai turni di guardia); 2. il sonno necessario è divisibile all'infinito nel corso della giornata; 3. l'avvenire nautico è per sua natura sempre incerto, meglio dunque riposare ogni volta che si può, dove e quando si può. L'essenziale, tuttavia, non è questo. Il marinaio è un moralista. Affrontando il mare egli cerca la sua verità. Non quella del mare (per sempre segreta), ma la sua propria. E più affronta il mare, più tale verità gli si rivela. Corollario 1: chi non prende le vie del mare non conoscerà mai la verità. Corollario 2: il marinaio si sente e si sa superiore a tutti gli altri uomini. Corollario 3: l'uomo di mare antartico si confronta con il mare più di ogni altro uomo di mare, quindi ha accesso a maggiore verità; egli è dunque l'uomo di mare (l'essere umano) per eccellenza. Corollario 3 bis: raggiunta a prezzo dei più ardui sforzi, l'Antartide è la terra della verità. Spesso, dopo regate massacranti quali la Vendée Globe, i navigatori solitari compiono al più presto i loro obblighi mediatici e subito si dirigono verso il Grande Sud. Laggiù, finalmente, possono riprendere il dialogo interrotto con l'Estremo. | << | < | > | >> |Pagina 168Un'altra ragione per compiere questo viaggio non l'avevo prevista. Mi è stata donata a sorpresa. Secondo una logica ben conosciuta dai mistici, e popolarizzata da Blaise Pascal: prega, e crederai. Mettiti in viaggio, e capirai perché. Questa ulteriore ragione per amare l'Antartide è del tutto personale, e di natura nevrotica. Dato che soffro di vertigini a livello patologico, le montagne, anche le più modeste, mi sono precluse. La sola idea di una strada a tornanti a strapiombo sul vuoto, mi provoca un mancamento. E per quanto riguarda la possibilità di imbarcarmi, anche una sola volta, su quell'oggetto sospeso che si chiama teleferica, preferirei piuttosto suicidarmi. In breve, sapevo bene che le parti più alte del pianeta sono belle, forse le più belle, ma io non vi avevo diritto di accesso. In Antartide, si arriva alle vette dal mare. Un mare certamente agitato, ma privo delle famose strade a tornanti evocate più sopra. La vostra imbarcazione vi trasporta direttamente in alta montagna. La navigazione, come per miracolo, vi trasforma in alpinisti. Alpinisti seduti, alpinisti senza piccozza. Ma pur sempre alpinisti: come altro si può chiamare chi ascende? Ho conosciuto una tale esaltazione arrivando nel bel mezzo degli isolotti Berthelot (65° 19' S, 64° 10' W). La nebbia, impenetrabile sino a quel momento, si era d'un tratto lacerata e io mi sono trovato proprio nel tipo di luogo che sino a quel momento mi era stato proibito: un lago d'altitudine. Alla mia destra e alla mia sinistra i ghiacciai discendevano con la loro impercettibile andatura. Di fronte a me, le vette salutavano e sembrava addirittura che sogghignassero: eccoti qui, infine, ce ne hai messo di tempo per venire! Avevo tentato mille volte di vincere il mio terrore. Mille volte mi ero giurato di riuscirci, e mi ero avviato lungo una strada che saliva verso un colle. E mille volte avevo dovuto ripercorrere a ritroso il cammino. Delle montagne, dunque, conoscevo solo i piedi. Eccomi ora, invece, a metà, a un terzo della salita, non più sul fondovalle. Mi ero inerpicato senza accorgermene. L'impressione che ho provato poggia su fatti confermati dalla scienza. I continenti galleggiano sul magma fluido e, come ogni altro corpo, si abbassano se qualcosa pesa su di essi. Proprio questo avviene in Antartide, dove la superficie continentale, ricoperta da uno spesso strato di neve e ghiaccio, sprofonda per settecento metri. Arrivando sul continente via mare, quindi, si è già conquistata una certa altezza, equivalente a settecento metri di arrampicata. Forza, ghiaccio e neve, ancora un piccolo sforzo, continuate a spingere in basso l'Antartide: potrò in questo modo, senza aver mai fatto scalate, raggiungere anche le vette! | << | < | > | >> |Pagina 170A partire dal 1890, e per vent'anni, i marinai più audaci che si avventuravano in questi paraggi poterono offrirsi un immenso piacere, riservato normalmente solo a Dio e ben descritto nella prima pagina della Genesi. «[...] Ora la terra era informe e deserta [...] Dio [...] chiamò la luce giorno e le tenebre notte. E fu sera e fu mattina: primo giorno.» Gli esploratori scoprono, inventano. In termini giuridici, la cosa smarrita che qualcuno ritrova è un'«invenzione». A modo loro, dunque, gli esploratori creano. Naturalmente, queste terre esistevano ben prima del loro arrivo. Ma hanno avuto bisogno dei loro viaggi per venire a nostra conoscenza. Colui che ingrandisce il mondo, non è forse un creatore? Creare, poi, significa distinguere. Per esempio, distinguere un'isola da una penisola. E distinguere è nominare. In questo campo, gli esploratori antartici si diedero alla pazza gioia, suscitando l'invidia dei loro confratelli terricoli: una volta battezzati corsi d'acqua e rilievi, che altro restava da nominare a un Livingstone o a un Brazza? Qui, invece, la natura è infinitamente arzigogolata. E ognuno dei suoi frammenti necessita di un nome. Ci volevano dunque migliaia di nomi, e infatti quelli più prevedibili sono stati tutti impiegati. Terre di Loubet e di Fallières (presidenti francesi); isole Anvers e Brabant (città e regione del Belgio); passaggio Bismarck (cancelliere tedesco); isola Hugo, monte Verne, ghiacciaio Melville (scrittori); isola Pickwick, monte Queequeg, picco Ismael, collina Gulliver (salute a questi personaggi di romanzi); capo Fair Weather (cioè Bel Tempo: deve essersi trattato di una stupefatta constatazione); baia Exasperation e capo Disappointment (stati d'animo: esasperazione e disappunto); baia Marguerite (nome della seconda moglie di Jean-Baptiste Charcot); stretto Matha, isola di Wiencke (omaggio a marinai scomparsi); ghiacciaio Pequod (nome di veliero immaginario, quello di Moby Dick ); isole Eta, Alpha, Beta (lettere greche); arcipelago Melchior (re Mago); arcipelago Palmer (cacciatore di foche americano), isola Lavoisier (scienziato decapitato); isola Sphinx (Sfinge: un ricordo del Cairo, o piuttosto una dichiarazione di perplessità davanti ai misteri locali?); isola Small (Piccola: forse qui l'esploratore non trovava più idee, gli si era esaurita l'immaginazione)... Sembrano i frammenti mescolati di innumerevoli storie, come se il vento si fosse insinuato nella memoria degli esploratori, o nelle loro biblioteche, e avesse messo tutto a soqquadro. | << | < | > | >> |Pagina 187Domenica 5 febbraio 2006Inizia il primo turno di guardia: dalle otto alle undici. Prima di tutto consultiamo l'ultima carta della situazione dei venti. Ci conferma le informazioni precedenti: la «nostra» depressione dovrebbe raggiungerci in prima serata. Quanto al vento di nord-est, regalo dell'anticiclone, è già arrivato. Ci attende là fuori con i suoi venti nodi, e soffia proprio dal luogo verso cui siamo diretti (capo Horn). Il futuro si preannuncia poco confortevole. Mentre gli altri dormono, noi discutiamo. Erik: «Non trovi che l'uomo di mare sia un animale morale? Morale nel senso cristiano di amare le penitenze. Il marinaio si castiga da solo. E rispetta solo coloro che si castigano». Isabelle: «No, non credo. Ma la vela ha molto da insegnare. In primo luogo a trovare il proprio posto sul pianeta. La vela insegna il rispetto, cosa che non ci impedisce di realizzare i nostri progetti. E ci insegna anche a fare uso dell'intelligenza. In ogni circostanza ti costringe a chiederti: che cosa potrei fare? Il giorno in cui l'avviamento del suo motore si è rotto, Michel Desjoyeaux ha vinto il Vendée Globe, o comunque non l'ha perso. Ha riflettuto, si è dato da fare. Un esempio contrario: due uomini attraversano l'Atlantico. Disalberano. Invece di agire si lasciano andare alla deriva. Un albero che si rompe dovrebbe fare infuriare, ma non disperare, soprattutto se a bordo non manca il cibo. Nel loro caso, la barca è arrivata tranquillamente sino alle Antille, ma troppo tardi: uno dei due era già morto». «Voi gente di mare, però, siete come gli alpinisti. Volete trovare il limite...»
«Niente affatto. Conosco molti arrampicatori. La paura o il fascino della
morte fanno parte in modo intimo del loro piacere, mentre
non direi altrettanto per i marinai. Essi, infatti, vogliono solo che la
barca vada avanti. E una buona navigazione è tale quando non vi è
paura. Quando arriva la tempesta, d'altro canto, bisogna affrontarla.
Una barca è una cosa solida. Da abbandonare solo all'ultimo momento, nei casi
più estremi. E di tali casi posso assicurarti che ne arrivano solo in seguito a
rarissime combinazioni di catastrofi successive. Una parete di ghiaccio, al
contrario, non è così solida. E men che meno un alpinista.»
|