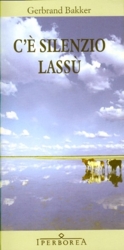
|
|
|
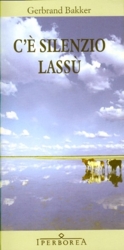
|
|
|
| << | < | > | >> |Pagina 11Ho messo mio padre di sopra. Dopo averlo sistemato su una sedia, ho smontato il letto. Lui è rimasto lì, come un vitello appena nato non ancora leccato dalla madre: la testa ciondolante e gli occhi che non si fissano su niente. Ho tirato via le coperte, le lenzuola e il coprimaterasso, appoggiato materasso e doghe contro il muro e staccato testiera e pediera dalle sponde. Cercavo di respirare il più possibile con la bocca. La camera al piano di sopra – la mia camera – l'avevo già sgombrata. "Che cosa fai?" mi ha chiesto. "Ti trasferisci." "Voglio restare qui." "No." Il suo letto poteva anche tenerlo. Una metà è fredda da più di dieci anni, ma quel posto vuoto continua a essere coronato da un cuscino. Nella camera al piano di sopra ho rimontato il letto, la pediera rivolta alla finestra. Sotto le gambe ho messo delle zeppe. Ho rifatto il letto con lenzuola pulite e due federe pulite. Poi ho portato mio padre di sopra. Quando l'ho sollevato dalla sedia mi ha guardato fisso e ha continuato a fissarmi finché non l'ho depositato sul letto e i nostri volti si sono quasi sfiorati. "Sono capace di camminare da solo", ha detto, solo allora. "No, non sei capace." Dalla finestra ha visto cose che non si aspettava di vedere. "Si è in alto, qui." "Sì, così puoi guardare fuori senza vedere solo cielo." Nonostante la stanza nuova, le lenzuola e le federe pulite, c'era odore di chiuso, era lui che sapeva di chiuso e di muffa. Ho aperto una delle due finestre e l'ho bloccata con il gancetto. Fuori c'era un freddo frizzante e silenzio, solo sui rami più alti del frassino curvo del giardino era rimasta ancora qualche foglia accartocciata. In lontananza ho visto tre ciclisti sulla strada dell'argine. Se mi fossi spostato di un passo li avrebbe visti anche lui. Non mi sono mosso. "Chiama il dottore", ha detto. "No." Ho girato sui tacchi e sono uscito.
Poco prima che la porta si chiudesse, l'ho sentito
gridare: "Le pecore!"
Nella sua vecchia camera c'era un rettangolo di polvere sul pavimento,
appena più piccolo della misura
del letto. Ho sgombrato la stanza. Le due sedie, i comodini e la toeletta di mia
madre li ho messi in salotto. Poi ho infilato due dita sotto un angolo della
moquette. "Non incollarla", ho sentito dire da mia
madre un'eternità fa, mentre mio padre si stava inginocchiando con un barattolo
di colla nella mano sinistra e un pennello nella destra, e noi eravamo già
quasi storditi dalle acri emanazioni. "Non incollarla,
perché tra dieci anni ne vorrò una nuova." Il retro
della moquette misi sbriciola tra le dita. L'ho arrotolata e, passando per la
sala del latte, l'ho portata fuori;
in mezzo all'aia di colpo non ho più saputo che farne.
L'ho lasciata cadere li dov'ero. Due o tre taccole, spaventate dal tonfo, sono
volate via dagli alberi che bordano il cortile.
Il pavimento della camera da letto è coperto da pannelli di compensato, con
la parte grezza rivolta in su.
Dopo aver passato rapidamente l'aspirapolvere, ho
preso un pennello largo e piatto e li ho dipinti con
una mano di fondo grigio, senza carteggiarli. Mentre
dipingevo l'ultima striscia, davanti alla porta, ho visto le pecore.
Sono in cucina, adesso, ad aspettare che la vernice si asciughi. Solo dopo potrò togliere dalla parete quel quadro deprimente, con quella coppia di pecore nere. Visto che vuole avere le sue pecore davanti agli occhi, pianterò un chiodo nel muro vicino alla finestra e gli appenderò li il suo quadro. La porta della cucina è aperta e quella della camera da letto pure, da dove sono seduto vedo il quadro, al di là della toeletta e dei due comodini, ma è talmente scuro e spento che, nonostante i miei sforzi, non riesco a distinguere le pecore. | << | < | > | >> |Pagina 13Piove e il vento forte ha strappato le ultime foglie del frassino. Novembre non è più né freddo frizzante né silenzioso. La camera da letto dei miei genitori adesso è la mia camera. Ho imbiancato i muri e il soffitto e dato una seconda mano di fondo al compensato. Le sedie, la toeletta di mia madre e i due comodini li ho portati di sopra. Ho messo un comodino vicino al letto di papà e il resto nella stanza vuota accanto alla sua. La stanza di Henk. Le vacche sono dentro già da due giorni. Sono nervose quando le mungo.
Se stamattina il coperchio del camion del latte
fosse stato aperto, metà del latte sarebbe schizzato
fuori come un geyser, da quanto ha frenato bruscamente l'autista davanti alla
moquette rimasta lì arrotolata in mezzo all'aia. Stava ancora imprecando tra
sé quando sono entrato nella sala del latte. Ci sono
due autisti del latte, e quello era il più vecchio, quello
scorbutico. Credo che abbia più o meno la mia età.
Ancora qualche anno di guida e poi la pensione.
La mia nuova camera, a parte il letto, è totalmente
vuota. Credo che darò una mano di pittura anche
agi infissi di legno – battiscopa, porta e finestre. Forse
dello stesso colore del pavimento, ma non sono ancora del tutto sicuro. Ho in
mente un grigiazzurro: il
colore dell'IJsselmeer in una giornata d'estate che nuvole grigie di temporale
minacciano in lontananza.
Sono passati di qui, sarà stato fine luglio o inizio agosto, due ragazzi in canoa. Non capita spesso, i percorsi ufficiali delle canoe non passano davanti alla mia fattoria. Solo i canoisti che vogliono spingersi oltre arrivano fin qui. Erano a torso nudo, faceva caldo, i muscoli delle braccia e delle spalle luccicavano al sole. Me ne stavo dietro l'angolo della casa senza farmi vedere, e li guardavo capovolgersi a vicenda. Le pagaie battevano sull'acqua in mezzo alle ninfee gialle. La prima canoa si è messa di traverso, incagliandosi con la prua nella sponda del canale. Il ragazzo ha volto lo sguardo verso di me. "Guarda", ha detto all'amico, un tipo rosso con le lentiggini e le spalle bruciate dal sole, "questa fattoria è fuori dal tempo. Qui, su questa stradina, potrebbe essere oggi, ma potrebbe benissimo essere il 1967 o il 1930." Il tipo rosso ha osservato attentamente la fattoria, gli alberi e il campo dove in quel momento pascolavano gli asini. Ho teso le orecchie. "In effetti", ha risposto dopo un lungo silenzio, "quegli asini, sono davvero d'altri tempi." Il ragazzo della prima canoa si è disincagliato dalla riva e ha rimesso la prua nella direzione della corrente. Ha detto qualcosa, qualcosa che non ho capito perché una pettegola si è messa a fare un gran chiasso. Una pettegola tardiva, in genere a fine luglio se ne sono già partite tutte. Il tipo rosso ha seguito lentamente il compagno, senza staccare gli occhi dai miei due asini. Non avevo vie di fuga, niente di cui potessi fingere di occuparmi su quel lato spoglio della casa. Sono rimasto li immobile, trattenendo il fiato. Mi ha visto. Ho pensato che stesse per dire qualcosa al compagno, le sue labbra si sono schiuse e ha girato la testa. Ma non ha detto niente. Si è limitato a guardare, senza rivelare la mia presenza all'altro. Poco dopo hanno imboccato il canale di Opperwoude e il tappeto di ninfee gialle è tornato a richiudersi. Sono uscito sulla strada per seguire i due ragazzi con lo sguardo. Dopo qualche minuto non si sentivano più le loro voci. Mi sono voltato e ho cercato di guardare la mia casa con i loro occhi. "1967", ho mormorato, scuotendo la testa. Perché proprio quell'anno? Il primo l'aveva nominato, l'altro, quello con le lentiggini e le spalle bruciate dal sole, l'aveva visto. Faceva molto caldo quel giorno, metà pomeriggio, quasi ora di portare dentro le vacche. Tutt'a un tratto ho sentito le gambe pesanti e il pomeriggio è diventato vuoto e irreale. | << | < | > | >> |Pagina 34È tutta la vita che ho paura. Paura del silenzio e del buio. E anche tutta la vita che faccio fatica ad addormentarmi. Mi basta sentire un rumore che non conosco e addio sonno. Eppure non ho mai fatto realmente caso a quello che succede fuori di notte. Un tempo, certo, ho visto passare di tutto davanti alla finestra, pur consapevole che si trovava a parecchi metri da terra. Spalle, vedevo, spalle tese, contratte, di qualcuno che si arrampicava sulla facciata della casa. Come una pantera. A volte con un braccio già sul davanzale. Allora ascoltavo il respiro di Henk, che era disteso di fianco a me, e più avanti lo immaginavo addormentato nella stanza accanto alla mia, e le spalle, o qualunque cosa fosse quella che credevo di vedere, sparivano. Sapevo dentro di me di vedere cose che non potevo vedere.
Adesso, dopo quello che ho visto sulla strada e
dopo aver dato da mangiare a mio padre, sono a letto
con gli occhi ermeticamente chiusi. Devo dormire,
penso, devo dormire. Ma vedo pecore che si lamentano e ruminano nel campo,
pennellate grigiastre nella pianura verdenera, e taccole sui pioppi con il
capo tra le piume, e gli asini uno di fronte all'altro vicino allo steccato, con
il collo curvo come se sonnecchiassero testa contro testa, e il mulino Bosman,
che ho fermato di nuovo, solitario in un angolo dove si
staglia grigio chiaro quando si apre uno squarcio tra
le nubi, e qualcuno che alza lo sguardo verso la coda
e legge: "N. 40832". Davanti a quella scena apro gli
occhi. Ci sarà stato spesso qualcuno lì fermo davanti
alla fattoria nelle notti d'autunno? E l'avrei mai scoperto se non avessi
guardato per caso dalla finestra della camera di mio padre?
Più tardi vedo i ragazzi in canoa. Il primo, quello che ha detto che questo è un posto senza tempo, una figura sfocata che svanisce subito. L'altro, il tipo rosso con le spalle bruciate dal sole, resta. Ha detto qualcosa, ma quel che ha detto non conta. Ha visto, e ha visto me. Un contadino di mezza età in tuta blu scolorita con i primi bottoni slacciati perché quel giorno faceva molto caldo. Che stava all'ombra, di fianco a una fattoria, e non aveva altro da fare che guardare immobile, trattenendo il fiato. Un contadino che dal 1967 è invecchiato giorno dopo giorno senza che per il resto cambiasse nulla – no, almeno una cosa è cambiata: gli asini, ed è proprio sugli asini che ha detto qualcosa il ragazzo dai capelli rossi. Che erano d'altri tempi. Conta, perciò, quello che ha detto. Risalgono pagaiando verso il canale di Opperwoude, giovani, ridenti, egocentrici, e quindi pronti a dimenticare in fretta le cose. Il sole tramonta in fondo al canale. È assolutamente impossibile, perché il canale prosegue verso est, qui il sole non tramonterà mai nell'IJsselmeer, ma in questo momento è possibile e i ragazzi diventano due silhouette dalla voce sempre più impercettibile. Poi scompaiono. Adesso, penso, adesso mi addormento. Ma dirlo vuole già dire scordarselo. Quel sole immaginario mi evoca il mare, che disterà trentacinque chilometri in linea d'aria, verso ovest. Ci siamo stati tanto tempo fa, due volte la stessa estate. Ed entrambe le volte il cielo ha finito per coprirsi. Mamma voleva tanto vedere il sole tramontare in mare ed era riuscita a convincere papà a lasciare che il garzone mungesse da solo. Non ho mai visto tramontare il sole in mare, e potrei vederlo senza andare lontano. Sento qualcosa, credo che sia sotto la mia finestra e ho come l'impressione che mi si rizzino i capelli sulla nuca. Penso a mio padre, di sopra. Non è più buono a nulla, ma ho comunque bisogno di lui in questo momento per scacciare le mie paure. Forse il ragazzo dai capelli rossi pensa ancora a me ogni tanto, pensa a quel vecchio contadino che se ne stava lì così, in quella bella giornata d'estate. | << | < | > | >> |Pagina 133Sono le dieci e mezzo del mattino. Piove da una coltre di nuvole basse. Come sempre hanno sbagliato le previsioni. C'è la luce accesa in cucina. Il frassino curvo è lucido di pioggia, la cornacchia grigia se ne sta appallottolata sul suo ramo. Ogni tanto scrolla le penne senza spiegare le ali. In quei momenti sembra un passero che fa il bagno in una pozzanghera dell'aia. Un passero gigante. Aspetto. Sul tavolo davanti a me c'è il giornale, ma non riesco a leggere. Guardo fuori. L'orologio ronza, di sopra un silenzio assoluto, nella mia tazza qualche sorso di caffè freddo. Non c'è silenzio solo lassù, c'è silenzio ovunque, la pioggia ticchetta dolcemente sul davanzale della finestra, la strada è bagnata e deserta. Sono solo, non ho nessuno contro cui rannicchiarmi. Nel febbraio del 1963 mio padre ci portò a fare dei giri in macchina sul Gouwzee gelato. "Una cosa così non ci capiterà mai più", diceva ridacchiando. Henk e io eravamo seduti dietro, lontani uno dall'altro, ciascuno incollato al suo finestrino. Mamma era rimasta a Monnickendam, aveva troppa paura. Quando tornammo al porto ci aspettava nello stesso identico posto in cui l'avevamo lasciata, con le ciglia coperte di minuscoli ghiaccioli. Al terzo o quarto giro, mio padre curvò a destra anziché a sinistra, in fondo alla diga di contenimento. Dopo una cinquantina di metri frenò. La diga di contenimento è una diga che i costruttori sembrano essersi dimenticati di finire, tra l'isola di Marken e Volendam, per cui Marken è destinata a restare per sempre separata dal paese. Chino sul volante, mio padre ne fissava il punto estremo, la porta d'accesso all'IJsselmeer. Sospirò. C'era il sole, era come se ci fosse sempre stato il sole in quel lungo inverno. La neve si spostava sul ghiaccio come sabbia su una spiaggia bagnata. Henk e io capimmo, senza guardarci, quale fosse l'intenzione di papà. Ci staccammo dai finestrini, scivolando uno verso l'altro al centro del sedile. Avevamo quindici anni. Nello specchietto retrovisore vedemmo passare un'altra macchina, senza sentirla. Papà sospirò di nuovo. Il motore si era spento, eravamo circondati dal silenzio. "Il ghiaccio sarà spesso almeno ottanta centimetri", gli aveva detto qualcuno al porto. Uno spessore inimmaginabile. Papà cercò di farsene un'idea misurandolo con le mani, era pronto a rischiare. Ottanta centimetri, neanche un camion sarebbe sprofondato. Non era un silenzio normale, era un silenzio da brividi. Papà non sapeva quanto fosse spesso il ghiaccio oltre la diga. Mentre continuava a sospirare, noi scivolammo ancora più vicini, fino a trovarci attaccati come gemelli siamesi dal bordo del piede alla spalla. Se papà avesse avuto il coraggio di lanciarsi in quell'avventura, avviando la macchina e andando incontro alla superficie di neve immacolata, l'avremmo affrontata come un sol uomo, senza paura, in assoluto silenzio. Papà avviò la macchina, il motore si accese solo al quarto o quinto tentativo. Non avevo più idea di avere una mia pelle, dei miei muscoli, delle mie ossa. Avrebbe potuto ingranare la prima. Invece fece retromarcia, molto lentamente, come se volesse concedersi il tempo di cambiare idea. A poco a poco Henk e io vedemmo le quattro montagnole di neve sollevate dalle gomme rimpicciolirsi. Poi papà fece ancora un quarto o quinto giro a folle velocità, rischiando di uscire in curva, e strappandoci per qualche breve, brevissimo istante dalla nostra condizione di siamesi. Solo quando ci rendemmo conto che la mamma ci vedeva, poco prima che papà salisse con la macchina sulla rampa di alaggio, ci dividemmo, tornando a essere Henk e Helmer. La mamma non riuscì ad articolare parola, il suo mento si rifiutava di abbassarsi, le sue labbra erano due strisce di carne congelate. | << | < | > | >> |Pagina 217Sono andato nel prato a contare le pecore. Quando vedo una pecora divento sempre un po' malinconico. Sono delle bestie talmente penose. Penso alle tre pecore che ho venduto per comprare la cartina della Danimarca, soprattutto perché neanche ho guardato di che pecore mi stavo disfando. Avrebbero tranquillamente potuto essere altre tre. Una ventina di pecore sotto la pioggia non sono una bella vista, delle pecore non tosate durante un'ondata di caldo sono orribili e una pecora zoppa è quasi insopportabile. La cosa peggiore è una pecora a zampe all'aria. Non è in grado di rialzarsi da sola, con le budella piene d'aria che premono sulla parete addominale, a furia di belare e rantolare e se c'è vento si gonfiano lentamente da sé tenendo la testa faticosamente sollevata il più a lungo possibile. Cerco di ricordarmi quando ho portato via l'ariete dal prato. È quasi il momento di rientrare. Conto diciannove pecore.
Non sono andato nel prato tanto per: conto le pecore
per evitare la casa. Riet ha telefonato. Ha chiesto di
nuovo se poteva fare un salto, così, solo per vedere, e
magari per fare qualche "lavoro da donna". Papà stava
tossendo, di sopra. Ho chiamato Henk, gli ho passato la cornetta e me ne sono
andato per i campi.
Sospiro e riconto da capo. Diciannove. Vado fino al fossato più vicino. La luce del sole scintilla sull'acqua immobile. L'immobilità non dice molto, una pecora che cade in acqua si arrende subito, inizia a bere e aspetta tranquillamente di vedere cosa succede. Le pecore di razza Texel annegano apposta. Un altro punto a loro sfavore. Cammino lungo il fossato fino al canale che lo incrocia. Le diciannove pecore si mantengono a una certa distanza, ma mi seguono. La pecora è nel terzo canale. L'acqua arriva quasi dappertutto a livello del terreno, è un canale con un argine non più alto di trenta centimetri. Affondo le mani nella lana e inizio a tirare la pecora. Hanno zampe sottili e fragili, ma quando sono immerse nel fango sembrano spuntoni di piombo. La pecora ondeggia un po' avanti e indietro, gira per un istante il muso verso di me, l'acqua batte contro l'argine non più alto di un righello. Allargo un po' i piedi e riprovo. Un attimo dopo mi ritrovo con un ciuffo di lana nella mano destra e il sedere sull'erba. Adesso la pecora non aspetta più tranquillamente di vedere cosa succederà. Si dibatte e bela contro la terra, rovescia gli occhi presa dal panico. Non ci penso due volte ed entro nel canale, senza togliermi gli stivali. Non è un canale profondo, ma quando mi piego sulle ginocchia per passare le braccia sotto la pancia, l'acqua melmosa mi arriva alle labbra. Provo a sollevare la pecora, gli stivali affondano sempre di più nel fango che li risucchia. Lentamente, ma sicuramente, l'animale emerge, eccolo già arrivato con un fianco contro l'argine. Proprio quando penso che il peggio è fatto, la pecora, sentendo la terra ferma, inizia a scalciare selvaggiamente. Perdo l'equilibrio, cado all'indietro e la pecora rotola sopra di me.
Gli stivali sono come colati nel cemento. Sono disteso sulla schiena, con le
ginocchia piegate. Non ho
più forza. Solo una volta riesco a tirare la testa fuori
dall'acqua attraverso la lana bagnata e pesante come
piombo e a prendere una grande boccata d'aria. Poi
il corpo della pecora mi spinge di nuovo sotto. Credo
di riuscire a sentire il battito del suo cuore, un battito
furioso, che potrebbe anche essere quello del mio
cuore. Provo a sfilare i piedi dagli stivali. Soprattutto
nessuna imprudenza, dato che inizia a mancarmi
l'aria. Di lato, devo provare a uscire da sotto la pecora
buttandomi di lato. Al diavolo sentirsi senza età, ora
che mi ritrovo come una bestia semiannegata sotto
un'altra bestia semiannegata. Dall'altra parte. A sinistra. Sollevare la spalla
sinistra nella speranza che la
pecora mi scivoli di dosso. Strano, d'un tratto vedo
Jaap che si allontana da me nuotando con le sue forti
bracciate e vedo me stesso che sbatto goffamente le
gambe e agito le braccia, la bocca spalancata, nella
quale spariscono grandi sorsi d'acqua dell'IJsselmeer.
Lava? Quest'acqua schifosa e puzzolente? Cosa c'è
da lavare?
I capelli ondeggiavano avanti e indietro come alghe.
Devo aprire la bocca, non posso farci niente.
Non vedo Henk, ma me stesso seduto nella Simca,
e i miei capelli ondeggiano avanti e indietro come
alghe, mentre Riet mi guarda dall'altra parte del finestrino. Non spaventata,
angosciata o in preda al panico. Sorride. Non fa neanche tutto quello che può
per aprire la portiera. Devo aprire la bocca. Non riesco a infilare le braccia
tra la mia pancia e la pecore anche se volessi provare a far rotolare la bestia
sopra la mia testa non ci riuscirei.
|