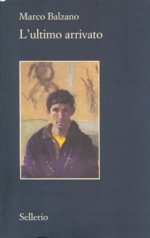
|
|
|
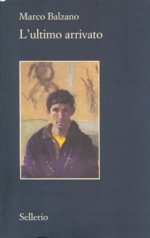
|
|
|
| << | < | > | >> |Pagina 13Prima di chiamarmi pelleossa mi chiamavano strillone, i bambini della scuola elementare di via dei Ginepri. Me li ricordo ancora tutti e trentaquattro, anche se la faccia che più mi è rimasta in testa è quella di Peppino, con quei capelli dritti da dita nella corrente. Insieme ci divertivamo a fottere la merenda di pane e mortadella a Ettore Ragusa, il figlio del macellaio. Quando se ne accorgeva tirava uno strillo più acuto dei miei e frignava a fontana. Io e Peppino, allora, andavamo lì con la bocca ancora bisunta e facevamo i dispiaciuti, «ma no, Toruccio... ma che si piange per fatti così piccoli?», «morto un panino se ne fa un altro, su!», queste frasi di consolazione gli dicevamo. Ogni tanto mi sentivo in colpa e chiedevo a Peppino se non stavamo esagerando. «Ma quale esagerazione! Quel cornuto è più largo che lungo e a casa trova tutti i giorni la pastasciutta. Tu che trovi?». «Acciughe» rispondevo io. Fino a nove anni ho vissuto di acciughe. Anzi, di un'acciuga al giorno. Me la rifilava mamma mia al mattino prendendola da un barattolo col sale rancido attaccato al vetro. La stiracchiava su una fetta di pane che lei chiamava «pane in cassetta» e mi diceva di stare alla larga dalla cucina fino a sera. «Smammare» ripeteva con un gesto da generale. Dopo un paio d'ore tendevo l'orecchio sulla pancia perché sentivo che da lì dentro uscivano rumori strani. Sgorghi, ragli, risucchi, non saprei come chiamarli. Così se qualcuno con le mie stesse calorie in corpo mi proponeva di andare a rubare, io subito ci stavo. Più facile era sgraffignare frutta dalle cassette di legno che le vecchie tenevano sulla soglia. Peppino distraeva la vecchia e io ficcavo pesche sotto la maglietta o nelle mutande. Complicato andare a rubare nelle case di un paio di paesani senza più cervello al seguito. Io di solito, visto che avevo una parlantina affilata, facevo da palo e Peppino, o Ciccillo o Berto o qualche altro affamato, mi passavano dietro la schiena per rovistare a casaccio dentro qualunque tiretto. A volte si usciva con un bottino niente male, ma nella maggior parte dei casi si raggranellavano cose da niente. Tozzi di pane, torroncini, qualche uovo da sucare. Difficile, infine, rubare nell'alimentari di Turuzzu, sia perché quel negozio era fetente e uno se ne voleva scappare prima ancora di metterci piede, sia perché Turuzzu era svelto e se ti beccava menava calci. Per arrischiarsi da lui bisognava avere nel sangue la pressione delle lucertole, altrimenti conveniva evitare. Nel tempo, però, ho realizzato che a San Cono in tanti seguivamo la stessa dieta e allora mi sono messo l'anima in pace. Tutti, presto o tardi, ci siamo messi l'anima in pace. Un'acciuga? E un'acciuga sia! Da picciriddi non ci si demoralizza mica così. Certo, finché andavo a scuola era un discorso. Stavo seduto al banco l'intera mattina, ascoltavo il maestro Vincenzo e la storia finiva li. Ma quando a mamma mia la notte del 10 ottobre 1959 venne il colpo apoplettico e rimase menomata per sempre, beh, non fu proprio la stessa cosa perché dovetti ritirarmi da scuola e filare in campagna con mio padre a fare lo jurnataru. Dopo Peppino, anche se non gliel'ho mai detto, la persona a cui volevo più bene era il maestro Vincenzo. Ero più affezionato a lui che a mio padre Rosario. Non solo perché non era noioso e non menava mazzate quando rientravo a casa con la giubba strappata o le ginocchia sbucciate, ma per le poesie che ci leggeva. Di Giovanni Pascoli specialmente. Non metteva mai fretta di capirle. Era prima di tutto una questione di musica. «Al senso ci penseremo dopo!» ripeteva quando noi bambocci facevamo certe facce da incomprensione. Dopo aver recitato marciando tra i banchi ordinava di trascrivere la poesia sul quaderno perché «ricopiare vuol dire imparare!», diceva col bastone in aria per farci stare muti. Il maestro Vincenzo era come un amico per me, non ci sono storie. Basta dire che ci vedevamo pure fuori scuola. Anzi, il sottoscritto era la prima persona che incontrava, visto che eravamo dirimpettai. L'appuntamento era all'angolo di via Archimede, alle sette e mezza. Io quando lo vedevo in lontananza sbattevo le mani sulle gambe per scuotere i peli del micio e correvo verso di lui. Gli dicevo subito che la versione in prosa non l'avevo fatta perché trasformare una poesia mi pareva una brutta operazione. Il maestro non ribatteva, mi domandava soltanto se l'avevo imparata. «Sicuro che l'ho imparata! Volete che ve la ripeto?». «Non adesso». «E mi metterete il brutto voto?». «Se non l'hai imparata sì». Ma quale brutto voto, io le poesie le sapevo tutte quante a menadito e pigliavo sempre Lodevole! Quando tornavo a casa sventagliavo in aria il quaderno per mostrare la sua scritta in penna rossa e reclamavo in premio un pezzo di cioccolata o il corrispettivo di piccioli per andarmela a comprare. Tutto questo, l'ho già detto, fino al 10 ottobre 1959, perché dopo non ci fu da reclamare più niente. Superata l'edicola di Rocco, il maestro si faceva guidare da me. Una volta comprata l'Unità non parlava più e camminava senza guardare. Allora, siccome al passaggio a livello di San Cono c'era già scappato il morto, gli prendevo il braccio come si fa coi ciechi. Quando era successo il fatto del morto ammazzato sotto il treno, il maestro aveva detto che dovevamo dispiacerci anche se non lo conoscevamo e sapevamo soltanto che la locomotiva lo aveva sbattuto lontano, lui, la bicicletta e il sacco di arance attaccato al manubrio. «Chi non si dispiace della morte di una persona è barbaro» disse in classe, e quando passò il carro funebre ci ordinò di interrompere il dettato per andare alla finestra a recitare una preghiera. Il maestro fu il primo a cui raccontai del colpo apoplettico di mamma mia. Quel mattino ero rimasto muto e non gli avevo manco pigliato il braccio al passaggio a livello. Quando finalmente mi guardò interrogativo, gli raccontai che era caduta per terra nel cuore della notte, una macchia di sangue nero gli si era formata sulla tempia e non se ne andava. Il maestro allora fermò il passo, ingoiò la saliva a fatica e mi disse tante cose importanti. Che però non mi ricordo più. | << | < | > | >> |Pagina 18Comunque non è che sono emigrato così, da un giorno all'altro. Non è che un picciriddu piglia e parte in quattro e quattr'otto. Prima mi hanno fatto venire a schifo tutte cose, ho collezionato litigate, digiuni, giornate di nervi impizzati, e solo dopo me ne sono andato via. Era la fine del '59, avevo nove anni e uno a quell'età preferirebbe sempre il suo paese, anche se è un cesso di paese e niente affatto quello dei balocchi. Ma c'è un limite a tutto e quando la miseria ti sembra un cavallone che ti vuole ingoiare è meglio che fai fagotto e te ne parti, punto e basta. Mamma mia stava ogni giorno più stordita. Il dottor Cucchi quando passava ripeteva le solite frasi sciacquate e dava da comprare certe medicine che non risolvevano un'acca ma che costavano una fucilata. Si dovevano mettere sotto la lingua quando le prendevano le crisi. Mio padre era diventato una corda di violino, tu lo pizzicavi e quello tirava mazzate. Per non correre rischi conveniva stargli più lontano della lunghezza del suo braccio. Lui rincasava all'ora che voleva e non diceva nemmeno buonasera. Se parlava, parlava per dire che usciva di nuovo. «Vado in piazza a camminare» mugugnava tirandosi la porta con la sigaretta in bocca. Ma, ovviamente, non andava in piazza a camminare. Andava a giocare a carte nello scantinato di uno che si chiamava Stefano. Finché, vacci uno vacci due vacci tre, gli prese la mania del tressette. So che ci andava perché una volta uscii scalzo e mi misi a seguirlo. Restai carponi a spiarlo dal vetro dello scantinato che affacciava sul marciapiede. Avevo voglia di suggerirgli le carte degli altri giocatori, ma anche senza suggerimenti mio padre vinceva, e anzi quei pochi piccioli che mi sono portato a Milano se li era guadagnati lì sotto, in quel posto col fumo galleggiante. Altri sono partiti solo con un boccaccio di ulive o col pane caldo, io invece avevo il mio bel gruzzoletto, anche se poi non l'ho potuto spendere. Però in paese, per questa storia delle carte, divenne odioso e le amicizie coi compari si guastarono in fretta. A uno a uno gli aveva fatto la pelle, mio padre, anche se poi non si è saputo frenare ed è rimasto gabbato. Quanto alle mazzate che certe sere mi tirava, invece, non c'è da filosofare troppo o da fare i sofisticati. I genitori a San Cono tiravano tutti mazzate, punto e basta. Come per il cielo è normale piovere, per una vacca muggire, per un albero far cadere le foglie, per un genitore di San Cono era naturale sganciare mazzate. Bastava tornare a casa che ti eri accapigliato e subito ne prendevi altre. «Com'è? Ti sei fatto picchiare? Ma che minchia di uomo diventerai?» e vai con la cintura. «Ti sei sporcato i pantaloni?» calci a ripetizione. «Ti sei fatto male?» zoccoli volanti. Gli zoccoli, in realtà, erano una specialità femminile, proprietà delle madri e di qualche sorella maggiore. Mamma mia, ad esempio, era una professionista dello zoccolo. Aveva la mira di un soldato. Riusciva a colpirti a distanza con una facilità impressionante. Certe volte, tanto era lo stupore che lo sentivo più prepotente del male. Gli bastava fissarti negli occhi con uno sguardo da tigre e lo zoccolo spiccava un volo di uccello, schivando i vasi e intrufolandosi tra le porte dietro le quali cercavo di ripararmi. Io ci ho rimesso un dente, ma ad alcuni amici è andata peggio. Una volta le ho prese pure perché sono andato a scuola. Mio padre, siccome la sera non mi aveva dato da mangiare, disse che potevo alzarmi più tardi. Così al risveglio pensai che non era più orario di jurnataru e senza dire niente presi per via dei Ginepri. Dalla contentezza mi fermai a chiedere in regalo un tarallo al forno di via Ruggero il Normanno. Da picciriddu sapevo fare di quegli occhi dolci! Anche farmi venire le lacrime finte sapevo, come un attore di Cinecittà. Le signore, infatti, ci cascavano sempre. Adesso invece ho questi occhi stretti stretti, a fessura, che sembra che hanno litigato col sole. Quel giorno di scuola ancora oggi non lo posso dimenticare. Appena entrato in classe, una delusione. Mi aspettavo una festa come quella del santo e invece, a parte Peppino che saltellava come un coniglio, nessuno mi considerò. Sembrava che non ero mai mancato. Solo Ettore venne a supplicarmi di non rubargli la merenda e di nuovo si mise a piangere come una femminuccia. Anche il maestro Vincenzo, quando entrò, non mi rivolse parola. Vedendomi seduto al mio posto corrugò la fronte, ma niente di più. Io allora pensai che la nostra amicizia era agli sgoccioli e me ne volevo scappare di corsa in campagna. Fece una lezione coi fiocchi, il maestro. Parlò di un signore che si chiamava Giangiacomo Russò e lo chiamò pensatore, una parola che non avevo mai sentito e che secondo il mio compagno di banco significava uno molto intelligente e che la sa lunga, mentre secondo Peppino indicava uno che il mattino si alza e non tiene una minchia da fare. Il maestro fece un disegno alla lavagna: due uomini. Uno stava in mezzo a un campo recintato e diceva «questo è mio!», l'altro stava in un campo senza recinto e non diceva niente. Il maestro ci fece ricopiare il suo disegno e poi spiegò che prima che quell'uomo dicesse «questo è mio!» non esisteva la società - caserme, ospedali, scuole, tribunali, carceri, banche - e tutti vivevano liberi, la natura era così generosa che ciò che cresceva spontaneamente bastava e non c'era bisogno di scannarsi per un boccone. Però poi quello disse «questo è mio!» e allora chi si è visto si è visto. Ognuno iniziò a imitarlo e al posto che sognare un paesaggio o una bella femmina iniziò a sognare recinti sempre più alti e mise porte con la serratura alle case e cani feroci ai cancelli. «Russò scrive che questa invenzione dei recinti si chiama proprietà privata» disse il maestro. Peppino alzò la mano per chiedere se questo signore era uno che nella vita russò molto e fece un grugnito col naso che ancora mi fa ridere a pensarci, sento nella testa un coro gioioso di picciriddi. | << | < | > | >> |Pagina 78Currado mi disse che dovevo essere felice della proposta di Ruggero e non piagnucchiare come un moccioso.«Chiedi piuttosto consiglio a tuo padre» mi suggerì. Ma mio padre Rosario, quando telefonai alla latteria di Gioacchino, mi ripeté semplicemente che il muratore è il più bel lavoro del mondo e se non accettavo vincevo il concorso di minchione numero uno. Così, il giorno dopo, tra una consegna e l'altra, mi presentai di malavoglia al cantiere. Il capomastro fu sbrigativo, disse quando si iniziava e quale sarebbe stata la mia mansione. La paga era due volte quella della lavanderia e a me non restò che accettare. Ruggero per incoraggiarmi disse: «Viene pure Evandro, sei fortunato». Capirai che fortuna. Evandro era l'unico che in locanda non parlava mai e avere un manico di scopa era la stessa cosa che avere Evandro, che per altro russava da far tremare il tetto. Quando lo dissi alla grassona lei gridò che ero proprio come gli altri napulì, anzi peggio, e mi ordinò di andare a sbrigare le consegne. Il sabato, al momento della paga, disse che soldi per me non ne aveva perché ero peggio degli altri napulì e la lasciavo in difficoltà. Io allora mi misi a gridare, ma lei gridava più forte, con una voce da corvo in calore, mi dava spintoni e urlava: «Screanzato disonesto!». Io disperato provai a fare i lucciconi finti e a convincerla che se mi dava pochissimo aumento restavo. Allora la grassona prima mi guardò da sopra gli occhiali, poi sbuffando promise che in futuro avrebbe fatto un ritocco alla paga. «Non sono mica una senza cuore» disse tirando occhiate anche alle altre ragazze. Finalmente mi diede la settimana di stipendio, poi ricaricò il cesto di tovaglie e mi disse: «Uè nani, cerchiamo di meritarcelo questo aumento».
È stato così che non ho salutato nemmeno la Maria
Rosa, la Elena, la Carmela e la Lucia. Dovevo per forza
agire in quella maniera se volevo la mia paga e quel poco
di liquidazione che meritavo. Ho infilato lo stipendio
in tasca, sono salito sulla bicicletta, e via! Un ridere mi
veniva mentre pedalavo a tutta birra! Una bella bicicletta
da uomo con tanto di lucchetto, un cesto di vimini, otto
tovaglie, due pigiami, tovaglioli a non finire! Se ero una
ragazza mi ero fatta il corredo. Mai mi sono sentito in
colpa per questo furto. E anche il maestro Vincenzo
non credo proprio che mi avrebbe rimproverato visto
che ci aveva parlato così bene dei briganti della Basilicata.
Il trasloco a Bollate l'ho fatto in bicicletta. Lunghissime e lunghissime pedalate con il cesto colmo di quei quattro vestiti che avevo e delle mie cianfrusaglie. Per arrivare a Bollate c'era da pedalare una decina di chilometri. Il paesaggio lì non c'entrava più niente con Milano. Terra, cielo, aria frizzante e niente più macchine, solo una Lambretta ogni tanto. Si vedevano contadini a lavoro, anche femmine, e io a vederle pensavo che allora la miseria c'era anche al nord, come in effetti c'era, perché dove ci sono femmine in mezzo ai campi lì c'è miseria. Andai ad abitare in una baracca molto bella. Più grande e spaziosa della locanda di viale Brianza. Si può dire che era simile alle baite di montagna dove adesso si va in villeggiatura, ma senza nessuna attrezzatura moderna. Anzi, non c'era neanche l'acqua corrente. Soltanto tavolo, sedie, stufa e un armadietto con le grucce. In quegli anni a Bollate e nei paesi di provincia si poteva comprare un appezzamento con pochi piccioli e costruire una baracca con la taverna. Infatti ne spuntavano come funghi, file e file. Gli uomini le costruivano dopo il lavoro e nel fine settimana. Appena terminavano di tirarne su una arrivavano col treno del sole donne e picciriddi lasciati al paese e si sentiva festa per la strada e voci alte fino a tarda notte. Nelle taverne, invece, stavamo in affitto noi squadre di carpentieri. Era una sistemazione sempre arrangiata, si capisce, ma non si stava pigiati come negli stanzoni delle locande milanesi. Adesso queste baracche non ci sono più. Non ne è rimasta traccia perché la fatica dei poveri cristi non lascia mai traccia. Non ne rimane testimonianza nemmeno nei libri di scuola, dove si legge soltanto del re e la regina. In taverna stavo sempre per i fatti miei. I calabresi erano gente muta e noiosa. Facevano la stessa vita degli animali. Il massimo del divertimento per loro erano le gare di rutti con la birra. Chissà, forse è stata proprio quella solitudine nella baracca di Bollate a farmi capire che dovevo darmi una mossa e cominciare a interessarmi alle donne. In siciliano si dice fimmine, ma il maestro Vincenzo un giorno ci spiegò che è dispregiativo, perché fimmina è anche una vacca o una scrofa, mentre per distinguere rispettosamente gli esseri umani bisogna dire donne. Anche se una è racchia o assomiglia in tutto e per tutto a una scrofa, lo stesso si dice donna. Comunque, a me nella baracca la solitudine mi aveva fatto venire voglia di amare perché quando uno sa tenere a braccetto una donna non è più solo e non è nemmeno più picciriddu. Diventa adulto. Uomo fatto e finito. | << | < | > | >> |Pagina 120Maddalena è da subito contraria. Figuriamoci. Io però la sera stessa comincio e la sensazione immediata è quella di vivere in un film in cui il protagonista è uno che non va mai avanti. Cambia la città, cambiano gli abitanti, cambiano i modi di fare, ma lui no. Da giovane come da vecchio fa la stessa cosa: va in giro a consegnare merce. Lui ci prova a cambiare la sua vita, ma quella, vuoi per sortilegio vuoi perché lui commette ogni volta gli stessi errori, resta sempre ferma e sempre uguale. Non so dire bene da dove arriva l'infelicità che mi strozza un po' la gola mentre col motorino di «Non solo pizza» spernacchio in giro per Porta Garibaldi, l'Isola, piazza della Repubblica. Forse dal fatto di lavorare per degli extracomunitari, che però mi pagano dieci euro all'ora, più di un call center o di un'impresa di pulizie, e sono educati con me, mi hanno dato lavoro senza nemmeno il curriculum e senza chiedere la caparra come quell'aguzzina della grassona. Forse è quell'odore di forno a legna e di umidità che mi rimane appiccicato addosso al giubbotto. O forse è il rimorso che potevo vivere meglio. Non è vero che basta la buona volontà per girare pagina e ricominciare. Se vuoi una vita dove sei contento di alzarti al mattino non devi romperla mai, non devi mai sciuparla. Però chissenefotte della coscienza che borbotta, io quando non la sopporto più lavoro di polso e do una bella accelerata, la motoretta sgasa e il pensiero in qualche modo si sta più zitto.Karim e Magdy mi mandano a consegnare anche un solo panino. Non si tirano indietro di fronte a niente. L'altra sera hanno riacceso il forno a legna per una sola margherita a un signore che è entrato alle undici passate con i capelli bagnati di pioggia. Capita anche di mangiare insieme a fine serata, così, sulla mensola attaccata al muro. Nessuno di noi beve alcolici, loro perché sono musulmani io perché sono astemio. Ci scoliamo contenti delle buone bottiglie d'acqua gassata. Magdy mi ha raccontato che quest'estate, per la prima volta dopo sei anni, chiude per dieci giorni il negozio e torna in Egitto. «Prendo trecento chili di grano, lì costa meno ed è buono. E poi mio padre mi ha trovato moglie». «Ah sì? E sai già che ti piace?». Lui annuisce convinto e allora ripeto pure io il suo gesto e facciamo tutti e tre un brindisi con l'acqua. | << | < | > | >> |Pagina 152Se non avessi avuto quindici anni e quell'ingenuo entusiasmo che, all'idea di conquistare un posto coi libri, mi attraversava la spina dorsale, forse ci avrei fatto più caso ai tornelli dell'Alfa Romeo. Altro non sono che grate di cella. Si muovono come l'espositore girevole delle cartoline, ma di fatto sono sbarre e non lasciano scampo.Quell'otto maggio eravamo una decina a cominciare, tutti della mia età tranne uno di nome Goffredo, che aveva dieci anni in più. Non me li ricordo quei volti. Ci penso ogni tanto, ma non mi viene in mente niente. Le facce della fabbrica, tranne quella di Sergio, me le sono tutte scordate. In carcere, il tempo che non ho passato a ricordare l'ho trascorso a cancellare, sperando così di alleggerirmi la prigionia. Sergio era alto e robusto, con baffi folti. Indossava sempre una giacca di velluto color caffè. Nella tasca interna teneva arrotolato qualche giornale militante o fotocopie di opuscoli francesi, di quelli che in fabbrica non potevano circolare. Sergio era un tornitore, ma questo non è un fatto interessante perché qualunque mansione negli anni diventò uno stupido automatismo che trasformava il lavoratore in un sorvegliante di macchinari. La cosa interessante, invece, è che Sergio Radaelli, milanese sui cinquantacinque, era un sindacalista importante e coraggioso. Uno di quegli uomini con quindici palle. Aveva iniziato come forgiatore all'Alfa di Arese negli anni Quaranta e presto, per la parlantina e il carattere tenace, divenne conosciuto e rispettato anche dal dottor Mantovani, che pure se ne sarebbe sbarazzato volentieri. Non si vantava mai delle battaglie vinte, Sergio, non diceva mai «io». Solo ricordava volentieri quando era riuscito a far avere in dotazione ai forgiatori il grembiule e i guanti di cuoio. Prima lavoravano con gli indumenti di tela e ogni due per tre gli operai si bruciavano il petto e le mani.
La prima settimana fummo affidati a lui. Mentre illustrava come controllare
la macchina che produceva torni paralleli mi faceva domande cercando di capire
se ero uno che si poteva coinvolgere nelle iniziative politiche
o se ero un crumiro. Subito mi spiegò che il lavoro era
dequalificante, usò questa parola, e che ormai bisognava
solamente stare dietro ai robot fino a che questi non ci
avrebbero per sempre confinato in soffitta come giocattoli vecchi.
|