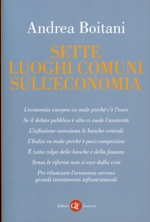
|
|
|
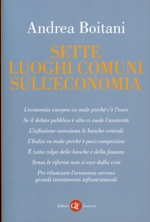
|
|
|
| << | < | > | >> |Indice
Prefazione IX
1. L'economia europea va male perché c'è l'euro 3
- Un grande successo?, p. 3
- I veri meriti dell'euro, p. 6
- Gli squilibri dietro le quinte, p. 9
- La crisi all'origine del luogo comune, p. 12
- Una crisi senza fine, p. 14
- La febbre greca e gli spread, p. 16
- Il «whatever it takes» di Draghi e le «visioni» tedesche, p. 19
- Un'idea strabica dell'equilibrio, p. 21
- L'illusione delle regole e la povertà della politica, p. 23
2. Se il debito pubblico è alto ci vuole l'austerità 27
- Una gelata dall'isola di Baffin, p. 27
- Alto debito, niente crescita?, p. 32
- Austerità espansiva?, p. 35
- Come il mito dell'austerità finì per crollare, p. 37
- Austerità punitiva, p. 42
- In ogni caso molti anelli non tengono, p. 45
3. L'inflazione ossessiona le banche centrali 51
- Il «mostro» dell'inflazione, p. 51
- Debiti e crediti, p. 53
- La preferenza per la stabilità (dei prezzi), p. 55
- All'origine dell'ossessione, p. 57
- La guerra di ieri, p. 61
- Facciamola non convenzionale, p. 65
- Soldi dall'elicottero?, p. 69
4. L'Italia va male perché è poco competitiva 73
- Orgoglio e pregiudizio, p. 73
- «Le parole sono importanti!», p. 76
- Esportare fa bene?, p. 79
- Importare fa bene?, p. 80
- «Hunger games» e competitività, p. 82
- Un patto corporativo ma non cooperativo, p. 87
- Achille e la tartaruga-sprint, p. 89
- Produttività e declino, p. 91
- Produttività e struttura industriale, p. 93
5. Θ tutta colpa delle banche e della finanza 97
- Due penny in banca, p. 97
- L'economia in bolla, p. 98
- Dammi una leva..., p. 101
- Bonus da favola e agenzie di rating da incubo, p. 105
- E la politica?, p. 106
- Il crollo della galassia centrale: breve cronistoria, p. 108
- Pantalone paga, ovvero il grande «bail out», p. 109
- L'intreccio coi debiti sovrani, p. 111
- Politica monetaria espansiva e regolazione restrittiva, p. 113
- Crediti deteriorati, p. 114
- Il problema sono le banche popolari e cooperative?, p. 117
- «Quale storia laggiù attende la fine»?, p. 120
6. Senza le riforme non si esce dalla crisi 123
- «Udite, udite, o rustici», p. 123
- Da Togliatti a Schδuble, p. 125
- A cosa dovrebbero servire le riforme strutturali, p. 127
- Come si misura l'efficacia delle riforme?, p. 131
- Fu vera gloria? L'Irlanda, la Grecia e le riforme, p. 137
- «Ma il troppo pieno simula il troppo vuoto», p. 139
- Roosevelt, Keynes e noi, p. 143
7. Per rilanciare l'economia servono grandi investimenti infrastrutturali 149
- Ritorno al futuro, p. 149
- Investimenti e austerità, p. 151
- La grande bellezza degli investimenti pubblici, p. 153
- Se non ora quando?, p. 156
- Calma e gesso, p. 158
- Il mito delle grandi opere civili, p. 161
- E se invece riducessimo le tasse?, p. 164
- Le ambizioni sbagliate del piano Junker, p. 167
- Una regola aurea?, p. 169
- Finanziamento monetario, iniziative nazionali e
la legge di Pappataci, p. 171
Poscritto. L'Unione monetaria ha bisogno di un bilancio federale 175
- La federazione che non c'è, p. 175
- Ma se il lavoro è mobile, qual piuma al vento..., p. 177
- A cosa serve una politica fiscale «federale», p. 179
- L'eclissi della politica fiscale, p. 181
- Una terza via, p. 183
Riferimenti bibliografici 187
|
| << | < | > | >> |Pagina 10L'accresciuta integrazione finanziaria ha consentito, nel primo decennio dell'euro, di finanziare i crescenti deficit di partite correnti dei paesi del Sud Europa. Quello delle partite correnti è un bilancio che registra importazioni ed esportazioni di beni e servizi e movimenti di reddito come i trasferimenti dei migranti. Tutte le somme che entrano nel paese (per esportazioni e redditi dall'estero) compaiono nel conto col segno più; quelle che escono (per importazioni e trasferimenti all'estero) compaiono col segno meno. Se le somme che escono sono maggiori di quelle che entrano c'è un deficit. E i deficit dei paesi del Sud EZ si ampliarono notevolmente proprio dopo l'avvio dell'euro e fino al 2008. I paesi del Nord dell'Eurozona qualche volta chiamati core, a indicare che sono il nucleo, il nocciolo duro dell'Area avevano, tutti insieme, un surplus di partite correnti di 14,5 miliardi nel 2000, arrivato a 311 miliardi nel 2007 (236 nel 2008). I paesi del Sud che nel gergo comune includono l'Irlanda e per i quali è invalso l'uso dell'acronimo PIIGS nel frattempo passavano da un passivo complessivo di 51 miliardi nel 2000 a uno di 317 miliardi nel 2008.
Ogni deficit di parte corrente significa che il paese spende
(per consumi, per investimenti, per opere e servizi pubblici)
più di quanto produca all'interno. Questo eccesso della spesa sulle risorse
disponibili all'interno di un paese è possibile
solo se quel che manca arriva dall'estero. A fornire le risorse
mancanti non possono che essere i paesi che spendono meno
rispetto alle risorse che producono, quindi i paesi con surplus
di partite correnti. E così è successo in Europa e, in particolare,
nell'Eurozona. I risparmi dei paesi del Nord, in surplus
di partite correnti, hanno finanziato le spese «in eccesso» dei
paesi del Sud. Gli squilibri di partite correnti lasciano anche
una pesante eredità, dal momento che ad ogni passivo corrisponde un aumento
dell'indebitamento finanziario verso l'estero e ad ogni attivo un aumento del
patrimonio finanziario estero detenuto. Così, le banche dei paesi del Nord EZ si
sono riempite di attività finanziare emesse da Stati, imprese
e banche del Sud EZ, facilitate dall'integrazione finanziaria
e dall'apparente assenza di rischi collegati ai paesi del Sud e
ai soggetti economici in essi residenti. Non c'è alcun giudizio
«morale» in quanto appena detto. Non è vero, cioè, che i paesi in surplus siano
virtuosi, in quanto «risparmiatori» e generosi, in quanto fornitori di fondi
finanziari agli scialacquatori in deficit. I flussi finanziari vanno alla
ricerca della miglior combinazione tra rendimento e rischio e il Sud Europa
offriva proprio quella combinazione. Se poi il rischio si è rivelato
più alto di quello stimato dai banchieri del Nord Europa non
è certo «colpa» dei paesi del Sud. Che questi avessero tassi di
inflazione più alti e (alcuni) avessero finanze pubbliche più
fragili rispetto ai paesi del Nord Europa era noto. Un errore
nella stima di un rischio è sempre «colpa» di chi lo compie.
La crisi all'origine del luogo comune
Nella tarda primavera del 2008, chi avesse detto che l'economia europea andava male a causa dell'euro sarebbe stato preso per matto o fortemente prevenuto. Primo perché non andava affatto così male e secondo perché, tutto sommato, l'euro aveva portato più vantaggi che svantaggi. Ma dietro la convergenza dei tassi d'interesse, dietro la rapida integrazione finanziaria, dietro la stabilità dei prezzi erano cresciute divergenze e squilibri tra le diverse economie dell'Eurozona. Divergenze e squilibri che dovevano far sentire i loro effetti con lo scoppio della crisi finanziaria ed economica. E dopo il crollo di Lehman Brothers, e soprattutto con l'esplosione della crisi dei debiti degli Stati europei nel 2010, che l'euro è stato sempre più percepito come la causa del cattivo funzionamento dell'economia, fino a che «l'economia europea va male perché c'è l'euro» è diventato un luogo comune, rafforzato nei paesi del Sud dall'esperienza di una recessione lunghissima e di una disoccupazione alta. E le file di coloro che sono a favore di un'uscita dall'euro sono andate ingrossandosi. Fino ai primi mesi del 2008 una buona parte dei cittadini europei credeva nelle istituzioni europee e magari senza condividere l'entusiasmo di Barroso riteneva che l'euro fosse stato un discreto successo. Nella rilevazione Eurobarometro di aprile 2008 la differenza tra la percentuale di persone che avevano fiducia nel Parlamento europeo e quella delle persone che non ne avevano superava í 30 punti; per la Commissione la differenza era positiva di 25 punti, più o meno come per la BCE. Si tratta di numeri non molto differenti da quelli rilevati nel gennaio 2002. La fiducia dei cittadini europei nell'Europa e nelle sue istituzioni ha cominciato a precipitare, guarda caso, nell'autunno del 2008 con le prime incertezze manifestatesi nella risposta alla crisi finanziaria. Secondo Eurobarometro, nella primavera del 2016 la differenza tra la percentuale di persone che, nell'Eurozona, hanno fiducia nel Parlamento europeo e quella delle persone che non ne hanno era negativa di 7 punti (40% ha fiducia, 47% no); la differenza tra chi ha e chi non ha fiducia nella Commissione è negativa di 11 punti (36% a 47%), mentre la differenza è diventata negativa di 19 punti (33% contro 52%) per quanto riguarda la fiducia nella BCE. Una bella caduta.
Cosa è successo? La risposta va ben oltre il luogo comune
e richiede di ripassare velocemente un po' di storia economica degli ultimi
anni. Il punto è che con la crisi sono emersi
tutti i difetti di costruzione dell'euro e delle istituzioni che lo
accompagnano. L'unione monetaria era stata pensata come
tappa di un lungo processo di unificazione del Vecchio Continente, una tappa che
(nelle intenzioni di Jacques Delors, presidente della Commissione europea nel
cruciale decennio 1985-1995) avrebbe dovuto spontaneamente portare a quella
successiva: l'unione politica e, quindi, fiscale. Purtroppo,
l'euro non era stato pensato per affrontare una crisi delle dimensioni e della
durata di quella che ha investito il mondo
dal 2008 e si è inasprita in Europa dopo il 2010. Forse si sperava che la
tempesta avrebbe aspettato l'irrobustimento della moneta unica con l'unione
politica. Ma la tempesta non ha aspettato. Ai difetti oggettivi si è aggiunta
poi la lettura della bufera che le massime autorità europee hanno dato,
soprattutto dopo il 2010. Secondo tale lettura, la crisi era l'inevitabile
risultato dell'eccesso di debito pubblico che affliggeva i
paesi del Sud. L'economista tedesco Hans Werner Sinn ama
ripetere che nei paesi del Sud era in corso una festa, ma non
ricorda come le bottiglie che tenevano viva la festa erano portate più dalle
banche del Nord che dai governi del Sud.
Una crisi senza fine
In paesi come Spagna, Irlanda e Portogallo, prima del 2008 il debito pubblico era basso o non molto alto (nel 2007 un rapporto debito/PIL intorno al 35% in Spagna, al 24% Irlanda, e al 68% in Portogallo), ma tra 2008 e 2010 era schizzato verso l'alto. Non perché in quei paesi governi spendaccioni avessero improvvisamente deciso di far vivere tutti al disopra delle proprie possibilità, ma perché, come abbiamo visto, le banche di quei paesi avevano prestato troppo a troppi (alimentando le rispettive bolle immobiliari) e adesso stavano fallendo a causa di una crescente montagna di crediti inesigibili: le imprese immobiliari non erano in grado di ripagare i crediti ottenuti per case che non riuscivano a vendere e i cui prezzi scendevano di giorno in giorno. E per salvare le banche, governi assai morigerati avevano rilevato i loro debiti iniettandovi soldi pubblici, ovviamente ottenuti emettendo titoli del debito pubblico. Del resto, se il debito non viene cancellato, quando deve forzatamente diminuire quello privato non può che aumentare quello pubblico. Dal momento che come ricordato nelle pagine precedenti una parte non trascurabile dei crediti offerti dalle banche spagnole, irlandesi e portoghesi era stata resa possibile dal finanziamento proveniente dalle banche tedesche e francesi, quando i governi di Spagna, Irlanda e Portogallo hanno salvato le proprie banche, hanno contribuito anche al salvataggio delle banche tedesche (e francesi), che avevano completamente sbagliato le loro valutazioni circa il rischio dei loro impieghi nei PIIGS. Una verità che suscita sempre nervosismo a Berlino (e un po' anche a Parigi), perché smentisce il mito della «generosità» dei risparmiatori del Nord Europa ed evidenzia che l'improvviso aumento del debito pubblico dei paesi del Sud dal 2009 è in buona parte attribuibile al salvataggio (indiretto) delle banche del Nord. Comunque, paesi con debito inizialmente basso hanno dovuto fare ricorso agli aiuti della cosiddetta Troika (il Fondo monetario internazionale, la BCE e la Commissione europea), mentre paesi ad alto debito (come il Belgio e l'Italia) se la sono cavata senza aiuti. In Irlanda, per esempio, il salvataggio del sistema bancario entrato in crisi nel 2008 per lo scoppio della bolla immobiliare che si era prodotta anche in quel paese è costato il 40% del PIL del 2013: non c'è da stupirsi che il rapporto tra debito pubblico e PIL sia cresciuto enormemente (120% nel 2013). Si obietterà che l'Italia aveva un debito pubblico alto già prima che scoppiasse la crisi e non certo a causa dei salvataggi bancari, mentre la Grecia era stata effettivamente spendacciona (un deficit pubblico passato da una media del 4,5% del PIL nel periodo 2000-2003 al 12% medio del biennio 2009-2010). In Grecia il costo del salvataggio delle banche è stato stimato pari al 22% del PIL 2013. Ma il rapporto tra debito e PIL, in Grecia, era alto già prima della crisi (107%) e il governo conservatore aveva dichiarato che il rapporto deficit/PIL sarebbe stato pari al 4% nel 2009, mentre, dopo le elezioni autunnali, il nuovo governo socialista (presieduto dall'economista Georges Papandreu) aveva scoperto che il rapporto deficit/PIL sarebbe stato del 13% (in effetti risultò di quasi il 16%). Ma la Grecia contava per circa il 2% del PIL dell'Eurozona: non può aver da sola mandato in crisi tutta l'area. Bisogna avere senso delle proporzioni. | << | < | > | >> |Pagina 22Colpa dell'euro? Sì e no. Sì perché senza moneta unica la svalutazione sarebbe possibile e ogni paese potrebbe avere il suo prestatore di ultima istanza. In effetti, paesi con livelli di debito e deficit pubblico (in rapporto al PIL) simili, come la Spagna e la Gran Bretagna, hanno avuto storie del tutto diverse dopo il 2010. Come mai? Semplice: la Gran Bretagna aveva una propria banca centrale e gli speculatori internazionali lo sapevano benissimo. Il tasso di interesse sul suo debito pubblico non è salito, né è salito lo spread con i titoli tedeschi. La Spagna invece, all'interno dell'Unione monetaria, non aveva la possibilità di ricorrere alla BCE, che non poteva (o non voleva) essere prestatore di ultima istanza di un paese in difficoltà. Perciò era vulnerabile a una crisi di liquidità, con investitori che ritiravano i propri capitali per reinvestirli in altri paesi dell'Area euro, facendo così impennare i tassi di interesse (e quindi lo spread) in Spagna.D'altra parte, non si può dire che sia colpa dell'euro in quanto tale, perché altre unioni monetarie non soffrono degli stessi problemi. Negli Stati Uniti parte crescente del debito pubblico è federale dai tempi di Hamilton (1789), cioè ben prima che il dollaro divenisse la moneta unica e che fosse fondata una banca centrale, la Federal Reserve System (FED, 1913). La FED può svolgere, quando necessario, il suo ruolo di prestatore di ultima istanza acquistando titoli federali, non dell'Alabama o del Wisconsin. I problemi relativi ai «trasferimenti» da uno Stato all'altro dell'Unione quando la Banca centrale acquista titoli pubblici neppure si pongono. Negli USA, dopo il 2008, si è lasciato crescere il debito pubblico federale senza il dramma degli spread, senza panico e senza che si minacciasse o richiedesse l'uscita di questo o quello dei 50 Stati dal dollaro. | << | < | > | >> |Pagina 24Colpa dell'euro? Cioè dell'unione monetaria in quanto tale? Di nuovo: no. Ci sono unioni monetarie che sono anche Stati federali, dove la politica fiscale macroeconomica quella che deve stabilizzare l'economia è svolta soprattutto a livello federale e che hanno assorbito la crisi molto meglio dell'Eurozona. Gli Stati Uniti d'America sono l'esempio più noto. Lì i cittadini degli Stati più colpiti dalla crisi, come la Florida dove la bolla immobiliare scoppiata era davvero enorme hanno potuto ricevere fondi dal bilancio federale senza scandali e senza che venissero sollevati dubbi di legittimità, come invece è accaduto in Eurolandia quando si è trattato di tirare fuori soldi per la Grecia, dal momento che si trattava di soldi tedeschi o austriaci oppure olandesi, non europei. L'economia europea, o meglio dell'Eurozona, non va male perché c'è l'euro, non cresce meno degli Stati Uniti e ha una disoccupazione più alta a causa dell'euro, ma perché l'esistenza dell'euro avrebbe richiesto più istituzioni e risorse federali e meno regole «tedesche».| << | < | > | >> |Pagina 27
Due cose sono infinite: l'universo
e la stupidità umana, ma riguardo
all'universo ho ancora dei dubbi.
Albert Einstein
Una gelata dall'isola di Baffin Il 5 e 6 febbraio 2010, in una cittadina dell'isola di Baffin (Canada) chiamata Iqaluit (che in lingua inuit significa «là dove ci sono i pesci», secondo Wikipedia) si tenne uno dei tanti summit dei ministri delle Finanze e dei banchieri centrali del G7, il gruppo dei paesi con la ricchezza più grande del mondo. La temperatura era di svariati gradi sotto lo zero. Il cibo più servito e meno gradito dagli ospiti, pare, carne di foca cruda. In quel summit i leader del mondo ricco (con il parziale dissenso degli Stati Uniti) concordarono che era venuto il momento di abbandonare lo «stimolo» all'economia, avviato dopo il fallimento di Lehman Brothers: bisognava passare al «consolidamento fiscale»; di più, all'austerità. Cioè a una consistente riduzione del deficit pubblico capace di avviare anche una continua riduzione del debito pubblico, costi quel che costi in termini di disoccupazione e di impoverimento dei già meno ricchi. Nel successivo summit del G20 a Toronto (26-27 giugno 2010) il presidente americano Obama rimase isolato nel sostenere che la ripresa era ancora fragile e che bisognava mantenere una politica di bilancio espansiva. Ma ormai anche l'Eurozona, guidata dalla Germania della cancelliera Merkel, aveva cambiato tono. I partiti conservatori vinsero le elezioni in Gran Bretagna e in Finlandia (nel 2011) con campagne elettorali basate sull'idea che lo Stato deve ridurre la sua sfera d'azione (e quindi ridurre spese e tasse) per dare al settore privato più spazio per crescere. [...] Dunque perché l'austerità? La ragione (ufficiale) fu la crescita del debito e del deficit pubblico, che aveva inevitabilmente accompagnato il salvataggio delle banche dopo il settembre 2008 e la contemporanea entrata in azione degli stabilizzatori automatici in Europa e del piano di stimolo di Obama negli Stati Uniti (circa il 2% del PIL americano nel 2009). Θ bene ricordare che, per un paese, la grandezza che conta veramente è il rapporto tra il debito pubblico e il PIL, perché ci fornisce la misura della sostenibilità del debito stesso, ovvero quanto è difficile ripagarlo versando anche gli interessi dovuti. Un po' come il peso del mutuo per una famiglia: dipende sì dall'entità del debito contratto ma anche dal reddito annuo cui la famiglia può attingere per pagare le rate. Il rapporto debito/PIL dell'Eurozona era passato dal 65% nel 2007 al 78% nel 2009, quello degli USA dal 63% nel 2007 all'83% nel 2009; in Giappone era cresciuto dal 167% al 194%. Le previsioni, poi, erano di un'ulteriore crescita tendenziale (cioè senza interventi correttivi) negli anni successivi. Nonostante queste impennate, i tassi di interesse erano rimasti abbastanza bassi, favoriti dalla politica monetaria delle banche centrali, che avevano portato rapidamente (un po' meno la BCE) i tassi d'interesse vicini allo zero. E quando i tassi sono bassi è un buon momento per avere un debito alto, poiché il suo costo è basso. Non erano né gli americani né i giapponesi a preoccuparsi, nonostante il livello straordinariamente elevato che il rapporto debito/PIL aveva raggiunto nel Sol Levante (nel 2014 quel rapporto sarebbe arrivato al 230%, senza disastri). [...] Nel mondo non c'era, né era in vista, alcuna crisi del debito e i tassi d'interesse così bassi sembravano, semmai, indicare un'abbondanza di fonti di finanziamento. In Eurolandia, però, si cominciava a temere che la crisi greca già aperta potesse estendersi agli altri paesi ad alto debito e a quelli il cui debito non era altissimo, ma era cresciuto molto rapidamente (come Spagna e Irlanda). Il timore era che questi paesi perdessero «l'accesso ai mercati», ovvero non fossero più in grado di collocare sui mercati le nuove emissioni di titoli necessarie a rifinanziare il loro crescente debito pubblico. O almeno così dice la versione dei fatti divenuta popolare successivamente. In realtà, come ormai sappiamo, era l'incapacità (vuoi per legge, vuoi per regole auto-inflitte) della BCE di fare il «prestatore di ultima istanza» (cioè di comprare i titoli degli Stati in difficoltà) a eccitare gli operatori finanziari e a rendere sempre più difficile l'accesso ai mercati per Spagna, Portogallo, Irlanda e Italia. D'altra parte, la controprova che il consolidamento fiscale non è inevitabile al fine di non perdere accesso ai mercati sta nel fatto che né Canada né Giappone decisero di passare all'austerità nel 2010 e né l'uno né l'altro paese hanno subito una reazione negativa dei mercati. Perché? Perché quei paesi hanno le loro banche centrali che possono agire da prestatori di ultima istanza e gli operatori finanziari lo sapevano benissimo. Sapevano, quindi, che quelle banche centrali avrebbero impedito il crollo dei prezzi dei titoli dei rispettivi Stati (e la contemporanea impennata dei tassi) e non provarono a sfidarne la «potenza di fuoco», ben consci di potersi bruciare, cioè di poter perdere i propri soldi. Insomma, la capacità di accesso ai mercati non è legata a una definita soglia del rapporto tra debito e PIL, ma dipende in modo cruciale da come si comporta la Banca centrale. | << | < | > | >> |Pagina 32Alto debito, niente crescita?La convinzione che non ci fosse alcuna alternativa è solo la base «materiale» del luogo comune per cui l'austerità è la risposta inevitabile a un debito pubblico troppo alto. Proprio tra il 2009 e il 2010 alcuni economisti fornirono la base «ideologica» del luogo comune. Alcuni degli argomenti sono complessi e perciò non posso che presentarli in modo iper-semplificato. Prima di vedere cosa dicevano gli apologeti dell'austerità, vale la pena ricordare che nel 1937 proprio mentre Roosevelt compiva la sua disastrosa svolta verso l'austerità fiscale John Maynard Keynes aveva ammonito che «la fase di espansione, non quella di recessione, è il momento giusto per l'austerità di bilancio». In effetti, secondo Keynes, quando un paese è in recessione o quando ne sta appena cominciando ad uscire e il tasso di interesse nominale è (vicino) a zero, l'economia si trova in una «trappola della liquidità», cioè in una situazione in cui una politica monetaria espansiva (come aumentare l'offerta di moneta) perde la sua efficacia, cioè non riesce a far scendere il tasso di interesse e stimolare i consumi e gli investimenti. Ciò accade in quanto il tasso nominale non può essere negativo (chi depositerebbe il suo denaro se il tasso di interesse nominale proposto dalle banche fosse negativo?) e l'inflazione realizzata e attesa risulta bassa o addirittura negativa (deflazione). Allora, il tasso di interesse reale non diventa negativo o non lo diventa abbastanza, le famiglie non sono sufficientemente scoraggiate dal depositare il proprio denaro in banca e non sono spinte a spenderlo per consumi. Lo stesso vale per le imprese: se il tasso reale non diventa sufficientemente negativo, rinviano al futuro le loro spese per investimenti produttivi. Questi rinvii di spesa di famiglie e imprese non permettono all'economia di riprendersi. In situazioni del genere, la ricetta suggerita da Keynes è di mettere mano alla leva fiscale, cioè aumentare la spesa e ridurre le tasse, in modo che nuova domanda pubblica sostituisca la carente domanda privata e che un po' più di reddito rimanga nelle tasche delle famiglie, reddito che si trasforma (in larga parte) in nuove spese. Soprattutto, si badi, se quel reddito addizionale rimanesse nelle tasche dei poveri (o meno ricchi), che spendono tutto o quasi il proprio reddito senza risparmiarne che frazioni piccolissime. Perciò, sono raccomandabili manovre che riducano le tasse sui redditi più bassi, da compensarsi (se è necessario limitare il deficit aggiuntivo) con un aumento del prelievo sui redditi più alti e sui patrimoni. Secondo Keynes (e la maggior parte degli economisti), nelle recessioni bisogna accettare un aumento del deficit di bilancio pubblico. Il consolidamento fiscale (che non è affatto escluso da Keynes, quando serve) va fatto nel momento in cui fa meno danni in termine di posti di lavoro persi, vale a dire quando la politica monetaria può essere abbastanza espansiva da compensare o almeno limitare l'impatto restrittivo della riduzione del deficit pubblico. In altri termini il consolidamento fiscale va rimandato a quando l'economia sia fuori dalla trappola della liquidità. Queste posizioni keynesiane si trovano in tutti i libri di testo standard di economia. La maggior parte degli economisti le condivide e quasi tutte le banche centrali utilizzano modelli che incorporano le principali intuizioni di Keynes sul funzionamento dell'economia nelle fasi di depressione. Molti si chiedono ancora oggi come sia potuto accadere che le indicazioni opposte di pochi ricercatori abbiano influenzato le decisioni di molti politici (soprattutto in Europa) e della BCE più delle indicazioni provenienti dalla maggioranza degli economisti. La ragione, probabilmente, è che spesso i banchieri centrali fanno da «mediatori» tra la ricerca economica e i politici, nel senso che i politici si fidano più di loro che degli economisti accademici (dopo tutto, i banchieri centrali vengono nominati dai politici, i professori no: almeno, non nel mondo libero). Tra i banchieri centrali è diffusa la paura che, se il deficit pubblico rimane ampio e il debito cresce, prima o poi i governanti chiederanno alle banche centrali di stampare moneta per finanziare gli Stati (monetizzazione del debito). E questo finirebbe, nel credo dei banchieri centrali, per portare sempre e comunque a un aumento dell'inflazione (ne parleremo nel capitolo 3). I banchieri centrali temono di perdere la loro fama di indipendenza se accettassero le richieste dei politici e di perdere le loro poltrone se le respingessero. Meglio evitare che si arrivi a una situazione così imbarazzante. L'esperienza ventennale del Giappone dove a una crescita abnorme del debito pubblico si è accompagnata la deflazione o un'inflazione dello zero virgola veniva ignorata: non avrebbe aiutato la causa dell'austerità.
Quale che sia la spiegazione, il terreno politico era pronto
ad accogliere un messaggio favorevole al «rigore fiscale». Inevitabile il
riferimento all'influente lavoro, reso pubblico nel 2010, di due economisti di
Harvard: Carmen Reinhart e Ken Rogoff. Questi avevano trovato, con un'analisi
empirica, una relazione tra livello del rapporto debito/PIL e crescita economica
relativamente a 20 economie avanzate, per il periodo 1946-2009. All'aumentare
del debito, il tasso di crescita di tali economie si riduce significativamente e
quando il rapporto debito/PIL supera il 90% il tasso di crescita diviene
negativo.
«Come minimo concludevano Reinhart e Rogoff questo
suggerisce che le questioni tradizionali relative al controllo
del debito dovrebbero essere in testa alle preoccupazioni politiche». Semplice,
chiaro, attraente per chi avesse già una
personale inclinazione per le politiche di austerità. Reinhart e Rogoff vennero
invitati a esporre i loro risultati nel corso
di un'audizione presso la Commissione Bilancio del Senato
americano e in numerosi articoli apparsi sui media di mezzo
mondo, sempre per sostenere la causa dell'austerità fiscale,
in nome della crescita. Mettete insieme il terrore del «contagio greco» e l'aura
negativa che Reinhart e Rogoff avevano creato intorno alla soglia del 90% ed
ecco due buone ragioni per l'austerità: non c'è alternativa se si vuole evitare
di finire come in Grecia e si vuole aiutare la crescita. Dato che per
ridurre il debito bisogna ridurre il deficit, non c'è alternativa all'austerità.
Austerità espansiva?
Alla vigilia del summit del G20 a Toronto, in un'intervista a «la Repubblica» (24 giugno 2010) l'allora presidente della BCE Jean Claude Trichet proclamò: «L'idea che misure di austerità possano innescare la stagnazione è scorretta [...]. In realtà, in queste circostanze, qualsiasi cosa possa accrescere la fiducia di famiglie, imprese e investitori circa la sostenibilità delle finanze pubbliche è un bene per il consolidamento della crescita e per la creazione di posti di lavoro. Credo fermamente che, nella situazione attuale, politiche che ispirino fiducia favoriranno e non ostacoleranno la ripresa economica, perché oggi la fiducia è il fattore cruciale». Non a caso, nello stesso giorno dell'intervista di Trichet, Wolfgang Schδuble il super-falco ministro delle Finanze tedesco pubblica un articolo sul «Financial Times», proclamando che la «spesa pubblica in deficit non può diventare una situazione permanente» e che la politica economica decisa dalla Germania si sarebbe potuta descrivere come «un consolidamento fiscale espansivo». Questo è, letteralmente, Keynes al rovescio: la fiducia verrebbe creata all'opposto di quanto pensava Keynes da una riduzione della domanda pubblica invece che da un suo aumento. Le imprese dovrebbero avere fiducia che la domanda da parte di consumatori e altre imprese aumenti mentre lo Stato riduce la sua spesa, cioè compra di meno e distribuisce meno redditi ai suoi dipendenti perché li licenzia o perché riduce le loro remunerazioni, oppure riduce il potere d'acquisto degli anziani tagliando le pensioni. Ovviamente, Trichet e Schδuble non pensavano a niente di così bislacco. Le loro affermazioni poggiavano sulla tesi elaborata soprattutto da un gruppo di economisti italiani nel corso degli anni Novanta del secolo scorso e divenuta nota come «austerità espansiva». Inizialmente la tesi poggiava sull'interpretazione di qualche evidenza empirica. Paesi come l'Irlanda e la Danimarca avevano attuato, negli anni Ottanta del secolo scorso, manovre fiscali molto restrittive per ridurre deficit e debito, ottenendo successivamente un ritorno della crescita economica. Si parlò di «effetti non keynesíani» della politica fiscale. Nell'ultima versione dell'austerità espansiva proposta da Alberto Alesina (professore ad Harvard come Reinhart e Rogoff) in una relazione presentata al meeting dell'Ecofin, a Madrid, nell'aprile del 2010 le aspettative giocano un ruolo cruciale. Innanzitutto, secondo Alesina, il consolidamento fiscale in un paese rende credibile una riduzione del debito e quindi gli operatori si convincono che quel paese eviterà il default. Perciò gli investitori penseranno che i titoli del debito di quel paese saranno meno rischiosi e richiederanno un tasso meno elevato per acquistarli e tenerli in portafoglio. La discesa del tasso sui titoli pubblici porterà con sé tassi più bassi sui crediti a famiglie e imprese che, quindi, potranno finanziare più facilmente le loro spese per consumi e investimenti. L'aspettativa di un futuro migliore porta a un presente migliore. Inoltre, se la stretta fiscale è abbastanza intensa e permanente nel tempo, gli operatori si convincono che è in atto un vero e proprio «cambio di regime», da uno Stato spendaccione a uno Stato parsimonioso e austero. E ciò li porta a credere che non ci saranno aumenti di tassazione in futuro (perché mai alzare le tasse se non c'è una maggior spesa da coprire?). Perciò i consumatori si convincono che in futuro saranno più ricchi e cominciano a spendere di più fin da subito, chiedendo soldi in prestito alle banche a tassi che saranno certamente bassi (per la ragione detta sopra). Di nuovo, l'aspettativa di un futuro migliore porta a un presente migliore. Infine (ma non è stata certo la cosa meno importante per i leader europei), una riduzione dei salari e/o del numero dei dipendenti pubblici finisce per spingere i sindacati a più miti consigli. Si ridurranno anche i salari dei lavoratori privati, che producono i beni e i servizi esportabili. Il che farà diminuire i prezzi di quei beni e servizi e ne aumenterà la competitività sui mercati internazionali, col risultato di far aumentare le esportazioni del paese «austero» a tutto vantaggio della sua crescita. La domanda aggiuntiva verrà dall'estero, se quella interna dovesse subire un calo iniziale, cioè prima che la fiducia ritrovata la faccia riprendere.
La relazione di Alesina all'Ecofin che le parole di Trichet echeggiavano
chiaramente rassicurava anche i ministri
europei che «la retorica sugli immensi costi sociali dell'aggiustamento fiscale
è sproporzionatamente gonfiata ed è
stata spesso usata in modo strategico da certi gruppi, non
necessariamente i più svantaggiati, per proteggere se stessi».
Insomma, l'austerità secondo questa visione non solo
sarebbe capace di ridurre rapidamente i deficit di bilancio
e il rapporto debito/PIL senza causare recessioni, ma non
comporterebbe neppure elevati costi sociali nel breve periodo. In definitiva una
ricetta semplice: per far «girare le aspettative» e far tornare la fiducia basta
ridurre il ruolo dello Stato. Soprattutto se, per realizzare il consolidamento
fiscale, si riducono le spese anziché aumentare le tasse a
spese invariate, aumento che finirebbe invece per ampliare
il ruolo dello Stato e non convincerebbe affatto gli operatori
che in futuro le tasse scenderanno, proprio perché le spese non sono diminuite.
Come il mito dell'austerità finì per crollare
In poco tempo i fatti e il lavoro di ricerca economica hanno finito per dimostrare che l'austerità era la risposta sbagliata ai problemi economici dell'Europa. Del resto, era già successo: l'austerità, dopo il 1929, aveva intrappolato le economie di mezzo mondo nella Grande Depressione per lungo tempo. Negli anni recenti, è stata di nuovo incapace di produrre la desiderata riduzione del rapporto debito/PIL e capacissima, invece, di far aumentare la disoccupazione e far peggiorare la recessione. Ancor prima che l'esperienza europea squadernasse i disastri pratici dell'austerità, a bruciare sono stati i suoi pilastri teorici, come navi in fiamme al largo dei bastioni di Orione. Ben presto (cioè già nel 2010) i risultati trovati da Reinhart e Rogoff si rivelarono basati su errori materiali e concettuali. Innanzitutto, il fatto che si trovi correlazione statistica tra due variabili come il tasso di crescita e il rapporto debito/PIL non ci dice cosa determini cosa, cioè se sia l'alto debito a causare la bassa crescita o sia la bassa crescita a generare l'alto debito. Θ il problema della «direzione di causalità»: si pone tutte le volte che viene osservata una correlazione statistica. Tenendo conto che il rapporto debito/PIL ha proprio il PIL al denominatore, può benissimo verificarsi che sia una bassa o negativa crescita del denominatore (cioè del PIL) a determinare un aumento del rapporto. Ma questa critica ebbe scarso impatto, all'inizio. Come ha notato il premio Nobel Paul Krugman , «per i sostenitori dell'austerità la storia di Reinhart e Rogoff era troppo buona per andare a controllare». La fine del mito arrivò nel 2013. Tre giovani e sconosciuti economisti dell'Università del Massachusetts hanno rifatto tutte le analisi con gli stessi dati e hanno trovato che i risultati di Reinhart e Rogoff erano materialmente sbagliati, nel senso che erano dovuti ad errori di calcolo e all'omissione di dati cruciali, quelli cioè relativi ad alcuni paesi che, dopo la seconda guerra mondiale, avevano sperimentato alto debito e alta crescita (Canada, Nuova Zelanda e Australia). Correggendo gli errori di calcolo, e tenendo conto dei dati che i due blasonati studiosi di Harvard avevano ingiustificatamente escluso, la magica soglia del 90% non c'è più. Gli effetti di un aumento del rapporto debito/PIL dall'85% al 90% sono minimi e alla fatidica soglia del 90% la crescita risulta ancora superiore al 2%! Le risposte di Reinhart e Rogoff alle critiche furono deboli ed evasive; il loro momento era passato. Analisi successive hanno poi mostrato che se una (debole) correlazione negativa tra debito e crescita c'era stata fino al 2007 nei paesi dell'Eurozona, la correlazione è del tutto scomparsa dal 2008 in avanti. Quando l'inganno fu palese, però, la frittata era ormai fatta. Anche il momento di Alesina è finito e forse era finito anche prima di quello dei suoi colleghi Reinhart e Rogoff. Innanzitutto, analisi più attente hanno mostrato che i campioni dell'austerità espansiva l'Irlanda, la Danimarca e l'Australia negli anni Ottanta non avevano raggiunto il successo grazie all'austerità, ma nonostante l'austerità, e in alcuni casi íl successo era stato effimero, oppure l'austerità era stata attuata dopo una fase espansiva, non dopo una recessiva. | << | < | > | >> |Pagina 42Austerità punitiva[...] Peggio ancora. Il consolidamento fiscale non ha avuto gli effetti sperati sul debito pubblico. Anzi, il rapporto debito/PIL è cresciuto di più proprio in quei paesi dove sono state attuate più intense politiche di consolidamento fiscale. Sempre escludendo la Grecia, viene fuori che per ogni punto percentuale di miglioramento del saldo primario aggiustato per il ciclo nel periodo 2011-2014, il rapporto debito/PIL è aumentato di oltre 5 punti in media nei paesi dell'Eurozona. La spiegazione più semplice è che l'austerità ha finito per far ridurre la crescita del PIL reale più di quanto abbia frenato la crescita del debito pubblico e perciò il rapporto tra debito e PIL è cresciuto di più proprio nei paesi che hanno fatto una più intensa cura di austerità. L'austerità, dunque, ha fatto sì ridurre il deficit primario (e in molti paesi anche quello complessivo), ma non ha permesso di migliorare il rapporto debito/PIL, e quindi non ha aiutato a migliorare la sostenibilità del debito. [...] L'ottimismo di Alesina è stato smentito dai fatti anche con riferimento ai costi sociali dell'austerity. Il reddito mediano (cioè quello che si trova esattamente in mezzo tra il 50% più povero e il 50% più ricco della popolazione) è diminuito in tutti i paesi sottoposti al trattamento, mentre il 10% più povero della popolazione, nel 2013, era assai più povero del 10% più povero nel 2009. In tutti questi paesi, tra 2010 e 2013 è anche cresciuta la quota della popolazione a rischio di povertà, che cioè rischia di non potersi più permettere di comprare neanche í beni e servizi che può comprare chi ha un reddito pari al 60% di quello mediano. La Grecia è stata il paese che ha sofferto di più con un aumento del 25% (dal 20 al 45) delle persone a rischio di povertà e, guarda caso, è stata il paese costretto a sorbire dosi più massicce di austerità. Ma anche in Portogallo, Spagna e Italia (per non parlare di Romania e Lituania) il rischio di povertà è aumentato. In generale, il mix di misure adottate per attuare il consolidamento fiscale ne influenza gli effetti distributivi: l'aumento delle tasse o il blocco degli stipendi pubblici (se gravano soprattutto sui redditi medio-alti) non implicano aumento della diseguaglianza, che invece è un portato di riduzioni della spesa pubblica concentrate sul welfare in senso ampio (prestazioni sanitarie e socio assistenziali, sussidi di disoccupazione e redditi minimi, ecc.). Ma certamente i costi sociali più alti e più iniquamente distribuiti sono da attribuirsi all'aumento della disoccupazione che l'austerità ha provocato. Alla fin fine, è stato il prolungato impatto (macroeconomico) recessivo a prevalere nella creazione di nuove povertà e nuove disuguaglianze. Qualcuno oggi dice che l'austerità sta pagando (sia pure molto in ritardo rispetto alle previsioni), perché alcuni paesi «austeri» nel 2015 sono tornati a crescere dello zero virgola... La Spagna è diventata per alcuni il campione dell'austerità benefica nel lungo periodo. In realtà, i numeri ci dicono che essa ha ancora oggi un livello di PIL reale inferiore a quello del 2007. Quindi, chi ne osanna la performance confonde livelli e tassi di crescita: un tasso di crescita positivo dello 0,5% annuo dopo un crollo del PIL pro capite di parecchi punti in pochi anni (tra 2008 e 2015 si tratta di 5 punti in Spagna e Portogallo, 8 in Finlandia, oltre 12 in Italia e oltre 25 in Grecia) non può certo essere considerato un successo. Inoltre, sempre i numeri ci dicono che la Spagna ha ripreso a crescere quando la stretta fiscale si è un po' allentata e la domanda interna ha smesso di diminuire (e questo vale pure per l'Italia), proprio come prevedibile sulla base di modelli keynesiani standard. In definitiva (è la battuta di Krugman), «anche se ti colpisci in testa ripetutamente con una mazza da baseball, ti senti meglio quando smetti».
«L'austerità scriveva
Enrico Berlinguer
nel 1977 a seconda dei contenuti che ha e delle forze che ne governano
l'attuazione, può essere adoperata o come strumento di
depressione economica, di repressione politica, di perpetuazione delle
ingiustizie sociali, oppure come occasione per
uno sviluppo economico e sociale nuovo, per un rigoroso
risanamento dello Stato, per una profonda trasformazione
dell'assetto della società, per la difesa ed espansione della
democrazia: in una parola come mezzo di giustizia e di liberazione dell'uomo e
di tutte le sue energie oggi mortificate, disperse, sprecate». In Europa è stata
adoperata nel primo modo. Il secondo non sappiamo ancora se sia destinato a
rimanere un sogno.
In ogni caso molti anelli non tengono
Chi crede al luogo comune che l'austerity sia la risposta giusta e inevitabile all'eccesso di debito pubblico si è avventurato a sostenere che il mancato successo di quella risposta nell'Eurozona sia dovuto alle dosi troppo piccole con cui la «medicina» è stata somministrata, dosi insufficienti a far «girare le aspettative» nella misura desiderata. Naturalmente, non c'è modo di sapere quale sia la dose giusta, e il rischio che coincida con quella che uccide il cavallo è molto elevato. Quando ha letto queste righe un mio amico (non economista) ha obiettato: «se hai molti debiti col macellaio, è difficile che lui ti dia altra carne a credito solo perché gli prometti che, mangiando più carne, guadagnerai forze e potrai portare più carriole, guadagnare di più e quindi ripagare tutti i tuoi debiti, vecchi e nuovi». Il punto, gli ho risposto, è che la saggezza del (singolo) commerciante non aiuta a capire i problemi economici di una nazione o di un gruppo di nazioni. In effetti, dai dati a disposizione sappiamo che i risultati, sotto vari punti di vista, sono stati tanto più negativi quanto maggiori le dosi di austerità propinate ai poveri ronzini della zona Sud dell'euro. E il buon senso economico ci dice anche che le banche centrali e i governi dovrebbero essere più lungimiranti dei macellai e capire meglio gli effetti «sistemici» delle loro scelte, ovvero gli effetti che le scelte di tutti i paesi (o di tutti i macellai) hanno sul sistema economico di un continente. [...] I numeri ci dicono che l'atteso aumento delle spese per consumi e per investimenti privati non c'è stato, soprattutto nei paesi del Sud dell'Eurozona dove la riduzione del deficit pubblico è stata più drastica. Solo le esportazioni sono aumentate un po', grazie alla maggiore competitività delle merci dei paesi dove il costo del lavoro diminuiva. La riduzione della spesa pubblica, lungi dal far posto a una maggior spesa privata interna, ha finito per deprimerla, proprio come ci dicono i libri di testo con basi teoriche keynesiane e al contrario di quanto previsto dalla dottrina dell'austerità espansiva. Evidentemente, su ciò che crea fiducia aveva ragione Keynes (e la maggioranza degli economisti) e avevano torto Alesina, Trichet e Schδuble. Aveva e ha ragione chi guarda ai fatti e usa teorie consolidate e non chi, per supportare la sua ideologia, si affida a modelli validi solo sull'isola che non c'è. | << | < | > | >> |Pagina 49Uno studio dell'estate 2015, firmato dal solito Olivier Blanchard, mostra come un aumento della spesa pubblica nei paesi del Nord avrebbe un effetto positivo e prolungato nel tempo tanto sulle economie del Nord quanto su quelle del Sud, riuscendo anche a far aumentare un po' l'inflazione in tutta l'Eurozona e quindi se la BCE mantenesse il tasso di interesse nominale vicino a zero a far diventare abbastanza negativo il tasso reale da stimolare la domanda di consumi e di investimenti tanto al Nord quanto al Sud. Tutti ne trarrebbero beneficio, sia nel Nord che nel Sud dell'Area euro. Bisogna, insomma, avviare un coordinamento serio delle politiche fiscali con un obiettivo di crescita per l'Area euro nel suo complesso. Il che non significa arrivare subito a un bilancio federale con un governo federale, che pure sarebbe la soluzione migliore e permanente. Significa solo disegnare e applicare politiche di buon senso, invece che affidarsi sempre e solo alle regole «stupide» (la definizione è di Romano Prodi, nel 2002) e, magari, scrivere anche regole intelligenti. Non è vietato.Alcuni sostengono che l'austerità è comunque necessaria, poiché non possiamo lasciare più debito alle generazioni future, che saranno inevitabilmente più povere di noi, perché ormai siamo destinati a una stagnazione secolare. I problemi con questo argomento sono (almeno) due. Il primo: come appena visto, è proprio l'austerità a far sì che il debito cresca (in rapporto al PIL) e il PIL ristagni. Θ con l'austerità, allora, che lasciamo più debito e più stagnazione ai nostri discendenti. Il secondo problema è che, se oggi spendessimo di più per le infrastrutture, l'istruzione, la ricerca e la conservazione dell'ambiente (anche in deficit), consegneremmo alle generazioni future un capitale fisico, tecnologico e umano maggiore (e meglio conservato), quindi una maggiore capacità produttiva (distrutta, in parte, dalla crisi e dall'austerità) e forse una più elevata crescita sostenibile, a fronte di un debito pubblico non maggiore e forse inferiore a quello di oggi.
Fuori dell'austerità, la stagnazione non è un destino; il futuro non è per
forza peggiore del passato. E forse potrebbe essere migliore.
|