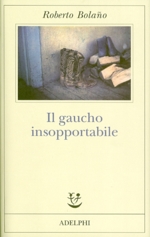
|
|
|
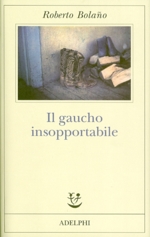
|
|
|
| << | < | > | >> |IndiceJim 13 Il gaucho insopportabile 17 Il poliziotto dei topi 49 Il viaggio di Alvaro Rousselot 79 Due racconti cattolici 103 Letteratura + malattia = malattia 121 I miti di Cthulhu 143 |
| << | < | > | >> |Pagina 13Tanti anni fa avevo un amico che si chiamava Jim e da allora non ho mai più visto un nordamericano così triste. Disperati ne ho visti molti. Tristi, come Jim, nessuno. Una volta se ne andò in Perù, un viaggio che doveva durare oltre sei mesi, ma lo rividi poco tempo dopo. Che cos'è la poesia, Jim?, gli domandavano i bambini mendicanti a città del Messico. Jim li ascoltava guardando le nuvole e poi si metteva a vomitare. Lessico, eloquenza, ricerca della verità. Epifania. Come quando ti appare la Madonna. In America centrale lo avevano aggredito diverse volte, cosa strana per uno che era stato un marine e aveva combattuto in Vietnam. Non voglio più menare le mani, diceva Jim. Ora sono un poeta e cerco lo straordinario per dirlo con parole normalissime. Tu credi che esistano parole normalissime? Io credo di sì, diceva Jim. Sua moglie era una poetessa chicana che minacciava, ogni tanto, di lasciarlo. Mi aveva mostrato una foto. Non era particolarmente bella. Il volto esprimeva sofferenza e da sotto la sofferenza spuntava la rabbia. La immaginavo in un appartamento di San Francisco o in una casa di Los Angeles, con le finestre chiuse e le tende aperte, seduta a tavola, a mangiare pezzettini di pancarrè e un piatto di minestra verde. A quanto pare a Jim piacevano le brune, le donne segrete della storia, diceva senza altre spiegazioni. A me, al contrario, piacevano le bionde. Una volta lo vidi che guardava i mangiafuoco nelle strade del DF. Lo vidi di spalle e non lo salutai, ma era chiaramente Jim. I capelli tagliati male, la camicia bianca e sporca, le spalle curve come se sentisse ancora il peso dello zaino. Il collo rosso, un collo che evocava, in qualche modo, un linciaggio in campagna, una campagna in bianco e nero, senza i cartelloni pubblicitari o le luci dei distributori di benzina, una campagna com'è o come dovrebbe essere la campagna: terreni a perdita d'occhio, casette di mattoni o blindate da cui siamo scappati e che aspettano il nostro ritorno. Jim aveva le mani in tasca. Il mangiafuoco agitava la torcia e rideva con ferocia. Il volto, annerito, diceva che poteva avere trentacinque anni come quindici. Non portava la camicia e una cicatrice gli saliva verticale dall'ombelico al petto. Ogni tanto si riempiva la bocca di liquido infiammabile e sputava una lunga serpe di fuoco. La gente lo guardava, apprezzava la sua bravura e poi tirava dritto, tranne Jim, che restava sul bordo del marciapiede, immobile, come in attesa di qualcos'altro dal mangiafuoco, il decimo segno da decifrare dopo i nove di rigore, oppure come se su quel volto nero di fuliggine avesse visto la faccia di un vecchio amico o di qualcuno che aveva ammazzato. Rimasi lì a guardarlo per un pezzo. Io allora avevo diciotto o diciannove anni e credevo di essere immortale. Se avessi saputo di non esserlo, avrei girato i tacchi e me ne sarei andato. Dopo un po' mi stancai di guardare la schiena di Jim e le smorfie del mangiafuoco. Così mi avvicinai e lo chiamai. Jim non parve sentirmi. Quando si voltò notai che aveva la faccia madida di sudore. Sembrava febbricitante e mi riconobbe a fatica: mi salutò con un cenno del capo e poi continuò a guardare il mangiafuoco. Appena gli arrivai accanto mi accorsi che stava piangendo. Probabilmente aveva anche la febbre. Scoprii pure, con meno stupore di quello con cui lo scrivo adesso, che il mangiafuoco stava lavorando esclusivamente per lui, come se tutti gli altri passanti di quell'angolo del DF non esistessero. Le fiammate, a volte, morivano a meno di un metro da dove stavamo. Ehi, gli dissi, vuoi farti arrostire per strada? Una battuta cretina, detta senza pensarci, ma di colpo mi resi conto che era esattamente quello che voleva Jim. Chingado, hechizado... chingado, hechizado era il ritornello, se non ricordo male, di una canzone di moda quell'anno in certi locali funky. E Jim sembrava proprio fottuto e stregato. La magia del Messico lo aveva vinto e ora guardava dritto in faccia i suoi fantasmi. Andiamocene, gli dissi. Gli chiesi anche se era drogato, se si sentiva male. Fece di no con la testa. Il mangiafuoco ci guardò. Poi, con le guance gonfie, come Eolo, il dio del vento, si avvicinò. Capii, in una frazione di secondo, che non sarebbe stato esattamente il vento a investirci. Andiamo, dissi, e con uno strattone lo tirai via dal bordo funesto di quel marciapiede. Sparimmo in fondo alla strada, verso Paseo de la Reforma, e poco dopo ci separammo. In tutto quel tempo Jim non aprì bocca. Non lo rividi mai più. | << | < | > | >> |Pagina 17a Rodrigo Fresán A giudizio di chi lo conobbe intimamente Héctor Pereda ebbe soprattutto due virtù: fu un padre di famiglia attento e tenero e un avvocato irreprensibile, di provata onestà, in un paese e in tempi in cui l'onestà non era, esattamente, di moda. Un esempio della prima virtù sono Bebe e Cuca Pereda, i suoi figli, che ebbero un'infanzia e un'adolescenza felici anche se più tardi, specie riguardo certi aspetti pratici, rinfacciarono a Pereda di aver loro occultato l'effettiva realtà delle cose. Sul suo mestiere di avvocato c'è ben poco da dire. Fece tanti soldi e si fece più amici che nemici, che non è poco, e quando ebbe la possibilità di diventare giudice o di candidarsi come deputato per un certo partito preferì, senza esitare, la carriera giudiziaria, dove avrebbe guadagnato, è risaputo, molti meno soldi di quelli che di sicuro avrebbe guadagnato nell'agone politico. Nel giro di tre anni, comunque, deluso dalla magistratura, abbandonò la vita pubblica e si dedicò, almeno per un periodo, che forse durò anni, alla lettura e ai viaggi. C'era stata, certo, anche una signora Pereda, Hirschman da signorina, di cui l'avvocato, raccontano, era follemente innamorato. Ci sono foto dell'epoca a testimoniarlo: in una si vede Pereda, in abito scuro, che balla un tango con una donna biondissima, quasi platino, la donna guarda l'obiettivo e sorride, gli occhi dell'avvocato, come gli occhi di un sonnambulo o di un vitello, guardano solo lei. Disgraziatamente, quando Cuca aveva cinque anni e Bebe sette, la signora Pereda mancò all'improvviso. Giovane vedovo, l'avvocato non si risposò più, anche se ebbe alcune amiche (mai fidanzate) abbastanza note nel suo ambiente e che per giunta avevano tutti i requisiti per diventare la nuova signora Pereda. Quando i due o tre amici intimi dell'avvocato lo interrogavano in merito, lui invariabilmente rispondeva che non voleva accollarsi il peso (insostenibile, dichiarava) di dare una matrigna ai suoi rampolli. Per Pereda, il grande problema dell'Argentina, dell'Argentina di quegli anni, era proprio il problema della matrigna. Noi argentini, diceva, non abbiamo mai avuto una madre, o nostra madre è rimasta invisibile, o nostra madre ci ha abbandonato sulla porta dell'orfanotrofio. Matrigne, invece, ne abbiamo avute fin troppe e di tutti i colori, a cominciare dalla grande matrigna peronista. E concludeva: Ne sappiamo più noi di matrigne di qualsiasi altra nazione latinoamericana. La sua vita, malgrado tutto, era una vita felice. È difficile, diceva, non essere felice a Buenos Aires, che è una combinazione perfetta di Parigi e Berlino, anche se in realtà, a ben guardare, è una combinazione perfetta di Lione e Praga. Tutti i giorni si alzava alla stessa ora dei suoi figli, con i quali faceva colazione e che poi accompagnava a scuola. Il resto della mattinata lo dedicava alla lettura dei giornali, ne leggeva invariabilmente almeno due, e dopo uno spuntino alle undici (composto in sostanza da carne e salumi e pane francese imburrato e due o tre bicchierini di vino argentino o cileno, tranne nelle grandi occasioni, in cui il vino era, tassativamente, francese) faceva un sonnellino fino all'una. Il pranzo, che consumava da solo nell'enorme sala da pranzo vuota, leggendo un libro sotto lo sguardo distratto della vecchia serva e gli occhi in bianco e nero della defunta moglie che lo fissava dalle foto nelle cornici di argento lavorato, era leggero, una minestrina, un po' di pesce e un po' di purè, che lui lasciava raffreddare nel piatto. Il pomeriggio aiutava i figli nei compiti o assisteva in silenzio alle lezioni di pianoforte di Cuca e alle lezioni di inglese e francese di Bebe, che due professori dai cognomi italiani venivano a impartire in casa. A volte, quando Cuca imparava a suonare un pezzo intero, arrivavano ad ascoltarla anche la serva e la cuoca, e l'avvocato, gonfio d'orgoglio, le sentiva mormorare parole di elogio, che lì per lì gli sembravano esagerate ma poi, ripensandoci, gli sembravano giustissime. La sera, dopo aver augurato la buonanotte ai figli e aver ricordato per l'ennesima volta alle domestiche di non aprire la porta a nessuno, se ne andava nel suo caffè preferito, in avenida Corrientes, dove poteva rimanere fino all'una, ma non oltre, ad ascoltare i suoi amici e gli amici dei suoi amici, che parlavano di cose che lui non conosceva e che se avesse conosciuto, sospettava, lo avrebbero annoiato a morte, e poi se ne tornava a casa, dove dormivano tutti. Un giorno però i figli crebbero e prima si sposò Cuca e se ne andò a vivere a Rio de Janeiro e poi Bebe si diede alla letteratura, ovvero trionfò nella letteratura, divenne uno scrittore di successo, cosa che riempiva di orgoglio Pereda, che leggeva dalla prima all'ultima riga tutte le pagine pubblicate dal figlio minore, il quale rimase in casa ancora qualche anno (dove stava meglio di così?), dopodiché, come già sua sorella prima di lui, spiccò il volo. All'inizio l'avvocato tentò di rassegnarsi alla solitudine. Ebbe una relazione con una vedova, viaggiò a lungo in Francia e in Italia, conobbe una ragazzina che si chiamava Rebeca, infine si accontentò di riordinare la sua vasta e disordinata biblioteca. Quando Bebe tornò dagli Stati Uniti, dove aveva lavorato per un anno all'università, trovò un uomo precocemente invecchiato. Preoccupato, il figlio si sforzò di non lasciarlo solo e a volte andavano al cinema o a teatro, dove l'avvocato di solito dormiva profondamente, mentre altre volte lo obbligava (ma solo all'inizio) a frequentare con lui il caffè El Làpiz Negro, un salotto letterario dove gli autori aureolati da qualche premio municipale dissertavano a lungo sui destini della patria. Pereda, che in questi salotti non aprì mai bocca, iniziò a interessarsi a quel che dicevano i colleghi di suo figlio. Quando parlavano di letteratura, francamente si annoiava. Per lui, i migliori scrittori argentini erano Borges e suo figlio, fine del discorso. Ma quando parlavano di politica nazionale e internazionale l'avvocato si irrigidiva come se gli stessero dando una scossa elettrica. Da allora le sue abitudini quotidiane cambiarono. Cominciò ad alzarsi presto e a cercare qualcosa fra i vecchi libri della sua biblioteca, ma non sapeva nemmeno lui cosa stava cercando. Passava le mattinate a leggere. Decise di rinunciare al vino e ai cibi troppo pesanti, perché capì che quella roba gli annebbiava il cervello. Cambiarono anche le sue abitudini igieniche. Non si tirava più a lucido come prima per uscire di casa. Ben presto smise di farsi la doccia quotidiana. Un giorno andò a leggere il giornale in un parco senza mettersi la cravatta. A volte i vecchi amici faticavano a riconoscere nel nuovo Pereda l'avvocato di un tempo, impeccabile sotto ogni aspetto. Un giorno si alzò più nervoso del solito. Pranzò con un giudice in pensione e con un giornalista in pensione e per tutto il pranzo non smise mai di ridere. Alla fine, mentre bevevano tutti una coppa di cognac, il giudice domandò a Pereda che cosa lo divertisse tanto. Buenos Aires affonda, rispose lui. Il vecchio giornalista pensò che l'avvocato fosse impazzito e gli raccomandò la spiaggia, il mare, l'aria tonificante. Il giudice, meno portato alle elucubrazioni, pensò che Pereda fosse partito per la tangente. Pochi giorni dopo, tuttavia, l'economia argentina precipitò. Furono congelati i conti correnti in dollari, chi non aveva portato i capitali (o i risparmi) all'estero si ritrovò di colpo con niente in mano, solo titoli, cambiali che a guardarle veniva la pelle d'oca, vaghe promesse ispirate per metà a un tango dimenticato e per metà alle parole dell'inno nazionale. Io l'avevo previsto, disse l'avvocato a chi volle ascoltarlo. Poi, accompagnato dalle sue due domestiche, fece quello che in quel momento fecero molti altri abitanti di Buenos Aires: lunghe code, lunghe chiacchierate con sconosciuti (che trovò simpaticissimi) in strade gremite di gente imbrogliata dallo Stato o dalle banche o da quel che era. Quando il presidente si dimise, Pereda partecipò alla cacerolada. Non fu l'unica forma di protesta. A volte le strade gli sembravano invase dai vecchi, vecchi di tutte le classi sociali, e questo, senza sapere perché, gli piaceva, gli sembrava il segno che qualcosa stava cambiando, che qualcosa si muoveva nel buio, anche se non evitava nemmeno le manifestazioni coi piqueteros che si trasformavano presto in tafferugli. Nell'arco di pochi giorni l'Argentina ebbe tre presidenti. A nessuno venne in mente di fare la rivoluzione, a nessun militare venne in mente di capeggiare un colpo di Stato. Fu allora che Pereda decise di tornare in campagna. Prima di partire parlò con la serva e la cuoca e gli espose il suo piano. Buenos Aires è marcia, disse, me ne vado nella tenuta. Parlarono per ore e ore, seduti al tavolo della cucina. La cuoca era stata nella tenuta tante volte quanto Pereda, che diceva sempre che la campagna non era posto per uno come lui, un padre di famiglia che aveva studiato e che si preoccupava di dare ai propri figli una buona istruzione. Nella sua memoria l'immagine stessa della tenuta era pian piano svanita fino a diventare una casa senza un centro, un albero enorme e minaccioso e un granaio dove si muovevano ombre che forse erano topi. Quella sera, però, mentre prendeva il tè in cucina, disse alle domestiche che praticamente non aveva più soldi per pagarle (aveva tutto nel corralito bancario, cioè aveva perso tutto) e che la sua proposta, l'unica che gli era venuta in mente, era di portarle con sé in campagna, dove almeno da mangiare, così voleva credere, non sarebbe mancato. La cuoca e la serva lo ascoltarono dispiaciute. L'avvocato a un certo punto della conversazione si mise a piangere. Per cercare di consolarlo gli dissero di non preoccuparsi per i soldi, che loro erano disposte a continuare a lavorare anche se non le pagava. L'avvocato si oppose in un modo che non ammetteva repliche. Non ho l'età per fare il pappone, disse con un sorriso che, alla sua maniera, chiedeva perdono. La mattina dopo fece la valigia e prese un taxi per andare alla stazione. Le donne lo salutarono dal marciapiede. Il viaggio in treno fu lungo e monotono, il che gli permise di riflettere con agio. All'inizio la carrozza era strapiena di gente. Gli argomenti di conversazione, da quanto poté sentire, erano fondamentalmente due: la situazione di bancarotta del paese e il livello di preparazione della squadra di calcio argentina in vista dei mondiali in Corea e Giappone. La calca gli ricordò i treni che lasciavano Mosca nel film Il dottor Zivago, che aveva visto anni prima, anche se sui treni russi di quel regista inglese la gente non parlava di hockey su ghiaccio né di sci. Siamo incorreggibili, pensò, ma fu d'accordo che, sulla carta, la nazionale argentina sembrava imbattibile. Quando scese la notte le chiacchiere si spensero e l'avvocato pensò ai suoi figli, Cuca e Bebe, entrambi all'estero, e pensò anche ad alcune donne che aveva conosciuto intimamente e che non credeva di ricordare ancora e invece spuntavano dall'oblio, silenziose, la pelle imperlata di sudore, infondendo nel suo spirito agitato una specie di serenità che non era serenità, un'inclinazione all'avventura che di nuovo non era esattamente quello, ma gli somigliava. Poi il treno cominciò a correre nella pampa e l'avvocato appoggiò la fronte al vetro freddo del finestrino e si assopì. | << | < | > | >> |Pagina 79a Carmen Pérez de Vega Lo strano caso di Álvaro Rousselot merita se non un posto di rilievo nell'antologia del mistero letterario, almeno la nostra attenzione o un minuto della nostra attenzione. Come senza dubbio ricorderanno tutti gli appassionati della letteratura argentina di metà Novecento, che non sono molti ma ci sono, Rousselot fu un prosatore ameno e prodigo di trame originali, con uno spagnolo ben costruito nel quale peraltro non mancavano, se l'intreccio lo richiedeva, le immersioni nel lunfardo, senza troppe complicazioni formali, o almeno così credevamo noi lettori più fedeli. Col tempo — personaggio più che sinistro il tempo, ed estremamente beffardo — la semplicità di Rousselot non ci sembra più tale. Può darsi che fosse complicato. Voglio dire, molto più complicato di quello che pensavamo. Ma c'è anche un'altra spiegazione: può darsi che Rousselot fosse solo l'ennesima vittima del caso. Capita, a coloro che amano la letteratura. In realtà, capita a chiunque ami qualcosa. Da ultimo diventiamo tutti vittime dell'oggetto della nostra adorazione, forse perché ogni passione tende - più velocemente delle altre emozioni umane - alla sua fine, forse per un'eccessiva frequentazione dell'oggetto del desiderio. Fatto sta che Rousselot amava la letteratura come tutti quelli della sua generazione e quelli della generazione precedente e successiva, cioè amava la letteratura senza farsi troppe illusioni al riguardo, come molti argentini. Con questo voglio dire che non era poi così diverso dagli altri, eppure agli altri, ai suoi pari, ai suoi compagni di piccole gioie o di martirio, non accadde nulla di nemmeno lontanamente simile. Giunti a questo punto si può presumere, con ogni ragione, che agli altri il destino riservasse il loro personale inferno, la loro propria singolarità. Angela Caputo, per esempio, si suicidò in modo inimmaginabile e nessuno che avesse letto le sue poesie, cariche di un'ambigua atmosfera infantile, sarebbe stato capace di predire una morte così atroce in mezzo a una scenografia calcolata al millimetro per suscitare terrore. Oppure Sánchez Brady, che scriveva testi ermetici e la cui vita fu troncata dai militari negli anni Settanta, quando ormai aveva superato la cinquantina e aveva perso ogni interesse nei confronti della letteratura (e del mondo). Morti e destini paradossali, che però non sminuiscono il destino di Rousselot, l'anomalia che avvolse impercettibilmente le sue giornate, la consapevolezza che il suo lavoro, cioè la sua scrittura, si collocava su una frontiera o raggiungeva un confine di cui lui ignorava quasi tutto. La sua storia ha una spiegazione semplice, forse perché in fondo è una storia semplice. Nel 1950, all'età di trent'anni, Rousselot pubblica il suo primo libro, dal titolo abbastanza laconico: Solitudine. Il romanzo racconta il trascorrere dei giorni in un penitenziario sperduto della Patagonia. Com'è naturale, abbondano le confessioni che rievocano vite passate, istanti di felicità perduti, e abbonda anche la violenza. A metà libro ci rendiamo conto che la maggior parte dei personaggi sono morti. Quando mancano solo trenta pagine alla fine, comprendiamo di colpo che sono tutti morti, tranne uno, ma non ci viene mai svelato qual è l'unico personaggio vivo. Il romanzo non ebbe molto successo a Buenos Aires, vendette meno di mille copie, ma grazie ad alcuni amici di Rousselot godette del privilegio di una traduzione in francese, nel 1954, presso una casa editrice di un certo prestigio. Solitudine, che nel paese di Victor Hugo si chiamava Le notti della pampa, passò inosservato se non si contano due critici letterari che lo recensirono, uno in modo amichevole, l'altro con un entusiasmo forse eccessivo, e poi si perse nel limbo degli ultimi scaffali o dei tavoli stracarichi delle librerie dell'usato. Alla fine del 1957, però, uscì un film, Le voci perdute, del regista francese Guy Morini, che per chiunque avesse letto il libro di Rousselot si rivelava un'abile rilettura di Solitudine. | << | < | > | >> |Pagina 128E dove diavolo è quel finocchio di Apollo? Apollo è malato, grave.
La poesia francese, come ben sanno i francesi, è la
poesia più alta dell'Ottocento e in qualche modo le
sue pagine e i suoi versi prefigurano i grandi problemi che l'Europa e la nostra
cultura occidentale si sarebbero trovate ad affrontare nel corso del Novecento e
che restano ancora oggi da risolvere. La rivoluzione, la morte, la noia e la
fuga possono essere i temi.
Questa grande poesia fu scritta da un pugno di poeti
e il suo punto di partenza non è Lamartine, né Hugo,
né Nerval, ma Baudelaire. Diciamo che inizia con
Baudelaire, raggiunge la sua massima tensione con
Lautréamont e Rimbaud, e finisce con Mallarmé. Naturalmente ci sono altri poeti
degni di nota, come Corbière o Verlaine, e altri non disprezzabili, come
Laforgue o Catulle Mendès o Charles Cros, e addirittura qualcuno non del tutto
disprezzabile come Banville. Ma la verità è che con Baudelaire, Lautréamont,
Rimbaud e Mallarmé ce n'è già a sufficienza. Cominciamo dall'ultimo. Voglio
dire, non dal più giovane ma dall'ultimo a morire, Mallarmé, che per soli due
anni non vide il Novecento. Scrive in
Brezza marina:
[...] Ma che cosa voleva dire Mallarmé quando disse che la carne è triste e che aveva già letto tutti i libri? Che aveva letto a sazietà e scopato a sazietà? Che a partire da un determinato momento ogni lettura e ogni atto carnale si trasformano in ripetizione? Che l'unica cosa che rimaneva era viaggiare? Che scopare e leggere, alla fine, diventava noioso, e che viaggiare era l'unica via d'uscita? Io credo che Mallarmé stesse parlando della malattia, della lotta che la malattia ingaggia contro la salute, due Stati o due potenze, come preferite, totalitari; io credo che Mallarmé stesse parlando della malattia rivestita coi panni della noia. [...] E ancor meno si può affermare che uno abbia già letto tutti i libri, perché anche se i libri sono in numero finito non si finisce mai di leggerli tutti, cosa che Mallarmé sapeva bene. I libri sono in numero finito, gli incontri sessuali sono in numero finito, ma il desiderio di leggere e di scopare è infinito, supera la nostra stessa morte, le nostre paure, le nostre speranze di pace. E cosa resta a Mallarmé in questa illustre poesia, quando non gli restano più, secondo lui, né la voglia di leggere né la voglia di scopare? Be', gli resta il viaggio, gli resta la voglia di viaggiare.
[...]
A viaggiare ci si ammala. Anticamente i medici raccomandavano ai loro pazienti, soprattutto a quelli che soffrivano di malattie nervose, di viaggiare. I pazienti, che in genere avevano soldi, obbedivano e si imbarcavano in lunghi viaggi che duravano mesi e talvolta anni. I poveri che avevano malattie nervose non viaggiavano. Alcuni, si presume, impazzivano. Ma anche quelli che viaggiavano impazzivano o, ancora peggio, man mano che cambiavano città, clima, abitudini alimentari prendevano nuove malattie. In realtà è più sano non viaggiare, è più sano non muoversi, non uscire mai di casa, stare ben coperti d'inverno e togliersi la sciarpa solo d'estate, è più sano non aprir bocca né batter ciglio, è più sano non respirare. [...]
Ma tutto arriva. I figli arrivano. I libri arrivano. La malattia arriva.
La fine del viaggio arriva.
La poesia di Baudelaire si chiama Il viaggio. La poesia è lunga e delirante, cioè possiede il delirio dell'estrema lucidità e non è questo il momento di leggerla tutta. | << | < | > | >> |Pagina 141Racconta Canetti nel suo libro su Kafka che il più grande scrittore del Novecento capì che i dadi erano tratti e che nulla ormai lo separava più dalla scrittura il giorno in cui per la prima volta sputò sangue. Che cosa intendo dire quando dico che nulla ormai lo separava più dalla sua scrittura? Sinceramente, non lo so bene. Intendo dire, suppongo, che Kafka capiva che i viaggi, il sesso e i libri sono strade che non portano da nessuna parte, eppure sono strade su cui bisogna spingersi e perdersi per ritrovarsi o per trovare qualcosa, qualunque cosa, un libro, un gesto, un oggetto perduto, per trovare qualunque cosa, forse un metodo, con un po' di fortuna il nuovo, quello che è sempre stato lì. | << | < | > | >> |Pagina 146Naturalmente è consigliabile accettare ed esigere, ci mancherebbe altro, l'esercizio indefesso della chiarezza e dell'amenità nel romanzo, arte che, diciamo, si sviluppa al margine dei movimenti che cambiano la storia e la storia privata, territorio esclusivo della scienza e della televisione, anche se a volte, allargando l'esigenza o il dettame del divertimento, della chiarezza, al saggio e alla filosofia, il risultato può essere a prima vista catastrofico pur mantenendo la sua potenza di promessa o continuando a essere, a medio termine, qualcosa di provvidenziale e desiderabile. Per esempio, il pensiero debole. Onestamente non so in che cosa sia consistito (o consista) il pensiero debole. Il suo promotore, mi sembra di ricordare, è stato un filosofo italiano del Novecento. Non ho mai letto un suo libro né un libro su di lui. Fra le altre ragioni, e non mi sto scusando, perché non avevo i soldi per comprarlo. Quindi devo averne di sicuro scoperto l'esistenza su qualche giornale. C'era un pensiero debole. Probabilmente il filosofo italiano è ancora vivo. Ma in fin dei conti questo italiano non importa. Forse intendeva dire altre cose quando parlava di pensiero debole. È probabile. L'importante è il titolo del libro. Così come, quando ci riferiamo al Don Chisciotte, non importa tanto il libro quanto il titolo e qualche mulino a vento. E quando ci riferiamo a Kafka non importano tanto (Dio mi perdoni) Kafka e il fuoco, quanto una signora o un signore dietro a uno sportello. (Questa si chiama concrezione, immagine trattenuta e metabolizzata dal nostro organismo, memoria storica, solidificarsi del caso e del destino). La forza del pensiero debole, l'ho intuito come se avessi avuto di colpo un capogiro, capogiro provocato dalla fame, stava nel fatto che si proponeva come metodo filosofico per gente poco versata nei sistemi filosofici. Pensiero debole per gente che appartiene alle classi deboli. Un operaio edile di Girona, che non si è mai seduto col suo Tractatus logico-philosophicus sul bordo dell'impalcatura, a trenta metri d'altezza, né lo ha riletto mentre mastica il suo panino al chope, potrebbe, con una buona campagna pubblicitaria, leggere il filosofo italiano o qualcuno dei suoi discepoli, la cui scrittura chiara e amena e intellegibile gli arriverebbe fino in fondo al cuore.| << | < | |