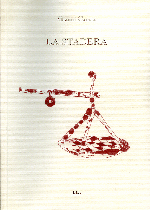
|
|
|
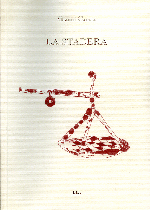
|
|
|
| << | < | > | >> |IndiceI giudici dell'ombra di Mario Marchisio 5 LA STADERA Autourghia - Una storia elvetica 9 Il rovescio naturale 21 Assassinio distributivo 37 L'impronta 51 Il ragionamento del Bloody Mary 67 Albanesi tutti appesi 75 Confessione di un brigatista 89 Sparwasser 111 Odio per l'odio 117 La corriera 125 Ate 131 L'appello al popolo 145 Gli ordini sono cambiati 153 Lettera dalla fine dell'Impero 161 Nota alle illustrazioni di Franca Cultrera 169 |
| << | < | > | >> |Pagina 9
Chi ha fatto subisca,
parola tre volte antica questo proclama.
Eschilo, Coefore
Una gigantesca bolla di livore avvolgeva le membra della città che da mezz'ora circa ristagnava nel suo torpore frenetico, cielo selciato solco di mota nera del fiume compressi dall'ovatta monocroma di quelle pareti biliose, accomunati da un blu di prussia che già marciva in un viola putrido; solo a risaltare, lungo i muri di banche, uffici e ditte, pavoni ancora per poco sonnolenti, le insegne di tanti decenni di paziente cesello, false e cortesi come quella gente che si salutava a voce sguaiata eppure senza superare il limite avito di un'ottusa compostezza, quasi per rafforzarsi nell'idea che anche quel freddo stampo denso color di aceto sulla città fosse parte del loro servizio quotidiano. In questa frenesia incipiente di rumori, anch'essi in certo modo composti nel loro caotico accavallarsi, si lanciava a passo lento e incerto Kaspar Weininger, puntuale alle 7.35 nel posteggio interno della sua palazzina; il gesto titubante con il quale le due dita della mano destra schiacciavano il labbro inferiore mal si accordava con il ritmo piatto dell'orologio che da un mattino immemorabile solcava da cima a fondo il suo corpo. Passeggiava uno sguardo un po' stranito sulla Toyota che cedeva fredda e invitante al suo sedersi, le mani e i piedi che da sé muovevano l'auto levigata e ossuta dai tratti svizzeri, a ben guardarla; già allacciato, chiuso nell'abitacolo che lasciava traspirare appena un sottile ronzio, scorreva senza accorgersene le cifre del contachilometri, e per la prima volta si trovò a pensare che quei giri ripetessero i chilometri della sua vita. Non si sorprese all'ondata di questo pensiero. Persino il motore, prima di avviarsi, si era incapricciato, rispondendo un'intrusione di raucedine alla sua mano malsicura. Non era di norma la carica alle lancette della sua giornata, aduso allo svolgersi insensibile del suo gomitolo non l'aveva mai attraversato l'idea di voltarsi indietro a considerare l'impiastro ordinato che aveva composto tutte le sue ore; il rombo puntuale lo confortava evitandogli di concepire una soluzione della continuità, che uno qualsiasi dei suoi giorni, tratto fuori dal piatto liquame di quell'impiastro, fosse proprio l'ultimo di una sequela impercettibile di fotocopie senza una matrice e potesse crearsi con le sue mani una curva del suo cammino, affacciandosi all'orlo di un altro tempo, vuoto e pauroso del suo fascino serpente. Ora le lancette sembravano muoversi a ritroso per recuperare i momenti di un fuso perduto, gli ingranaggi non tenevano: il giro a vuoto della chiavetta non era lo stento della variazione, enorme al presente ma impalpabile a uno sguardo che smarriva le tracce alle sue spalle sfumando l'asperità del caso; era l'inversione di rotta che lo portava a frugare le viscere malate di abitudine, ad aguzzare con rinnovato artiglio l'impietosa retrospezione piuttosto che posare la mente sullo stanco rettifilo del futuro prossimo. Questi cavalloni si abbattevano sulla rena spolpata della mente di Raspar Weininger, mentre tentava di circoscriverli al disco rosso del semaforo che lo fissava ambiguo nella potenza con cui forava il torbido pastello della città. Ed era la prima volta, certo, la prima volta che lo scarno quarantenne capelli radi e sussulti di vita remoti, impiegato da due lustri nell'ufficio della Leitchemie sulla Leibnizstra▀e veniva invaso da queste scariche inattuali come l'orizzonte vago che gli aveva sorriso il giorno del diploma, quando ancora non sapeva che quel cielo si sarebbe chiuso su di lui in un laccio di sopore e gli avrebbe preordinato un canone rettilineo donde poco a poco non avrebbe sceverato altro; ora invece una sottile vena, non del tutto seccata, lasciava sgorgare qualche rivolo di pensiero anomalo, tanto anomalo da fargli quasi male, una specie di dolore che nasceva dallo stesso piacere pungolo di sensazione bifronte, dove i due estremi si fondevano correndo dall'uno all'altro come lungo la corda di un arco: una sensazione indefinita, compagna del suo risveglio, che poteva collocare in quella fitta presso le costole, sulla sinistra all'altezza del cuore. Un colpo di clacson lo riportò per un attimo alla memoria della sua strada, ma subito dopo il dolore si infittì srotolando la sferza di altri pensieri. Vi galleggiavano sparsi i relitti del suo passato, tutte le ciliege amare masticate o ingoiate senza forza una dopo l'altra come vincolo inerte: la chiesetta di campagna in mezzo al pascolo in ossequio alla moda tutta urbana del matrimonio rustico, lo sciabordio festoso di campane perso nell'eco delle mucche, e poi Juliane dal bianco sorriso, un sorriso che non gli fu più dato di rintracciare, le vetrate invitanti nel giorno del primo ingresso in ditta che pareva mattino e non sapeva di inizio di tramonto; | << | < | > | >> |Pagina 67Appena li vide entrare intuì. Erano scesi da un'Honda Civic che avevano sbattuto proprio davanti all'ingresso, fuori dalle righe malgrado il parcheggio fosse quasi vuoto, proprio dove si protendeva la tettoia di cemento che recava l'insegna rosso scuro, quasi porpora del Bloody Mary, a lettere spietatamente squadrate. Non che l'avessero scritto in faccia chi erano, ma in un locale che sembrava creato apposta per quel punto senza vita nel mezzo del rettilineo, tra due curve strette come se obbligassero a rallentare per vederlo, un pub birreria con musica dal vivo nel weekend che era l'incrocio della gente più inquieta e più smaniosa d'altrove, a lavorare in un locale come quello, un edificio bianco e piatto con un po' di dehors per l'estate e la macchia sanguinolenta dell'insegna che spiccava nella notte, s'imparava presto a catalogare le facce, a riconoscerle al primo colpo e al primo colpo incasellarle, ciascuna nella sua categoria; cosi appena li vide entrare, quello al volante, piuttosto tarchiato, la faccia tristemente cattiva col pizzetto folto che gli dava un che d'intellettuale, i capelli un tempo corvini ora di un grigio fluente, un completo beige sulla camicia bianca senza cravatta; l'altro, smilzo e dagli scatti nervosi, con un giubbotto di jeans sopra pantaloni di un improbabile verde oliva, i capelli biondicci, radi sulla fronte, raccolti dietro la nuca in un accenno di coda; appena li vide entrare come se temessero di perdere un appuntamento, con la poca gente che c'era, anche se non aveva ancora avuto la prova il tipo del bar intuì. Andarono difilati verso di lui girando nel contempo lo sguardo tutt'intorno, anzi il tipo smilzo a un certo momento puntò quasi i piedi e fece per tracciare un'orbita sui suoi tacchi, poi riprese la direzione del bar. Il locale, una specie di rettangolo corto e largo, era immerso in una penembra da camera ardente; due luci rossastre, piuttosto soffocate che soffuse, disegnavano due flebili cerchi sul pavimento, al centro del rettangolo, mentre alcuni faretti giallognoli incombevano, a completare l'opera, sul bancone del bar in fondo, ancora deserto a quell'ora presta del venerdì sera, dove lui si affaccendava più per non stare fermo che per necessità. Come un rombo in lontananza pesava sul locale un sottofondo cupo, la voce sporca di Toni Waits raschiava dalla gola le sue ultime note imbarbarite dal whisky. Sedettero sugli sgabelli e in tutta scomodità si appoggiarono al bancone di finto marmo; le mani del tipo col pizzetto erano straordinariamente pelose, cespugli sgraziati fiorivano anche sulle dita, quelle del tipo con l'accenno di coda erano esili e lisce come la sua faccia dov'era appena un segno di peluria sotto il mento. Il tipo col pizzetto comandò gentilmente una birra piccola; la cadenza era fonda e triste come la barba che gli cresceva fin quasi agli occhi. «╚ perché vuoi restare lucido, vero?», disse l'altro col tono di una battuta che teneva in serbo per l'occasione. Qualche spruzzo di saliva si era depositato sul finto marmo. Poi comandò a sua volta un caffè sforzando un'uguale gentilezza. «Ma non sei già abbastanza nervoso?», fece di rimando il tipo col pizzetto. E ci risero su col gusto di aver ripetuto e sentito quello che volevano ripetere e sentirsi ripetere. Non ebbe più dubbi allora, anche sotto i loro modi gentili la natura si tradiva, aveva catalogato giusto. «Che razza di musica», disse il tipo con l'accenno di coda mentre il tipo del bar armeggiava alla macchinetta del caffè. «La conosci?» «Mai sentita». «Con questa musica del membro», il tipo con l'accenno di coda calcò l'ultima parola mirando con soddisfazione le consumazioni che arrivavano, «faranno scappare tutti. Non lo troveremo». «Sarà un brano per quando non c'è di gente. Del resto la musica è intonata al locale». Consumarono senza più parlare, l'uno svuotando il boccale di birra piccola con pochi e ampi sorsi, l'altro divorando il caffè e raccogliendo lo zucchero rimasto sul fondo col cucchiaino. Infine il tipo col pizzetto fece la richiesta che il tipo del bar aspettava. «Cerchiamo Tiberio Ciceri. Sappiamo che viene spesso qui. Sulla trentina, anche qualcosa di più, altezza media, capelli castani, porta gli occhiali; taciturno, veste trasandato...» «So chi dite. Non è ancora venuto stasera. Ma è ancora presto». «Sei proprio il barista adatto per questo locale. Bloody Mary, che specie di nome. Che cosa ti ricorda?», chiese rivolto al tipo col pizzetto. «Una robaccia imbevibile, fatta col pomodoro e qualcosa di piccante». «E proprio un nome del genere dovevano dargli?» Gli rispose la voce sideralè di Laurie Anderson, inusualmente contornata di fisarmonica e chitarra acustica. "Strange angels", cantava. "Here they come". «Già quelli che hanno per passatempo di andarsi a prendere qualcosa in un bar è gente da poco. Quelli che vengono qui, poi...» «Perché non chiedi ragione a lui, del nome?» «Buona idea. Scommetto le pudende», il tipo con l'accenno di coda calcò ancora il preteso eufemismo, «che non sa neanche perché il posto dove lavora si chiama così. E magari», la faccia glabra s'illuminò tutta, ne aveva scovata un'altra delle sue, «e magari adesso esce la padrona, una bonza dalle sinuosità cascanti, coi capelli lunghi e rossi, non quel rossiccio ramato, ma proprio rossi che sembra le abbiano rovesciato il sugo di pomodoro in testa, e l'amico, con la sua faccia da pesce bollito, la chiama: "Excuse me, Mrs. Bloody Mary?"». E qui stette ad aspettare l'effetto saltellando sul suo trespolo. Il tipo col pizzetto piegò il labbro a un accenno di sorriso forzato, appena visibile tra la peluria. «Mica per altro nel cinema usavano il pomodoro», intervenne il tipo del bar. «Quella roba è davvero imbevibile, pastosa come il sangue; se qualcuno la chiede gli spieghiamo bene di che si tratta, prima. Ma capita di rado. Io, poi, non la so fare». «Questo stordito mi ha triturato l'organo». Il tipo con l'accenno di coda represse appena un epiteto zoomorfo alla divinità che gli avrebbe rovinato tutto il gioco di schivare il turpiloquio; la sua voce era il soffio rabbioso di un gatto che stava per sfoderare le armi. «Fosse per me, comincerei da lui. Andiamocene, stasera non viene». «No, aspettiamo ancora», disse il tipo col pizzetto. «Non vedi che proprio adesso c'è un po' dì gente? E poi l'amico mi piace. Ragiona bene. Prenderei un'altra birra piccola». «Ma non dovevi mantenerti lucido?» «Mi serve per concentrarmi meglio. Tu non prendere altri caffè, che sei già abbastanza nervoso». Il tipo del bar aveva voltato le spalle ai due e spillava la birra. Con la coda dell'occhio sbirciava il tipo col pizzetto che fissava il boccale vuoto continuando a ripassarci il dito sull'orlo, gliel'aveva lasciato davanti proprìo per quel bisogno, mentre l'altro era sceso dal trespolo e lo squadrava torvo con le mani che grattavano le tasche del giubbotto. Quando tornò con la birra il tipo col pizzetto aveva già estratto i soldi delle consumazioni. «Stasera tocca a me», disse con un altro mezzo sorriso. «Sì, se viene tocca a te. ╚ il giro». «╚ il giro. Quando tocca». Mise il resto nel portafogli ordinando le banconote, poi tastò la birra con sorsi più brevi. «Ha ragione l'amico», disse rivolto al boccale. «Non si può fuggire. Neanche noi. Pensa se, ad esempio, ci rifiutassimo». L'altro sbuffava, frenando a stento la sua impazienza che non contemplava un'ipotesi del genere. Venne gente al bancone e il tipo del bar dovette abbandonarli. La musica non fu più un sottofondo, il volume era salito, come d'abitudine quando il locale cominciava a riempirsi. Ma restava un romorio ossessivo, un blues imbastardito che sembrava sempre al punto di svoltare e invece tornava senza speranza su se stesso; il continuo, angoscioso refrain sul quale i Savoy Brown sferragliavano il loro "Train to Nowhere". Il tipo del bar tornò da loro con un paio di bicchieri lavati in mano, facendo segno che non aveva più tempo da spendere, che il ragionamento era finito. «Aspettiamo ancora un poco», disse il tipo col pizzetto levando la sua faccia pelosa dal boccale. «Se viene ce lo indichi. Senza scherzi, s'intende», aggiunse col suo mezzo sorriso. «Siamo intesi. Non potrei evitarglielo comunque. Avrei solo una richiesta...» «Che cosa ancora?» «Non fatelo qui. Il sangue, costa fatica a lavarlo». | << | < | > | >> |Pagina 131
I ceppi si possono sciogliere, a questo è rimedio
e molti mezzi per liberarsi, invero;
ma d'uomo che sia marlo, quando la polvere
abbia bevuto il suo sangue, non è resurrezione.
Eschilo, Eumenidi
La strada poco illuminata era già fuori dal centro, tanto da non rassicurare ad affacciarsi nella sera tarda, per cosa che fosse. Un alito di rifiuti saliva dai cassonetti straccimi che contendevano alle auto qualche posto addosso ai marciapiedi, presso lo scheletro di una cabina telefonica sfasciata da anni. Seduto sugli scalini che davano alla porta di un palazzotto malandato, l'uomo cercava di leggere con molta pena un libro alla povera luce pendente sopra l'ingresso. Il volto provato dalle rughe e le guance scavate indicavano un'età sulla sessantina, malgrado i capelli ancora neri e folti; vestiva un cappotto gualcito, pantaloni consunti con qualche rattoppo e scarpe impolverate che si aprivano sul davanti. Doveva essere stata roba di una certa eleganza, un tempo. Da un lato della via cresceva un vociare sguaiato e pian piano emersero dalla sera quattro giovani con giubbotti e pantaloni presso che uguali come un'uniforme; gridavano forte per sovrastarsi l'un l'altro, intercalando le loro parole di nulla con bestemmie gratuite. Uno dei quattro, che chiamavano Lillo, camminava un poco avanti e si dava l'aria di essere il più importante; faccia squadrata, fremeva tra i denti e i pugni serrati le sue battutacce, sazio delle punture con che lo attizzavano i compagni. Il pungiglione più attivo, che chiamavano Cano, dondolava la sua mole d'orso in un'andatura curva e stupida come i suoi occhi dilatati nel buio. Degli altri due, uno, che chiamavano Willy, fronte precocemente stempiata e sguardo di una viva tristezza, tradiva una certa forzatura nel turpiloquio ricercato; l'ultimo, che chiamavano Giasti, faccia magrolina e cattiva, si limitava a ridere e incassare insulti. Erano evidentemente in cerca di qualche numero senza pericolo, forti dell'esca offerta dalle loro grida e dall'abito uniforme, con tutti i colletti girati in alto. All'improvviso il giovane che aveva l'aria di essere il più importante si fermò alla vista dell'uomo e tacque; di riflesso tacquero gli altri tre, si diedero d'intesa con una rapida occhiata e in minaccioso silenzio si avvicinarono, certi di aver trovato. «Dai che ci divertiamo un po', con questo qui», attaccò Lillo. «Sì, dai che salviamo la serata», riecheggiò Cano dalle sue spalle curve. Lillo si avvicinò all'uomo con fare di scherno. «Guardate qui il tipo. Vuoi un po' di luce per leggere?» «Avessimo benzina... così col fuoco riesce a leggere davvero», disse Giasti accendendo la faccia magrolina e cattiva. L'uomo girò pagina come se niente fosse. «Hai sentito, barbone?», eruppe Cano. «Ti ha fatto una domanda. E non è educazione non rispondere». Gli altri risero becero. «Non ha recepito», disse il giovane dallo sguardo più vivo. «Ora lo faccio recepire io», gridò Lillo, e sferrò all'uomo un calcio nelle gambe che lo girò di lato, suscitando l'ovazione dei compagni che lo incoraggiarono a replicare. Il libro cadde a terra restando aperto, con la copertina verso l'alto. «Dico a te, mangiamerda! Non penserai di scapparci... e il prossimo è nei denti, se non ti comporti bene». «Avremmo dovuto portarci della benzina», ripetè Giasti ringalluzzito. «Chissà che libro leggeva, poi», disse Cano. Lo raccattò grossolanamente da terra e guardò la copertina. «I dinosauri e la legge», compitò con ostentazione. «Che titolo!» «Roba da uno come lui», disse Giasti. «O come te. Dinosauri: corpo grosso e cervello piccolo...» Cano gli rispose un pugno alla spalla che lo fece indietreggiare di due passi, provocando un piagnucolio finto. «Da' qua». Lillo tolse con forza il libro dalle mani di Cano e lo gettò sulla faccia dell'uomo, che tranquillo lo ricompose accanto a sé. «E cosa ci fai con questo libro? Pensi che ti salverà la tua faccia di cazzo?» E accennò a mettersi in posa per colpire di nuovo. «Cerco il diritto; di capire il diritto, dov'è», esordì tranquillamente l'uomo, alzando la testa. «Sentito?», disse Willy. «Ha anche una voce! Da dove l'hai tirata fuori?» «E cosa ci fai con la tua voce?», digrignò Lillo. «Ti difenderai con quella?» «Dai Lillo, sfasciagli le ossa!», saltellò Giasti. Da sopra l'anta di una persiana si aprì per richiudersi in tutta fretta.
«Non vi converrebbe». Con la sua tranquillità l'uomo mise la mano sinistra
in una tasca del cappotto gualcito; solo allora i quattro vi notarono un
rigonfiamento.
[...]
«Dunque. il dio capisce che tutti questi atti non s'accordano tra loro quanto a giustizia: la giusta follia mandata per punire la superbia di un mortale provoca la giusta vendetta di una madre, che però è nello stesso tempo adulterio e omicidio, e non più giusta appare la vendetta che ne consegue. Sangue reclama sangue, e sempre un nuovo torto si aggiunge agli altri. ╚ necessario un nuovo diritto, che rimedi a tutto e non lasci nulla d'invendicato, un diritto che elimini alla radice il sangue e la vendetta; e a questo il dio interviene, per porre fine a quanto egli stesso ha causato, o almeno incominciato». «E non potevano arrivarci gli uomini?», chiese stizzito Cano. «Dovevano sempre tirare in ballo questo dio?» «Gli uomini non arrivavano a tanto. Andare sempre indietro a ricercare l'atto primo, era solo un continuo rotolarsi nei propri delitti. Da un dio ha avuto inizio, e un dio deve rimediare; la faccenda è troppo grande perché un mortale possa giudicarla. Così il dio istituisce un tribunale, al quale siano esposte le ragioni dell'una e dell'altra parte, lo dichiara sacro e gli affida di giudicare dei fatti di sangue per il tempo a venire; un consiglio di uomini scelti per la loro equità e del tutto estranei a quanto giudicano. ╚ la fine delle vendette che muovono da un singolo, o da una singola causa, una sentenza sostituisce il sangue reclamato dal sangue. Perché anche la vita pretesa secondo giustizia dal tribunale non esige altra riparazione; e ciò accade solo nei casi estremi». «D'accordo, ma come finisce la storia?», intervenne Giasti. «Il matricida subisce un vero processo: le cagne, o la sua coscienza se vogliamo è l'accusa, il dio presiede il tribunale». «E non ci sono avvocati?» «No, il giovane si difende da sé». «Meglio cosi, senza avvocati di mezzo». L'uomo sorrise leggermente. «Accusato di aver tolto la vita a colei che gli aveva dato la vita, il matricida si difende ricordando il crimine della madre, il tradimento e la complicità nell'assassinio, invoca il consiglio del dio nel l'aver compiuto vendetta; gli viene ricordato che la madre a sua volta vendicava un crimine non meno infame...» «Falla corta: come finisce?», lo interruppe ancora Giasti. «I giudici votano, e il dio con loro, deponendo in un'urna una pietra bianca, se inclinano all'innocenza, nera se sono per la colpevolezza. Alla conta metà delle sentenze è favorevole, metà della parte contraria; per ultimo il dio da la sua sentenza a favore del giovane, che così è assolto dalla colpa. Le cagne cessano di dilaniarlo e accettano di mettersi al servizio del nuovo diritto; e da allora gli uomini hanno un tribunale che li garantisce dalle vendette ma nello stesso tempo li trattiene dal commettere ingiustizia». «Eh, non c'erano ancora gli avvocati...», ripetè Giasti col suo risolino magro. Willy schiacciò la cicca con la scarpa, e rialzò la testa all'uomo. «E dimmi un po': oggi dove possiamo trovare un diritto simile?» «Dentro di noi, stimolando questo dio che dev'essere in noi. O scommettendo che la legge d'oggi continui la sua rovina finché si senta di nuovo l'esigenza di fermarla, o piuttosto di rifondarla da capo». «Intendi che fuori dalla tua storia il diritto che ci hai raccontato non c'è?» «Per niente, e quel ch'è più nel tempo in cui dovrebbe essere stato tolto l'arbitrio del torto». «Cioè oggi non è possibile ottenere il diritto?» «Più per un caso che per una sincera volontà. Le mille vie di fuga che la legge regala, tanto più larghe quanto più è la colpa, e lo spettacolo che le si fa attorno anche da chi sarebbe comandato a esercitarla e la riduce a proscenio, ostano a che il diritto s'imponga nella sua verità. Ma se l'arbitrio del torto vince, se la legge viene condotta al peggio, alla sua catastrofe, può darsi che torni a vincere anche l'antico rimedio, sangue al sangue. Donde per reazione risorgerà il diritto, questa è la vera speranza». «Quindi dovremmo continuare a recarci offesa secondo la legge d'oggi finché a qualcuno, o un po' a tutti verrà l'idea che il meglio è regolare le cose diversamente, riattingendo al diritto che dici?» «Proprio così. Tornare indietro, è più difficile. Più che rischiare questa scommessa». La triste curiosità di Willy appariva ristorata. «Ma mi dica, Lei che cos'è? Un poeta, un ex giudice...» «Sono solo un dinosauro, che s'ostina a cercare il diritto scommettendolo da antiche storie». Cano e Giasti sì alzarono tra il divertito e il deluso, ma anche in loro sembrava muovere una certa inquietudine. Con più lentezza si alzò anche Willy, con una faccia come di scusa. «Beh, mi dispiace per prima. Chi sa che la sua storia non riaccada. Adesso andiamo, l'abbiamo infastidita abbastanza». Cano era rientrato in sé, e aspirava la boccata di una nuova sigaretta per sfida. «Se ci incontriamo di nuovo, non ti assicuro...» «Nemmeno io; siamo sotto questa legge», disse piano l'uomo. «Dipenderà solo da noi, sciogliere una buona volta la scommessa».
I tre biascicarono un qualcosa tra il buonasera e il buonanotte, poi si
allontanarono con le braccia ficcate nei giubbotti. Camminavano distanti uno
dall'altro, senza parlare; solo Giasti a un certo punto accennò a un discorso
che venne subito fatto cadere, e non insistè più. L'uomo li guardò allontanarsi
con un sorriso fioco, trasse la mano dalla tasca e la ispezionò per qualche
secondo; accennò ad alzarsi, ma cambiò subito idea e risedette pesantemente. Con
sforzo raccattò il libro da terra e cercò di leggere alla debole luce sopra di
lui. Dopo poche pagine lo ridepose a terra accanto a sé e fissò il buio,
soddisfatto.
|