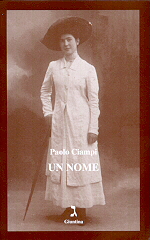
|
|
|
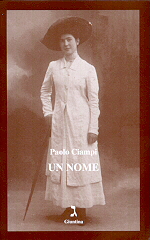
|
|
|
| << | < | > | >> |IndicePrefazione di Margherita Hack 5 Un nome 13 Un mondo davanti a sé 16 La signorina Enrica 36 Prima della tempesta 59 Fuori gli ebrei 88 La scuola che non ti aspetti 119 Verso il precipizio 147 Inghiottita dal buio 171 I lampi della memoria 201 Un libro di molti 223 Per saperne di più 226 |
| << | < | > | >> |Pagina 13
Capita a volte che qualcuno
raccolga un rametto spezzato
e portandolo con sé
ne provi compassione.
Chi raccoglierà i nostri figli
chi ne avrà compassione
nessuno nessuno nessuno.
Myriam Ulinover, poetessa morta ad Auschwitz
Un nome. Anzi, all'inizio nemmeno quello. All'inizio c'è il silenzio. Un vuoto senza emozioni. Come se un buco nero avesse risucchiato tutta una vita. Solo dopo diventa un nome: di quelli che si perdono tra i tanti. Pensate a una spiga in un campo di grano, oppure a un granello di sabbia che scivola tra le mani. O piuttosto, a un cadavere tra gli innumerevoli nella fossa comune della Storia. Enrica Calabresi, zoologa.
Nessuna strada porta oggi il suo nome. Non c'è lapide
che la ricordi, né libro di scuola che la rammenti. E anch'io:
cosa mi rappresentava fino a ieri? Un nome che non ti dice
niente, che non ti lascia niente. Un nome che ti fai ripetere,
per controllare se hai capito bene, per prendere tempo e rovistare nei
ripostigli della memoria. Fai fatica perfino a immaginarti che possa
corrispondere a una persona che è stata viva. A un cuore, a una testa, e
naturalmente anche a un corpo. A una donna e solo a lei.
Questa vita in realtà io l'ho percepita dalla fine. Dall'epilogo che l'ovvietà del linguaggio ci fa liquidare come tragico, e tanto basta, andiamo oltre. Enrica Calabresi la professoressa ebrea. Enrica Calabresi, una piccola inerme preda per i cacciatori nazisti. Enrica Calabresi, suicida in una notte del gennaio 1944. Una fiala di veleno svuotata in cella per darsi la morte piuttosto che subirla nel mattatoio di Auschwitz. E poi? Il poi è una foto sbiadita che la ritrae di profilo. Una figura minuta, colta negli anni della giovinezza. Lo sguardo che si spinge lontano, non si sa bene dove. Non un'espressione impaurita, perché non c'è ancora da avere paura. C'è solo da decifrare il futuro. I capelli tirati all'indietro; il collo lungo che spunta da una camicia bianca, senza la tentazione di una collana o di un orecchino; l'espressione dolce, ingenua, forse vagamente imbarazzata, di chi non è abituata a una parte da protagonista, nemmeno per impressionare un negativo: tutto mi induce a pensare a un punto interrogativo senza inquietudine. O a un placido animale al pascolo che non ha sentore del macello. È da qui che bisogna cominciare.
Da qui e da alcune domande.
Mi interrogo. Quanto so davvero dell'Olocausto? Quanto degli anni delle persecuzioni razziali? Sì, ho studiato i manuali di storia. Ho divorato un certo numero di libri, quasi uno scaffale della mia libreria. In televisione non ho mai cambiato canale a cuor leggero di fronte alla testimonianza di un superstite, a un filmato in bianco e nero con le immagini sgranate. Ho provato a misurarmi con l'immensità del male, a concepirlo. Mi sono chiesto e chiesto ancora come sia stato possibile. Alla fine mi sono sempre dovuto arrendere. Arrestarmi di fronte al muro del non vissuto. Adagiarmi sul ciglio della strada, come un autostoppista stremato. Penso ai numeri dell'ecatombe. Quanti sono stati? Sei milioni? Qualcuno meno, qualcuno di più? Troppi zeri: è una cifra così enorme da perdere di consistenza. Il suo significato si smarrisce. Non riesco a contare sei milioni di uomini, di donne, di bambini. Non posso vederli. Non posso immaginarmeli uno accanto all'altro. Ma sarebbe lo stesso, e sarebbe sempre troppo, con uno zero in meno, con due zeri in meno, con tre zeri in meno. Anche mille sono inconcepibili, anche cento... Lo so, c'è un solo numero che mi consentirà di comprendere. Uno. Uno, perché una sola è la persona. Quella persona. Proprio quella e non altre. Lei che ho scelto per accompagnarmi. Lei, purché ne riesca a cogliere la vita prima della morte. Enrica.
Quel
volto.
Di lei cosa è rimasto? Una manciata di foto e di lettere conservate dalla famiglia; alcuni scritti scientifici con lo stile esatto e asciutto che ci si aspetta in pubblicazioni di questo tipo; un mucchietto di moduli compilati per adempiere a qualche obbligo burocratico; i ricordi sfumati di un anziano nipote per il quale era come una mamma; la gratitudine di qualche allievo di un tempo, scampato al massacro e oggi disperso tra Milano e Gerusalemme; qualche citazione di sfuggita — e spesso incerta — in due o tre volumi sui tristi destini degli ebrei italiani. Tutto qui. Queste sono le coordinate di cui dispongo per tracciare la mappa di una vita. Nient'altro, perché di Enrica è più facile dire ciò che non è stata che quello che è stata. Non è stata un premio Nobel della scienza, non è stata una personalità della politica, non è stata un'eroina della Resistenza, non è stata una intellettuale impegnata, non è stata... E in realtà so già dove approderò, alla fine di questo viaggio intorno a una donna. Opporrò la mia personale banalità alla banalità del male. E potrò dire che Enrica, in fondo, è una di noi, una dei sei milioni di persone tra cui anche noi avremmo potuto essere. Che Enrica è soltanto Enrica e che per questo, precisamente per questo, è necessario trattenerne il ricordo. Ed è da qui che voglio cominciare. | << | < | > | >> |Pagina 119Cosa può succedere nella testa e nel cuore di un professore che da un giorno all'altro viene allontanato dalla sua cattedra, dai suoi studenti, per il solo fatto di non appartenere alla razza giusta? Enrica su questo non ci ha lasciato una sola riga. E per la verità non ho trovato nemmeno parole sue riportate da altri. Né me l'aspettavo. Per come sto imparando a conoscerla, Enrica i grandi dolori se li porta tutti dentro, non li sfoga in lacrime e invettive. Come per il suo Giovanni, tutto viene sepolto dal silenzio. Allo stesso modo una nevicata seppellisce i cadaveri della battaglia del giorno avanti. L'assenza di suoni, di parole, in fondo non fa che amplificare l'urlo della sofferenza, almeno per chi ha orecchie per ascoltare. Non credo comunque che le emozioni che si agitano nell'animo di Enrica siano poi molto diverse da quelle che nelle lettere agli amici racconterà Attilio Momigliano, uno dei più illustri professori dell'ateneo fiorentino e prima ancora di quello pisano. Incredulità, in prima battuta: e chissà se a un grande docente di letteratura italiana, a un uomo che ha trascorso la vita tra le pagine di Dante e di Manzoni, desti particolari emozioni il ritrovarsi ora in qualche modo estromesso dalla sua lingua e dalla sua cultura, come uno straniero inaccettabile. Momigliano, in questo non troppo diverso da Enrica, è un uomo schivo, che rifugge dall'idea di poter pesare o importunare. Anche agli amici più cari, come Giuseppe Gallico, ha difficoltà a confessare la sua pena. Piuttosto la vive come una vergogna privata, un'umiliazione con cui solo lui può e deve fare i conti. Nessuno può aiutarlo a organizzare la linea di resistenza, a reinventarsi una vita nella quale sia possibile sostenere il trauma e dare un senso al vuoto che si è inaspettalamente spalancato. E allora, a dispetto di questo scherzetto, così si fa forza di chiamarlo una volta, Momigliano cerca di mantenere una vita normale. Continua gli studi, dhvora libri, prepara lezioni come se ancora gli studenti lo attendessero in aula. Rispetta i consueti orari, non tralascia le abituali passeggiate malinconiche, che ogni giorno, con la regolarità di un Immanuel Kant fiorentino — pure questo lo dice lui — compie nel viale dietro casa e lungo il corso del Mugnone. Me lo immagino spingersi talvolta fino al portone della sua facoltà e lì soffermarsi per qualche attimo.
Non ci vuole molto, però, perché l'illusione che tutto possa proseguire come
prima si sgretoli e l'insensatezza la faccia da padrona. Lo spiazzamento sociale
si trasforma in depressione.
Le vicende di questi mesi si vengono a sovrapporre sopra un fondo di
tristezza e di sfiducia nei beni della vita, che — per questo almeno,
fortunatamente — mi aliena da me e mi lascia navigare dietro la solita scia
grigia... La vita in questi momenti sembra l'ombra di un sogno, gli avvenimenti
vicini e lontani si perdono nello stesso nulla. Poi si ritorna alla realtà, e
basta guardare gli amici per sentire una stretta al cuore... Io rimango
attaccato ciecamente alle mie abitudini di lavoro, e vivo un po' alla giornata,
perché l'istinto mi avverte che questo è il rimedio.
E questo lo confessa all'amico Gallico già il 2 novembre. Sono passati appena due mesi da quando le leggi razziali sono rovinosamrnte piombate sul suo mondo. Passo dopo passo la sua vita — un tempo così aperta, così ricca di relazioni e interessi coltivati e condivisi — si contrae e si riduce allo spazio di una stanza. Il professore diventa i libri che legge e che rappresentano sempre di più la via di fuga da quell'altro mondo, quello vero. Passo la vita facendo l'inventario della medesima, ammette prima di tutto a se stesso.
Si scopre a tirare fuori dai cassetti le carte che ha accumulato in
quarant'anni di
pensiferazione e di studio.
Però è sempre più consapevole che per quanto studi, per quanto scriva, gli
mancherà sempre il vero nutrimento, quella benzina che sola potrebbe rimettere
davvero in movimento il suo spirito provato: l'insegnamento.
Quello che mi tormenta non è il ricordo degli «irrevocati dì», che non sono mai stati felici, ma questa fatica di vivere senza possibilità di orientarsi. Lavoro più di prima, ma senza più gli stimoli d'una volta, e quell'alternativa — così salutare — fra il lavoro personale e la lezione, che si nutrivano a vicenda. Con una sua ex allieva, che nell'ottobre 1940 gli scriverà per annunciargli l'inizio della sua carriera di insegnante, sarà ancora più esplicito: Lei vedrà che in questi rapporti spesso chi più dà e chi più conforta è l'allievo.
Come gli mancano ora, i suoi allievi.
Nella solitudine della propria abitazione, nelle passeggiate per una città che ora si offre solo perché si ammazzi un po' di tempo, è più facile riandare con il ricordo a quanto è successo, a quegli istanti in cui abbiamo compreso che l'università, o la scuola, non ci appartiene più. È come un film che si vede e si rivede, nella speranza che le forbici della memoria ci sorprendano con un altro montaggio. E la memoria filtra, separa, riavvicina, cambia inquadrature e prospettive, riveste attori e comparse. Una sola cosa non riesce a cancellare o a modificare, esperienza comune a tutti gli insegnanti cacciati: l' assordante silenzio dei colleghi. I mesi che seguono al settembre 1938 non sono il tempo della solidarietà, ma quello in cui invidie professionali e ambizioni di carriera, trovano un insperato e squallido sfogo. A fronte di almeno quattrocento ebrei cacciati fuori dall'università, dal professore emerito all'ultimo assistente, gli scatti di indignazione, le prese di distanza si contano sulle dita di una mano. C'è Enrico Fermi, che ebreo non è ma che ha sposato un'ebrea, per cui le leggi razziali rappresentano la goccia che fa traboccare il vaso. C'è Massimo Bontempelli che a Firenze rifiuta la cattedra di letteratura italiana scippata proprio a Momigliano. E pochi altri assieme a loro. Come sette anni prima, quando ai professori era stato imposto il giuramento di fedeltà al Re, ai suoi Reali successori e al Regime fascista: su oltre milleduecento professori solo una dozzina vi si erano sottratti. Peggio ancora, anzi, perché questa volta non si tratta di sole parole, pur pesanti come macigni; questa volta in ballo ci sono uomini cacciati come paria e altri che sgomitano per subentrare in quei posti. C'è ben poca traccia di quel pietismo che le autorità fasciste stigmatizzano rudemente, degradando la compassione ad atteggiamento indegno. Assai di più pesa il calcolo cinico, quello su cui punta l'indice un disincantato Ernesto Rossi: È un bel numero di cattedre che rimangono contemporaneamente vacanti: una manna per tutti i candidati che si affolleranno ora ai concorsi. E lo scrive dal carcere. Questa è l'università degli indifferenti e degli opportunisti. Questo è il tradimento dei chierici, il peggiore dei tanti. E questa è davvero l'umiliazione peggiore per chi ora è fuori. Quale sconquasso tutto questo possa produrre ce lo racconta Pietro Calamandrei, ripercorrendo la triste parabola di Federico Cammeo, l'uomo che fino a solo qualche mese prima era l' insigne giurista, l' avvocato principe, l'accademico riverito da stormi di pappagalli adulatori.
Ora è solo il
giudeo,
per di più alle prese con una specie di
catastrofe intima,
calvario di un uomo che non è mai stato antifascista: complicazione ulteriore
per chi adesso è annichilito dallo spettacolo dei tanti
benpensanti disciplinati
passati improvvisamente
dall'ammirazione con cui per tutta la vita lo avevano blandito, all'isolamento e
all'abbandono.
Questo, di tutti i tormenti che la campagna razziale mise in opera contro
gli innocenti, fu il più crudele, e anche, a ripensarlo ora, il più
ingiustificabile: non la ferocia dei carnefici, ma il servilismo accomodante e
utilitario di certe persone perbene, le quali, solo perché così era ordinato,
cambiavano da un giorno all'altro, come se fosse la cosa più naturale del
mondo, l'affetto, la gratitudine, l'ammirazione di ieri, in indifferenza e forse
in ostilità e in disprezzo.
E allora teniamoci strette le parole di padre Ernesto Balducci, allorché si
chiede perché le leggi razziali non abbiano provocato un'
insurrezione delle coscienze.
Il fascismo non era solo un regime politico, era un clima spirituale che
penetrava per ogni dove, uccidendo lo spirito critico e favorendo quel sonno
dogmatico che negli ambienti cattolici di stretta osservanza passava per somma
virtù.
Il vero ghetto era il nostro, conclude lapidario padre Balducci: non degli ebrei, ma di chi si è di fatto autosegregato accettando a cuor leggero e con miope opportunismo il taglio netto dei vincoli di umanità. Lo accetto come giudizio a posteriori. Dubito però che nell'autunno 1938 parole di questo tipo potessero lenire coscienze ferite come quella di Enrica e riscattare un vertiginoso senso di solitudine. | << | < | > | >> |Pagina 147Però il peggio deve ancora arrivare. E c'è chi fa di tutto per non pensarci e chi guarda un po' più in là, e intuisce che le leggi razziali sono solo la prima tappa del calvario. Tra quest'ultimi c'è pure Enrica. Anche a non voler indossare i panni della Cassandra di turno, lei sa bene che le cose non finiranno così. Non possiede il dono della profezia, però a Firenze è tra i pochi che seguono attentamente le vicende internazionali e che godono di un punto di osservazione privilegiato: grazie alle sue consuete letture dei giornali inglesi può apprendere quello che sulla stampa italiana non c'è. E poi, anche in quel mondo a parte che è la scuola ebraica, capita che la Storia bussi alla porta, ospite non invitata e sgradita. Succede per esempio in occasione di qualche dimostrazione spontanea, allorché i fascisti chiudono le scuole e spediscono gli studenti per le strade, a manifestare per o contro qualcosa. C'è sempre il timore che il corteo possa deviare verso la sinagoga e che la vista di qualche ebreo possa scatenare una gazzarra per la difesa della razza. Un giorno siamo ancora nel 1938. il professor Scaramella viene preavvertito da alcuni vecchi colleghi del Michelangelo, con cui è ancora in confidenza: è in programma una manifestazione per l' italianità della Corsica e di Nizza, più o meno alla stessa ora in cui in via Farini terminano le lezioni. Il preside non ha esitazioni: manda tutti a casa con un'ora di anticipo e raccomanda che ogni ragazza sia accompagnata a casa da un ragazzo. Per alcuni studenti il seguito sarà un'emozione imprevista. E poiché niente può ripagare il brivido di una compagna di classe portata sulla canna della bicicletta, da bravi fidanzatini, questo momento se lo terranno ben stretto. Lo conserveranno come cosa cara a dispetto della miseria dell'epoca e a lungo ci sorrideranno sopra: Questo al Michelangelo non mi sarebbe mai potuto capitare. Qui, certo, c'è anche l'incoscienza dell'età, c'è la dolcezza che si mescola al ricordo, tanto più è lontano. No, l'ignoranza no, perché questi studenti sono assai più consapevoli di tutti i loro coetanei: per quello che hanno appreso sulla loro pelle e per quanto possono apprendere tra queste mura. In realtà lo stesso isolamento della scuola ebraica consente un clima di complicità, il sollievo della zona franca, l'illusione dell'immunità diplomatica. Talvolta è possibile affrontare addirittura argomenti proibiti, politicamente compromettenti. La stessa Enrica se lo concede; lei che non ha mai condito le sue spiegazioni di altro ingrediente che non fosse la scienza, tra queste mura amiche finisce per sbottonarsi. Forse è la prima a sorprendersi mentre senza eccessivi giri di parole fa cadere una battuta sulla politica razziale del regime oppure manifesta la simpatia per la sua Inghilterra, in anni in cui quest'ultima non è altro che la perfida Albione. I suoi allievi sono ragazzi nati dopo la marcia su Roma, imbevuti di propaganda fascista da quando erano in fasce. Certi discorsi, estranei alla retorica di regime, sottratti alla calma piatta del conformismo, non li hanno mai potuti ascoltare. Tra loro qualcuno è stato contento di vestirsi da balilla, prima che pure questo fosse proibito dalle leggi razziali, e ha fatto festa il giorno della proclamazione dell'Impero. Il settembre 1938 lo ha senz'altro aiutato ad aprire gli occhi, ma di qui a sentire certe cose ce ne corre... E ora ecco che si trova davanti questa insegnante triste e introversa, una donna che ha tutto fuorché l'aria di una pericolosa sovversiva, di una traditrice della patria, e che pure non lesina parole di ammirazione per Anthony Eden, il ministro degli esteri che si è battuto alla Società delle Nazioni perché l'aggressione all'Etiopia fosse punita con quelle che il fascismo chiama inique sanzioni...
Sono parole che sembrano arrivare da un altro pianeta:
prima che il peggio, appunto, arrivi davvero.
Per Enrica la guerra è prima di tutto l'addio a una amica cara. Probabilmente la più cara tra quante frequenta e con le quali ha una relativa confidenza. Prima ancora che Mussolini decida di finirla con la non belligeranza, prima che passi una volta per tutte alla guerra, anche a costo di pugnalare alle spalle una Francia già in ginocchio, molti inglesi comprendono che per loro non c'è più posto. Hanno amato e amano l'Italia con un'intensità difficilmente concepibile oggi, si sono ubriacati del suo sole e della sua arte, hanno sciolto versi commossi alle sue campagne e ai suoi monumenti, però ora è finita. Il fascismo corre rovinosamente verso la guerra, prigioniero della sua stessa retorica, come un treno lanciato a tutta velocità di cui si è perso il controllo. E loro presto saranno solo i sudditi di un paese nemico, da destinare ai campi di prigionia o al confino. È tempo di fare le valigie, di acquistare i biglietti per Londra e tagliare di netto con un passato in cui si sono sentiti orgogliosamente anglo-italiani. Così, all'inizio del 1940, tocca anche a Miss Houton, l'amica che per tanti anni ha condiviso con Enrica tè e conversazioni e che ora abbandona Firenze con riluttanza. Non fosse stato per Mussolini, non si sarebbe mai decise; e del resto a tornare in Inghilterra non ci pensa nemmeno. Quella salute che un tempo l'ha portata sulle sponde dell'Arno la tiene ancora lontana da quelle del Tamigi. Miss Houton è una di quelle inglesi che si sente splendidamente inglese solo lontano dal suo paese, trapiantando un pezzo di Inghilterra in un altro angolo del mondo. Ora sceglie isole lontane, un arcipelago tropicale su cui sventola l' Union Jack, ma senza le nebbie, senza l'umido inglese. Soprattutto senza la guerra, evenienza che pare assolutamente remota in quel cantuccio di impero britannico. Miss Houton ed Enrica non si rivedranno più. Prima che le operazioni militari le separino una volta per tutte l'amica inglese farà solo in tempo a inviarle una cartolina. Vi descriverà, brevemente, la sua nuova vita. Il luogo dove ha deciso di fermarsi, dirà, è so peaceful... così pieno di pace. Parole che Enrica leggerà e rileggerà ad alta voce, talvolta così presa da non accorgersi di essere guardata.
Parole che accompagnerà sempre con un sospiro, arresa all'evidenza di un
paese che si sta cacciando su una strada senza ritorno.
Per Enrica, come per tutti gli italiani, la guerra è la voce
del Duce, quel caldo pomeriggio del 10 giugno 1940.
Combattenti di terra, di mare, dell'aria, camicie nere della Rivoluzione e delle legioni, uomini e donne d'Italia, dell'Impero e del Regno d'Albania, ascoltate... | << | < | > | >> |Pagina 191Alla fine, nel gennaio 1944, arriva il turno di Enrica.Del suo arresto sono più le cose che non si sanno, e che temo non si sapranno mai, che quelle che sono rimaste impigliate nelle reti della memoria. Anche la data si è persa. Chi le si è presentato davanti, chi le ha ordinato di seguirla, che cosa si è portata via con sé? C'è qualcuno che l'ha tradita? Difficilmente apprenderemo qualcosa di più, perché ogni documento relativo al suo arresto, come a quello di tanti altri, è sparito con la fine della guerra. Distrutto assieme ai nomi di molte persone che in qualche maniera hanno contribuito ad attuare la scienza esatta persuasa allo sterminio, per dirla con le parole del poeta Quasimodo. Si sa che Enrica viene prelevata dalla sua abitazione di via del Proconsolo, la casa che ha deciso di non abbandonare. Si sa che a portarla via sono italiani, non tedeschi. Si sa che viene immediatamente trasferita a Santa Verdiana, in pratica la sezione femminile del complesso carcerario delle Murate: un ex convento di clausura riconvertito a questo uso. Da molto tempo le porte di Santa Verdiana si chiudono alle spalle di donne a cui è stata tolta la libertà. Ora però ci sono soprattutto ebree e politiche, due mondi ben distinti nella complicata mappa delle relazioni carcerarie. Le politiche, infatti, sono tutte sistemate in celle al pianterreno. Per il timore di infiltrazioni fanno gruppo insieme e guardano con sospetto le nuove arrivate che non conoscono. Anche con la paura che monta dentro, rispetto alle ebree hanno motivazioni a cui aggrapparsi. Loro sanno perché sono finite lì: la prigionia sta nelle regole di quella terribile avventura che è la guerra partigiana. Si può attendere con ansia la sveglia delle suore, che alle sei della mattina chiamano per la messa, perché tra i banchi della cappella ci si scambieranno informazioni, ci si darà forza. E nel laboratorio dove si cuciono camicie e mutande per i tedeschi non si rimarrà in silenzio. Il carcere, per queste detenute, è anche una scuola politica, un esercizio di vita comune. Per le donne ebree è diverso: non c'è ragione che possa spiegare perché sono qui. Non c'è ragione che possa sostenere la speranza di fronte alla prospettiva della deportazione. Tuttavia per quanto siano situazioni diverse e lontane, per quanto il presente sia tetro e il futuro indecifrabile per tutte, non ci si sente completamente sole. Nel carcere di Santa Verdiana la solidarietà non è un bene raro, a dispetto di tutte le miserie umane che pure ci sono. Anche le politiche, con tutte le loro diffidenze, non fanno finta di non vedere e non sapere. Tutte insieme, per dirne solo una, adottano una bambina ebrea, nel tentativo di sottrarla ai convogli che partono per i lager. A loro rischio e pericolo la nascondono ai tedeschi, magari sotto un pagliericcio. E poi ci sono le comuni, donne imprigionate per motivi che niente hanno a che vedere con la razza e con la guerra di liberazione. Sciagurate che in qualche caso pagano reati commessi in gioventù con una detenzione che ormai si trascina da venti o trenta anni. Vite annientate, storie di miseria, di un Italia di campagne affamate e di quartieri malfamati. Cuori spesso induriti e che pure sanno sciogliersi di fronte al dramma delle donne ebree. Per loro c'è chi rinuncia a qualche razione di cibo. Altri aiuti sono ancora più inattesi. C'è il medico che, quando è necessario, dà buoni consigli per marcare visita: piglia un uovo, sbattilo, fai finta di rigettare. C'è lo stesso direttore del carcere, che fa quel che può e che, giorno dopo giorno, dà prova che anche a non sentirsi un cuor di leone, anche a essere un piccolo ingranaggio di un meccanismo spietato, si può fare la differenza: perché c'è sempre una possibilità di scarto rispetto a una obbedienza cieca e perché, almeno questo, gli ordini eseguiti non hanno bisogno di una personale razione di sadismo. C'è la figlia del direttore, nemmeno ventenne, che fa ancora di più: ogni giorno si mescola alle suore e alle detenute e da loro impara a lavorare all'uncinetto, un'occupazione che serve da paravento per raccogliere messaggi e trasmetterli all'esterno. Può farlo perché la sua presenza non desta alcun sospetto, le guardie sono abituate a vederla da quando era una ragazzina. E ci sono le religiose di servizio nella casa di pena, cioè le suore di San Giuseppe dell'Apparizione, che a Firenze hanno un loro istituto, in via Gioberti. Fanno molto e, tra loro, fa molto soprattutto la madre superiora. È grazie a lei che si chiude un occhio, e talvolta anche l'altro, nel parlatorio, quando qualche messaggio passa attraverso la grata. Si mormora che, in qualche modo, sia collegata con le forze della Resistenza. Le carcerate sottoposte a interrogatori possono confidarle cosa è stato loro chiesto e cosa si sono lasciate scappare: lei provvederà a farlo sapere all'esterno, magari con qualche bigliettino vergato in fretta e furia. Quando i partigiani, travestiti da nazisti, piomberanno a Santa Verdiana per portarsi via una loro compagna, Tosca Bucarelli, la religiosa prima aprirà loro la porta e poi li rampognerà: Un momento, dovete lasciare andare anche le altre, altrimenti dmani vengono, me le prendono e me le fucilano. Questo è il personaggio. E nelle celle non si è sole. In alcune, anzi, si passano i giorni e le notti gomito a gomito, fianco a fianco, stipate anche in otto o nove. Non c'è intimità e le tensioni talvolta si scatenano in litigi o degradano in gesti meschini e vigliacchi. Però anche in queste situazioni, direi proprio in queste situazioni, emergono caratteri straordinari, donne che proprio la tragedia incombente sembra forgiare ed esaltare. Che si trovi nella stessa cella, oppure in quelle accanto, Enrica ha modo di conoscere Carolina, la moglie del partigiano Calò, che a Santa Verdiana resterà per quattro mesi, in attesa che la sua prigionia aiuti a mettere le mani sul marito. Alla fine lei e i suoi tre bambini saranno spediti a Fossoli – il campo di raccolta e transito in provincia di Modena dove dal febbraio 1944 si concentrano gli ebrei in partenza per i lager – e di lì ad Auschwitz: durante il tragitto, su un carro bestiame sigillato e affollato all'inverosimile, Carolina partorirà il quarto figlio. E anche lui, come la mamma e i fratellini, la mattina stessa dell'arrivo sarà selezionato per la camera a gas.
Niente è rimasto dei suoi ultimi momenti, delle rapide tappe dell'orrore che
si squadernano una volta che il vagone blindato conclude la sua corsa e si ferma
nella pianura polacca. In carcere, però, Carolina lascia una traccia e un
ricordo: è la leonessa che protegge i suoi figli, la donna che
offre coraggio e speranza.
|