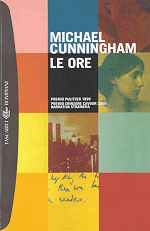
|
|
|
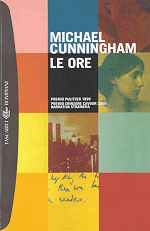
|
|
|
| << | < | > | >> |Pagina 9Si affretta, via di casa, indosso ha un cappotto troppo pesante per il clima. È il 1941. È scoppiata una nuova guerra. Ha lasciato un biglietto per Leonard, e un altro per Vanessa. Cammina con determinazione verso il fiume, sicura di quello che farà, ma anche in questo momento è quasi distratta dalla vista delle colline, della chiesa e di un gregge sparso di pecore, incandescente, tinto di una debole traccia di zolfo, che pascola sotto un cielo che si fa più scuro. Si ferma, osserva le pecore e il cielo, poi riprende a camminare. Le voci mormorano alle sue spalle; bombardieri ronzano nel cielo, ma lei cerca gli aeroplani e non riesce a vederli. Supera uno dei lavoranti della fattoria (si chiama John?), un uomo robusto, con la testa piccola, che porta una maglietta del colore delle patate; sta pulendo il fosso che corre lungo il vincheto. Lui la guarda, fa un cenno con il capo, guarda di nuovo in basso, nell'acqua marrone. Mentre lo supera diretta al fiume, pensa a quanto lui sia appagato, a quanto sia fortunato, a pulire il fosso in un vincheto. Lei invece ha fallito. Non è una scrittrice, non veramente: è solo una stravagante dotata. Squarci di cielo brillano nelle pozzanghere lasciate dalla pioggia della notte precedente. Le sue scarpe affondano leggermente nella terra soffice. Ha fallito, e ora le voci sono ritornate, mormorano indistinte proprio dietro il suo campo visivo, dietro di lei, qui, no, ti volti e sono andate via, da qualche altra parte. Le voci sono ritornate e il mal di testa si sta avvicinando, sicuro come la pioggia: il mal di testa che distruggerà qualunque cosa lei sia e prenderà il suo posto. Il mal di testa si sta avvicinando e sembra (lo sta solo immaginando, o no?) che i bombardieri siano di nuovo comparsi nel cielo. Raggiunge l'argine, lo scavalca e continua giù, di nuovo verso il fiume. C'è un pescatore a monte, su per il fiume, non si accorgerà di lei, oppure sì? Comincia a cercare una pietra. Lo fa in fretta, ma con metodo, come se stesse seguendo una ricetta a cui bisogna obbedire scrupolosamente per raggiungere un buon risultato. Ne sceglie una approssimativamente del peso e della forma della testa di un maiale. Anche mentre la raccoglie e la spinge a forza in una delle tasche del cappotto (la pelliccia le fa il solletico sul collo), non può fare a meno di notarne la qualità fredda e gessosa e il colore, un marrone lattiginoso con tracce di verde. Sta vicino alla sponda del fiume, che si spinge contro l'argine, riempiendo le piccole irregolarità del fango di acqua chiara, acqua che potrebbe essere una sostanza completamente diversa da quella giallo-marrone, chiazzata, apparentemente solida come una strada, che si stende immobile da una sponda all'altra. Fa un passo avanti. Non si toglie le scarpe. L'acqua è fredda, ma non tanto da essere insopportabile. Si ferma, ormai nell'acqua fino alle ginocchia. Pensa a Leonard. Pensa alle sue mani e alla sua barba, alle linee profonde intorno alla sua bocca. Pensa a Vanessa, ai bambini, a Vita e Ethel: tante persone. Anche loro hanno fallito, no? All'improvviso, si sente immensamente dispiaciuta per loro. Immagina di voltarsi indietro, di tirare fuori la pietra dalla tasca, di tornare a casa. Potrebbe forse rientrare in tempo per distruggere i biglietti. Potrebbe continuare a vivere; potrebbe compiere questo atto finale di gentilezza. Immersa fino alle ginocchia nell'acqua che si muove, decide di no. Le voci sono qui, il mal di testa sta per arrivare e, se si affida alle cure di Leonard e Vanessa, non la lasceranno andare via di nuovo, vero? Decide di continuare, perché la lascino andare. Si muove a stento, goffamente (il fondo è fangoso), fino a che l'acqua le arriva ai fianchi. Getta uno sguardo a monte, al pescatore, che porta una giacca rossa e non la vede. La surerficie gialla del fiume (più gialla che marrone, vista da così vicino riflette un cielo scuro. È questo, allora, l'ultimo momento di percezione vera: un uomo che pesca con una giacca rossa e un cielo nuvoloso che si riflette nell'acqua opaca. Quasi involontariamente (a lei sembra che sia involontariamente) fa un passo avanti o inciampa, e la pietra la spinge giù. Per un momento, ancora, sembra niente, sembra un altro fallimento: solo acqua gelata da cui può facilmente uscire; ma poi la corrente la avvolge e la trascina con una forza così muscolare, così improvvisa che sembra che un uomo forte si sia sollevato dal fondo, le abbia afferrato le gambe e se le sia strette al petto. Sembra un contatto personale. | << | < | > | >> |Pagina 22[...] Ecco la piccola e bella libreria di Spring Street. Forse a Evan piacerebbe un libro. Nella vetrina ce n'è uno (uno solo!) di Clarissa, quello inglese (criminale, il fatto che lei abbia dovuto combattere per una tiratura di diecimila copie e, ben peggio, il fatto che saranno fortunati se ne venderanno cinquemila), accanto alla saga di una famiglia del Sud America che lei ha perso a vantaggio di una casa editrice più importante, che chiaramente non guadagnerà perché, per ragioni misteriose, è rispettata ma non amata. C'è la nuova biografia di Robert Mapplethorpe, le poesie di Louise Glück, ma niente sembra adatto. Sono tutti, allo stesso tempo, troppo generici e troppo specifici. Vuoi dargli il libro della sua vita, il libro che gli assegnerà un posto nel mondo, che gli farà da padre e madre, che gli darà delle armi per i cambiamenti che deve affrontare. Non ci si può presentare con dei pettegolezzi sulle celebrità, no; non si può portargli la storia di un romanziere inglese amareggiato dalla vita o le disgrazie di sette sorelle in Cile, per quanto siano scritti bene, e le probabilità che a Evan piaccia la poesia sono identiche a quelle che cominci a dipingere piatti di porcellana.Non c'è conforto, sembra, nel mondo degli oggetti, e Clarissa teme che l'arte, anche la più grande (anche i tre volumi di poesia di Richard e il suo unico, illeggibile romanzo), appartenga decisamente al mondo degli oggetti. In piedi di fronte alla vetrina della libreria, viene assalita da un vecchio ricordo, un ramo d'albero che batte contro una finestra mentre da qualche parte (dalle stanze in basso?) una debole musica, il lento lamento di una jazz band, attacca da un fonografo. Non è il suo primo ricordo (che sembra invece riguardare una lumaca che striscia sul bordo di un marciapiede), e neanche il suo secondo (i sandali di paglia di sua madre, o forse i due ricordi sono invertiti), ma questo ricordo sembra pressante più di ogni altro, e in maniera profondà, quasi soprannaturale, confortante. Clarissa era probabilmente in una casa del Wisconsin, una delle tante che i suoi genitori affittavano per l'estate (raramente due volte la stessa - ognuna finiva per avere qualche difetto che sua madre inseriva in un racconto che si allungava sempre, Le tribolazioni della famiglia Vaughan nel giro delle lacrime fra le vallette del Wisconsin). Clarissa doveva avere tre o quattro anni, in una casa in cui non sarebbe mai ritornata, della quale non ha alcuna altra memoria se non questa, precisamente distinta, più chiara di ciò che le è accaduto ieri: un ramo che batte alla finestra mentre attaccano le trombe, come se il ramo, mosso dal vento, avesse in qualche modo determinato la musica. Le sembra di aver iniziato in quel momento a vivere nel mondo, a capire le promesse implicite in uno schema che è più grande della felicità umana, sebbene contenga la felicità umana insieme a ogni altra emozione. Il ramo e la musica contano per lei più di tutti i libri nella vetrina del negozio. Vuole per Evan - e per se stessa - un libro che possa contenere ciò che contiene quel singolo ricordo. Se ne sta in piedi a guardare i libri e il suo riflesso in sovrimpressione sul vetro (ha ancora un bell'aspetto, adesso è bella, invece che carina - quando cominceranno a emergere le increspature e la desolazione, le labbra grinzose del suo volto di vecchia?), e poi riprende a camminare, rimpiangendo il delizioso vestito nero che non può comprare per sua figlia, perché Julia è schiava di un'omosessuale impegnata e insiste a indossare T-shirt e anfibi. Mary Krull è una donna da rispettare, è lei stessa a non dare altra scelta, per come vive al limite dell'indigenza, per come va in prigione per le sue varie cause, per come tiene appassionate conferenze alla New York University su quella spiacevole mascherata conosciuta come "genere sessuale". Vuoi che ti piaccia, combatti perché sia così, ma alla fine è troppo dispotica nella sua profondità intellettuale e morale, nella sua dimostrazione incessante di incisività, di correttezza in giacca di pelle. Sai che ti prende in giro, in privato, per le tue comodità e le tue buffe (deve considerarle "buffe") nozioni sull'identità lesbica. Ti stanchi di essere trattata come il nemico solo perché non sei più giovane, perché vesti come ci si aspetta che tu vesta. Vuoi urlare a Mary Krull che non fa tanta differenza; vuoi che entri nella tua testa per qualche giorno e senta le preoccupazioni e i dispiaceri, la paura senza nome. Credi - sai - che tu e Mary Krull soffrite della stessa malattia mortale, dello stesso disgusto d'anima, e con un giro dell'orologio in più avreste potuto essere amiche; [...] | << | < | > | >> |Pagina 30"Mangerò più tardi. Adesso vado a lavorare."Lui esita, poi annuisce borbottando. Non vuole interferire con il suo lavoro, non lo farà. Però Virginia che si rifiuta di mangiare non è un buon segno. "Pranzerai," dice lui. "Un pranzo vero: minestra, pudding e tutto il resto. Con la forza, se è necessario." "Pranzerò," dice lei, con impazienza, ma senza vera rabbia. È alta, smunta, meravigliosa nella sua vestaglia, con il caffè che fuma in mano. A volte lui resta ancora senza parole di fronte a lei. Pensa che sia la donna più intelligente d'Inghilterra. I suoi libri verranno letti nei secoli. Lui lo crede con più forza di chiunque altro. Ed è sua moglie. E Virginia Stephen, pallida e alta, sorprendente come un Rembrandt o un Velazquez, che compare vent'anni prima nella stanza di suo fratello con un vestito bianco, ed è Virginia Woolf, di fronte a lui, adesso. È invecchiata in maniera drammatica, proprio quest'anno, come se uno strato d'aria fosse filtrato da sotto la sua pelle. Adesso è indurita, stanca. Ha cominciato a sembrare scolpita in un marmo grigiobianco, molto poroso. È ancora regale, ancora squisitamente costruita, ancora in possesso della sua formidabile radiosità lunare, ma improvvisamente non è più bella. "Va bene," dice lui. "Continuo a darei dentro qui." Lei ritorna su furtivamente, in modo da non attirare l'attenzione di Nelly (perché si sente sempre così circospetta rispetto ai domestici, così colpevole di qualche crimine?), va nel suo studio, chiude piano la porta. Al sicuro. Apre le tende. Fuori, dietro il vetro, Richmond continua a sognare se stessa, civile, in pace. I fiori e le siepi sono curati; gli infissi ridipinti prima che ne abbiano veramente bisogno. I vicini, che lei non conosce, fanno tutto quello che fanno, qualunque cosa sia, dietro le tende alla veneziana e le persiane delle loro ville di mattoni rossi. Lei riesce solo a pensare a stanze in penombra e a cibo ordinario, troppo cotto. Si stacca dalla finestra. Se riesce a rimanere forte e lucida, se riesce a continuare a pesare almeno sessanta chili, Leonard si lascerà convincere a ritornare a Londra. La cura del riposo, questi anni tra le distese di delfinio e le ville rosse dei sobborghi, verrà decretata un successo e lei sarà giudicata di nuovo pronta per la città. Il pranzo, sì: pranzerà. Dovrebbe anche fare colazione, ma non riesce a sopportare l'interruzione che ne conseguirebbe, avere a che fare con l'umore di Nelly. Scriverà per circa un'ora, poi mangerà qualcosa. Non mangiare è un vizio, un tipo di droga - con lo stomaco vuoto si sente veloce e pulita, lucida di mente, pronta per una battaglia. Sorseggia il caffè, lo mette giù, stende le braccia. Questa è una delle esperienze più singolari: svegliarsi in quello che sembra un buon giorno, prepararsi al lavoro, ma non cominciado ancora veramente. Questo momento racchiude infinite possibilità, intere ore a venire. La mente ronza. Questa mattina può penetrare la foschia, i condotti intasati, raggiungere l'oro. Riesce a sentirlo dentro di sé, una seconda se stessa indescrivibile, o piuttosto una se stessa parallela, più pura. Se fosse religiosa la chiamerebbe "l'anima". È più della somma del suo intelletto e delle sue emozioni, più della somma delle sue esperienze, anche se corre attraverso tutte e tre come vene di metallo brillante. È una facoltà interiore che riconosce i misteri che animano il mondo, perché è fatta della stessa sostanza, e quando è molto fortunata lei è capace di scrivere attingendo direttamente da quella facoltà. Scrivere in quello stato è la soddisfazione più profonda che conosca. Ma la sua capacità di accedervi va e viene senza preavviso. Può impugnare la penna e seguirla con la mano mentre si muove per il foglio; può impugnare la penna e scoprire che è solo lei: una donna in vestaglia che regge una penna, timorosa e incerta, con una competenza solo superficiale e nessuna idea su dove cominciare o cosa scrivere. Impugna la penna. La signora Dalloway disse che avrebbe comprato lei i fiori. | << | < | > | >> |Pagina 32[...] È Los Angeles. È il 1949. Laura Brown sta cercando di perdersi. No, non è esattamente cosi - sta cercando di rimanere in sé entrando in un mondo parallelo. Tiene il libro a faccia in giù sul petto. Già la sua stanza da letto (no, la "loro" stanza da letto) sembra più densamente popolata, più vera, perché un personaggio di nome "signora Dalloway" è in cammino per comprare dei fiori. Laura dà uno sguardo all'orologio sul comodino. Le sette sono passate da un pezzo. Perché ha comprato questo orologio, questa cosa orribile, con il quadrante verde squadrato in un sarcofago rettangolare di bachelite nera - come ha mai potuto pensare che fosse una buona idea? Non dovrebbe permettere a se stessa di leggere, non proprio stamattina, non il giorno del compleanno di Dan. Dovrebbe essere fuori dal letto, aver già fatto la doccia ed essersi vestita, a preparare la colazione per Dan e Richie. Riesce a sentirli giù: suo marito che si prepara la colazione, che dà da mangiare a Richie. Dovrebbe essere lì, no? Dovrebbe essere ai fornelli con la sua vestaglia nuova, pronta a parlare di tante cose semplici e incoraggianti. Eppure, quando ha aperto gli occhi qualche minuto fa (già dopo le sette!) - mentre ancora viveva nel suo sogno, dove un macchinario pulsava molto in lontananza, un battito costante come di un gigantesco cuore meccanico che poi sembrava farsi più vicino -, ha avvertito quella sensazione umida intorno a lei, la sensazione di non trovarsi in nessun posto, e ha capito che sarebbe stata una giornata difficile. Ha capito che avrebbe avuto problemi a credere in se stessa, nelle stanze della casa, e quando ha gettato uno sguardo a questo nuovo libro sul comodino, impilato sull'altro che ha finito la scorsa notte, lo ha preso automaticamente, come se leggere fosse il solo e naturale compito con cui iniziare la giornata, la sola via praticabile per gestire il passaggio dal sonno al dovere. Dal momento che aspetta un bambino, le sono concesse queste mancanze. Le è concesso, per adesso, leggere senza ragione, oziare a letto, piangere o infuriarsi per un nonnulla. | << | < | > | >> |Pagina 56Guarda l'orologio sul tavolo. Sono passate quasi due ore. Si sente ancora piena di forze, anche se sa che domani potrebbe guardare quello che ha scritto e trovarlo pieno d'aria, gonfio. Si ha sempre in mente un libro migliore di quello che si riesce a mettere sulla carta. Beve un sorso di caffè freddo, e si concede di rileggere ciò che ha scritto fino a questo momento. Sembra abbastanza buono: a tratti sembra veramente buono. Ha grandi speranze, naturalmente - vuole che questo sia il suo miglior libro, quello che finalmente corrisponde alle sue aspettative. Ma si può far diventare un solo giorno di vita di una donna ordinaria materiale sufficiente per un romanzo? Virginia si tamburella le labbra con il pollice: Clarissa Dalloway morirà, di questo si sente certa, sebbene sia impossibile sapere così presto come e anche precisamente perché. Si toglierà la vita, crede Virginia. Sì, è quello che farà. Virginia depone la penna. Le piacerebbe scrivere tutto il giorno, riempire trenta pagine invece che tre, ma dopo le prime ore qualcosa dentro di lei vacilla, e teme che se si spingesse oltre i suoi limiti rovinerebbe tutto. Sprofonderebbe in un regno di incoerenza, dal quale potrebbe non ritornare mai più. Nello stesso tempo, odia trascorrere le sue ore buone a fare qualsiasi altra cosa che non sia scrivere. Lavora, sempre, contro la paura di una ricaduta. Prima arrivano i mal di testa, che non le danno affatto un dolore ordinario ("mal di testa" le è sempre sembrato un termine inadeguato, ma chiamarli in qualsiasi altro modo sarebbe troppo melodrammatico). Si infiltrano in lei. Prendono possesso di lei piuttosto che colpirla, nel modo in cui i virus prendono possesso dei loro ospiti. Fitte di dolore si annunciano, scagliano schegge brillanti nei suoi occhi con una tale forza che lei deve costringersi a ricordare che gli altri non possono vederle. Il dolore la colonizza, velocemente prende il posto di ciò che era Virginia, sempre di più, e la sua avanzata è così potente, i suoi contorni dentati così distinti che non può fare a meno di immaginarlo come un'entità dotata di vita propria. Può vederla mentre cammina con Leonard nella piazza, una scintillante massa bianco argento che galleggia verso di lei sopra i ciottoli, armata di punte, fluida ma compatta, come una medusa. "Che cos'è quello?" potrebbe chiedere Leonard. "È il mio mal di testa," risponderebbe lei. "Per favore, ignoralo."
Il mal di testa è sempre lì, in attesa, e i suoi periodi di
libertà, per quanto lunghi, sembrano sempre provvisori. A volte il mal di testa
si impossessa di lei solo parzialmente, per una sera, o un giorno o due, e poi
si ritira. A volte rimane e aumenta finché lei non soggiace. Quelle volte il mal
di testa esce dalla sua scatola cranica e va nel mondo. Tutto brilla e pulsa.
Tutto è infetto di lucentezza, vibra di essa, e lei prega perché arrivi un po'
di buio, come un viandante perso nel deserto prega per avere un po' d'acqua. Il
mondo è in ogni parte privo di oscurità, come un deserto può esserlo d'acqua.
Non c'è oscurità nelle stanze con le imposte chiuse; non c'è oscurità dietro le
sue palpebre abbassate. Ci sono solo diverse gradazioni di luminosità, maggiori
o minori. Quando è stata trasportata in questo regno di brillantezza senza
tregua, cominciano le voci. A volte sono basse, mormorii incorporei che si
compattano dall'aria stessa; a volte provengono da dietro i mobili, o da dentro
i muri. Sono indistinte, ma gravide di significati, sicuramente maschili,
oscenamente vecchie. Sono arrabbiate, accusatorie, deluse. A volte sembra che
conversino, sussurrando, fra di loro; a volte sembra che recitino un testo. A
volte, debolmente, riesce a distinguere una parola. "Salto", una volta e "sotto"
in due occasioni. Uno stormo di passeri fuori dalla finestra una volta ha
cantato, senza ombra di dubbio, in greco. Questo stato la rende tremendamente
miserabile; in questo stato è capace di urlare contro Leonard o contro chiunque
altro le si avvicini (sprizzando luce come un diavolo), eppure questo stato,
quando si protrae, ,comincia ad avvilupparla completamente, ora dopo ora, come
una crisalide. Alla fine, quando sono passate sufficienti ore, lei emerge
ricoperta di sangue, tremante, ma piena di visioni e pronta, dopo aver
riposato, a lavorare di nuovo. Teme i suoi scivolamenti nel dolore e nella
luce, e nello stesso tempo sospetta che le siano necessari. È libera da un po'
di tempo, adesso, da qualche anno. Sa quanto improvvisamente il mal di testa può
ritornare, ma ne sminuisce l'importanza di fronte a Leonard, agisce come se si
sentisse meglio di quanto a volte si senta. Ritornerà a Londra. Meglio morire
impazzendo completamente a Londra che evaporare nell'aria a Richmond.
|