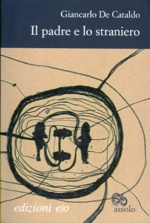
|
|
|
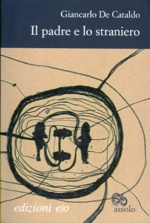
|
|
|
| << | < | > | >> |Pagina 9Diego fumava una sigaretta dopo l'altra in attesa di riprendersi il bambino. Mancavano dieci minuti alla fine della seduta. Tirava un fresco venticello autunnale, e, al centro dello spiazzo sterrato che separava il reparto dei convulsivi da quello dei cerebrolesi, alcuni ragazzi epilettici giocavano a rincorrersi sotto lo sguardo distratto di un'anziana signora intenta a sferruzzare. Due terapiste tentavano di mettere in posizione eretta un bimbetto dalla testa microscopica. Diego aveva già notato quella creaturina disarticolata, che sembrava uno scherzo della natura. Tra sé lo chiamava «il mostrino». Non vide l'uomo sinché non gli si sedette accanto, dal lato della panchina immerso nell'ombra. Un quarantenne alto e olivastro, profondi occhi neri, un'eleganza che rasentava la ricercatezza. Diego si mise a fissare con ostinazione la punta delle proprie scarpe. Di solito, i genitori si scambiavano un cenno di saluto o qualche commento sul tempo e sui figli. Diego non si era mai concesso il conforto di una chiacchiera. Che aiuto gli avrebbero potuto dare le lamentazioni o i consigli degli altri? C'era stato un tempo in cui aveva provato vergogna per la disgrazia che gli era capitata. Infine, s'era persuaso che nel dolore, così come nella rabbia, si è sempre soli e impotenti. L'uomo aveva preso a picchiettare col piede per terra, ossessivamente. All'improvviso gli sfuggì un profondo sospiro. Diego si sorprese suo malgrado a fissarlo. L'altro intercettò il suo sguardo e gli rivolse un sorriso mite. «Anche lei è qui per un figlio?». Aveva detto queste parole con calma, staccando nettamente sugli accenti. L'inflessione era incerta, ma sicuramente straniera, forse mediorientale, a giudicare dalla carnagione olivastra e dall'ombra di una barba che pareva sfidare anche la più accurata rasatura. Diego sospirò a sua volta, annuendo. «Di questa stagione, nel mio Paese, nei villaggi sotto le alture si fa grande festa. Danziamo per tenere lontano la paura dell'inverno. Mi chiamo Walid». Strinse la mano che l'altro gli tendeva e farfugliò un «Marini Diego» che lo fece sentire ridicolo e lo infuriò al tempo stesso. «Qual è il suo Paese?» aggiunse subito. «Oh, è un Paese molto lontano. Ma non è molto diverso dall'Italia. Anche lì ci sono le montagne e il mare, e ogni tipo di gente. Noi della costa diciamo che quelli della montagna si lavano poco, perché fa freddo. Quelli della montagna dicono che noi della costa puzziamo di pesce. Quello è mio figlio Yusuf». Era quindi il padre del «mostrino». Strano, però, lui così scuro e quel bambino con un ciuffetto di capelli biondi in cima alla testina... Poi ripensò al tono con cui aveva pronunciato il nome del bambino: con orgoglio e dolore. Di questo l'aveva rimproverato tante volte sua moglie, di non aver mai saputo dire il nome del figlio con altrettanto orgoglio e altrettanto dolore. «Il mio è ancora dentro» borbottò, alzandosi di scatto, «è ora che vada a riprenderlo». Quando raggiunse la sala della terapia, le ragazze avevano già rivestito Giacomo e una madre attendeva impaziente il suo turno stringendosi al petto una ragazzina dalle guance arrossate, che con la lingua esplorava senza sosta l'interno del palato. Diego si chinò a sussurrare qualcosa all'orecchio del figlio. Il volto del piccolo s'illuminò d'un sorriso radioso, e lo sentì lanciare il suo grido di felicità, un «eeeh-eeeh!» al contempo monocorde e modulato con cui lo ringraziava per averlo ripreso con sé, liberandolo dalle terapiste. Per lui ogni seduta era una tortura: ma si trattava, secondo i medici, di una tortura necessaria allo sviluppo del suo cervello malformato. In capo a due anni di assidue cure, Giacomo aveva imparato a sorridere ai genitori e a reggersi il ciuccio con il dorso di una mano. Riusciva a restare in piedi, se sorretto, per una trentina di secondi. Diego era ormai convinto di essersi rassegnato alla malattia di Giacomo: ma quando, certi giorni, in casa, si respirava un vago ottimismo per i «progressi» del piccolo, veniva colto da violenti accessi di rabbia. Tutta quella fatica gli sembrava inutile o, peggio, un'assurda violenza. Fosse stato qualcosa di più di un semplice impiegato del Ministero di Grazia e Giustizia, avrebbe potuto dire di sé stesso che, dopo la nascita del figlio, era morto dentro. Nel cortile ritrovò Walid: era al centro dello spiazzo, e ballava abbracciato al mostrino. La testa del piccolo pendeva da un lato, i suoi occhi erano vuoti, ma sulle labbra gli aleggiava lo stesso sorriso del padre. Si ritrovarono accanto, ciascuno alla guida del proprio passeggino, e percorsero affiancati il tratto di strada che li separava dall'uscita dell'Istituto. Sulla soglia della porta a vetri che immetteva in un lungo vialone trafficato si fermarono per dare un'aggiustatina ai bambini. Giacomo continuava a sorridere, un filo di bava all'angolo della bocca screpolata. Yusuf si era addormentato. Si scambiarono un cenno di saluto, sul volto di Walid riaffiorò il sorriso mite, poi si avviò in direzione di una lunga berlina nera parcheggiata di fronte all'Istituto. Dal posto di guida scese un mediorientale, in divisa da autista, s'inchinò a Walid e lo aiutò a sollevare il piccolo. Mentre si avviava verso la sua Panda scassata, Diego pensò che gli sarebbe piaciuto rivedere quel padre tanto sereno. E provò una profonda vergogna per aver pensato a Yusuf come al «mostrino». | << | < | > | >> |Pagina 14Il primo bambino handicappato della sua vita Diego l'aveva visto trentadue anni prima sui gradini della scuola media «Mazzini». In un giorno di pioggia, all'ora dell'uscita, mentre le scolaresche sciamavano verso la libertà. Se ne stava aggrappato alla madre grattandosi furiosamente un orecchio, tutti e due, madre e figlio, ingobbiti in due identici cappottini color grigio smorto. Nel passargli davanti, non aveva potuto reprimere un brivido incrociando quello sguardo vacuo. Per quanto non avesse che undici anni, quella fugace visione l'aveva tormentato a lungo, sino a spingerlo a parlarne con i genitori. La madre gli aveva detto che era solo un bambino sfortunato, il padre che sarebbe stato opportuno tenersi in casa certi spettacoli, e la cosa era finita lì. Qualche anno dopo, già adolescente, era stato battuto a ping-pong da un tipetto secco secco che reggeva la racchetta con la sinistra e al posto del braccio destro aveva una manica penzolante. Incuriosito, gli aveva chiesto di mostrargli che cosa si nascondeva sotto quella manica. L'altro aveva esibito prontamente un'aluccia da pernice, accennando qualcosa a proposito di una medicina dal nome curioso, Talidomide. Quella sera Diego era rincasato pieno di vergogna per il moto di ribrezzo che non era riuscito a nascondere. Il terzo bambino handicappato della sua vita era suo figlio Giacomo. Era nato di sabato mattina, e appena i medici l'avevano tirato fuori a forza dal ventre di Elsa, e gliel'avevano mostrato, piccolo e cianotico, grinzoso e muto, Diego aveva provato un'inspiegabile repulsione. C'erano voluti almeno cinque minuti perché Giacomo facesse sentire la sua voce, un belato flebile e discontinuo, il lamento di una creatura che non era stato giusto far venire al mondo. Diego aveva avuto una crisi di pianto che tutti avevano attribuito all'emozione per la recente paternità. Le lacrime di Elsa sarebbero venute in seguito, quando le diagnosi più accurate avrebbero confermato il sospetto del pediatra di famiglia: ma Diego ritenne a lungo di aver già speso tutto il proprio dolore in quel primo pianto premonitore. Mentre raccontava tutto questo a Walid, si rendeva conto di non averne mai parlato prima con nessuno. La storia andava avanti da quasi tre anni, e solo con quello sconosciuto aveva trovato il coraggio di aprirsi. Diego portava Giacomo alla terapia di sabato, il suo giorno libero. Era il terzo sabato che s'incontravano, e Walid aveva proposto di passare al tu. Sedevano al tavolino di un bar che fronteggiava un isolato di botteghe, con uno squallido garage a ore, laboratori di marmisti specializzati in lapidi destinate al vicino cimitero, un vinaio di povera gente, i muri istoriati di graffiti in vernice nera e rossa. Al tavolino accanto al loro tre operai in tuta maledicevano il governo e la cassa integrazione. Walid finì di sorseggiare il suo caffè allungato con acqua calda, e indicò le scritte sul muro. «Quella è contro il governo islamico di Iran» disse in quel suo italiano che sapeva più di studio delle grammatiche che di abitudine alla conversazione. «Vicino a casa mia ci sono scritte che dicono "Dio c'è". Pare siano opera di un pazzo». «Forse è Dio stesso» mormorò Diego. «Se esiste deve essere molto arrabbiato con noi. Ma se è così arrabbiato che per vendicarsi colpisce ogni tanto una persona a caso, magari una persona innocente, allora preferisco credere che non esista. Nel mio Paese molti credono in Allah e qualcuno in Gesù Cristo. Anche questo è un fatto che non mi convince. Tutti quelli che credono dicono che c'è un solo Dio. E naturalmente si tratta del loro Dio. Ma se Dio è uno solo, che importanza ha il suo nome? Ciascuno gli può dare il nome che preferisce, tu non credi?». «Non lo so. Quando ero molto piccolo andavo in chiesa, come tutti. E ho fatto la prima comunione e anche la cresima. Mi sono sposato in chiesa. Ho fatto sempre come facevano tutti». Walid tacque. Tornarono a concentrarsi sulla strada. Passavano massaie cariche di sporte da cui spuntavano sedani e sfilatini di pane. Passò un infermiere in camice bianco, trascinandosi appresso un ragazzo epilettico sui tredici anni. Per Diego era «il ragazzo-lupo»: per via del suo stare sempre curvo, degli urli che di tanto in tanto gli squassavano le mascelle, della forma inverosimilmente allungata del cranio, della massa di ricci che, dai capelli alla precoce barba, formava un insieme inestricabile, una grottesca criniera. Passò una studentessa in minigonna con una camicetta bianca che lasciava gioire al sole due seni esuberanti. La seguirono con lo sguardo scambiandosi un muto cenno d'apprezzamento. Walid sorrise. «La notte che è nato Yusuf, ho sognato che venivano tanti amici con le corone e dicevano che sarebbe diventato il re del suo popolo. E la mattina dopo, quando i medici mi hanno avvertito che c'era qualche problema, io ho pianto. Tu sei stato più fortunato, amico, perché quel tuo pianto è venuto dal cuore. Il mio veniva dal cervello. Tu hai capito prima di sapere. Io ho avuto bisogno che me lo dicessero altri». «Io penso che non è giusto» mormorò Diego. Walid gli disse di aver letto in un libro che il problema dei loro bambini era l'inesistenza del mondo. «Siamo noi che dobbiamo spingere il mondo verso di loro. Bisogna imparare a ragionare in un modo diverso. Altrimenti, il dolore uccide». Pagarono ciascuno la propria consumazione e poi tornarono in Istituto a riprendersi i figli. Prima di congedarsi, Walid disse a Diego di soffiare sul volto di Giacomo. «È un esperimento che hanno fatto gli psicologi. Se tu soffi sulla faccia di tuo figlio, e quello ride, vuol dire che è amato. Se piange, vuol dire che non gli vogliono abbastanza bene».
Diego sbuffò come un mantice sulle guance di
Giacomino, che lo lasciò fare, prima sorpreso, poi
interessato, finché non decise che ne aveva abbastanza, e si voltò da un lato,
senza un lamento né un sorriso.
|