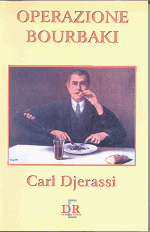
|
|
|
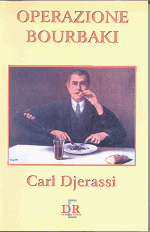
|
|
|
| << | < | > | >> |Pagina 12"Un visionario è una persona capace di vedere con gli occhi chiusi".I miei occhi erano chiusi. Sam mi stava spuntando le sopracciglia, mentre io pensavo all'isola di Virgin Gorda, cercando di ricordare quello che lei mi aveva detto. Doveva essere qualcosa del genere; ma c'era anche dell'altro... Cosa? "Fatto, Professore", disse Sam, strappandomi alla mia réverie. "Finisco in un minuto. Lasci che le dia una spazzolata. I capelli bianchi saltano all'occhio sul completo blu". Capelli bianchi, pensai. Da quando l'avevo incontrata, avevo preso a considerarmi un uomo dal manto argenteo. Sottili, pallidi capelli mi svolazzavano intorno, depositandosi dolcemente sul pavimento. "Sono la mia biografia", avrei voluto dire, ma non lo feci. Guardando in terra, tutto ciò che vedevo era la mia storia. Una biblioteca inesplorata che giaceva sul pavimento: volumi di Who's Who, storie della medicina, peccati inconfessati. Mi stavano talmente a cuore che non potevo sopportare di vederli spazzare via. Chi avrebbe mai pensato, due anni fa, che ci saremmo messi a contrattare per un filo anzi, per una porzione di filo di quelle due preziose ciocche di capelli di Abramo Lincoln, che contano in tutto 183 fili, nessuno dei quali più lungo di cinque centimetri. Come poteva il curatore lesinarci quei pochi millimetri di un solo capello, che ci sarebbero serviti per fornire una risposta alla decennale ossessione degli storici: Lincoln soffriva della sindrome di Marfan? Sarebbe morto comunque, attorno al 1860, anche se Booth non l'avesse assassinato? Era strano, pensai, mentre i miei capelli fluttuavano nell'aria, come tutte queste domande si riducessero a questioni sul morire: strano trovare nel cuore della vita così tante informazioni sulla morte. Eppure, come aveva avuto inizio tutto questo... Con una domanda di morte. Quante cose sono state spazzate via. Vite umane, qualcuno direbbe. Non mi ero reso conto di quanto fossero fragili o di quanto facile fosse dimenticarsene. Non avevo previsto quante altre vite sarebbero rimaste coinvolte nel processo. Per tutto il tempo durante il quale avevo costruito i miei propositi di vendetta, ero rimasto cieco dinanzi a ciò che avrebbero comportato. Nessuno di noi sarebbe più stato lo stesso. Eppure lei lo aveva capito fin dall'inizio. Ricordo ancora cosa mi disse, quando le confessai tutto, molto dopo che ci aveva ribattezzati "i quattro visionari". Mi fece piacere, allora: stuzzicò la mia vanità in un modo che dubito potesse immaginare. Mi conosceva ancora poco. Ma già a quel tempo faceva domande. Domande che avrei fatto bene ad ascoltare. "Sai che gli scienziati hanno la presunzione di scrivere?" La interruppi. "Direi 'l'orgoglio'".
"Orgoglio, presunzione... Θ lo stesso". Aggirò la mia obiezione. "Sono
entrambi incompatibili con Bourbaki".
"Finito", disse il barbiere e poi, dopo avermi squadrato, "Qualcosa non va?" "No, certo che no", ribattei. Cos'altro avrei potuto dirgli? Appena fuori, per le strade di Manhattan, che ogni mattina ancora mi sorprendono con la loro vitalità, la loro energia e la loro freschezza, dovetti ammettere che, sebbene la mia risposta fosse stata un automatismo, non avevo mentito. Non c'era nulla che non andasse. Per la prima volta in tanti anni, non una cosa era fuori posto. Che magnifica età la vecchiaia! | << | < | > | >> |Pagina 45Forse lo champagne aveva indebolito i miei riflessi, ma per un secondo o due mi sentii perso. Poi udii me stesso chiedere: "Facciamo cosa?" E ancora: "Noi?""Non essere stupido, Max. Non ti ricordi che cosa mi hai detto sulla spiaggia? Che non saresti capace di riuscirci". Non ricordavo niente del genere. "...A proposito della necessità di trovare il denaro e un indirizzo?" Stralunai gli occhi per la sorpresa. "Questo sarà il mio contributo. Ho sempre desiderato mettere su un salotto... sai, come quello di Madame de Sévigné e Madame de Tencin o Mademoiselle de Lespinasse. Mi piacerebbe avere il tuo Bourbaki come ospite del mio salotto scientifico". Ammutolii per la sorpresa, la confusione e l'irritazione. Un salotto non era affatto quello che avevo in mente. Nicolas Bourbaki in salotto? "Hai la minima idea" protestai "di quanto costi finanziare anche un semplice..." "Max". Era incredibile quante sillabe D3 era capace di trovare nel mio nome. "Ogni volta che voi scienziati parlate di un nuovo progetto, cominciate subito a lamentarvi di quanto poco denaro avete a disposizione e di quanto ne avreste bisogno. Piuttosto, perché non..." "Ma cosa ne sai tu degli scienziati e del loro bisogno di denaro... reale o esagerato che sia?" "Non ti avevo detto che, ai miei tempi, ne ho conosciuti parecchi?" Qualcosa fece click nella mia mente. "Che significa 'ai miei tempi'?" "Quando ero Preside". Pronunciò la parola Preside con la P maiuscola. "Preside di che?" Era la mia voce che gracidava oppure era solo un'impressione? "Lettere e Scienze alla New York University. Per sei anni... un tempo sufficiente a conoscere un gran numero di chimici, fisici e biologi... "Un momento, Diana". La mia voce era supplichevole, la testa mi girava e avevo bisogno di tempo per digerire la novità. Preside di Lettere e Scienze alla New York University? Si stava prendendo gioco di me? Perché non me l'aveva detto, allora, a Virgin Gorda? Evidentemente sul mio volto si dipingeva tutta la mia confusione perché, a questo punto, lei si chinò verso di me e prese la mia guancia nell'incavo della sua mano. Un modo molto efficace per mantenere il contatto visivo. "Max, non essere arrabbiato. Vuoi sapere perché non te l'ho detto quando ci siamo incontrati la prima volta?" Lasciò andare la mia guancia e si mise comoda sulla poltrona. "Tu sai meglio di me che cosa si aspettano i professori da un preside: denaro o favori o tutti e due. Un paio di settimane fa ho pensato e ancora di più lo penso stasera ecco un'opportunità di conoscere realmente uno scienziato. Spero che tu non ne sia dispiaciuto; perché io, fossi in te, non lo sarei". "No, non sono dispiaciuto". Mi rivolse un sorriso caldo. "E non credo che lo sarà il tuo Bourbaki, Max. Penso di potervi aiutare". La mia voce adesso gracchiò sul serio: "Come?" Il suo sorriso era diventato di nuovo misterioso. "Un buon preside impara a trovare soldi quando ce ne sono pochi. E io ero una preside eccezionalmente brava". Poi, dopo una pausa: "Ma tutto a suo tempo, si sta facendo tardi. Andiamo, voglio mostrarti un'altra cosa". Mi prese per mano e mi portò nel suo studio: la seguii docilmente. Ero ancora barcollante per quello che avevo appreso; stavo realizzando quante fantasie sbagliate mi fossi fatte su di lei. Cos'altro c'era che non sapevo? Ero determinato a scoprirlo e desideroso di sapere che cosa avesse in mente. Nello studio c'era una libreria che arrivava fino al soffitto; ciononostante i libri erano accatastati dappertutto, in gran confusione: segno certo di una biblioteca funzionante. La scrivania era piena di giornali e riviste; di nuovo, rimasi sorpreso. Questo non era lo studio di una donna, appositamente arredato; era un luogo di lavoro attrezzato a tale scopo. D3 scivolò verso la scrivania e cominciò a rovistare in un mucchio di carte. "Eccolo" disse con orgoglio "dai uno sguardo a questo". "Nicolas Bourbaki und die heutige Mathematik" recitava la pagina iniziale. Non ebbi alcuna difficoltà a dare un rapido sguardo al testo tedesco, ma quello che mi lasciò stupefatto fu il titolo del giornale, una rivista totalmente sconosciuta: Arbeitgemeinschaft fόr Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen. Si trattava del testo di una conferenza tenuta l'8 Gennaio 1958, niente di meno che dal grande matematico francese Henri Cartan, che si diceva essere uno degli scienziati che si nascondevano dietro il nome di Bourbaki. "Incredibile!" Mi uscì detto di bocca in un soffio, cosa che gratificò moltissimo D3. "Volevo che ti rendessi conto che avevo preso molto sul serio la tua idea di Bourbaki, almeno dal punto di vista storico. Non ho ancora completato la mia ricerca, ma ne so abbastanza per poterti dire che ci puoi riuscire, anche senza un nuovo indirizzo e un grande investimento". | << | < | > | >> |Pagina 76"Non proprio", disse, con quella specie di sorriso che è tipico degli studenti. "Mi riferivo all'istituzione dei salotti in generale. A proposito, hai letto nulla di Londa Schiebinger?""Mai sentita". "La mente non ha sesso". "Come scusa?" Diana sorrise, ma in un modo che non sembrava divertito. "Θ il titolo del suo libro. Parla del ruolo delle donne nelle origini della scienza moderna. Ti presterò la mia copia. Θ proprio il genere di cosa che ogni scienziato di sesso maschile e pédant dovrebbe leggere". Risparmiami, avrei voluto dire, mentre con voce chiara mi uscì un "Grazie tante!". Mi diede un colpetto sulla mano. "Rilassati, Max. Non intendevo sembrare maliziosa. Non questa volta, almeno. Tuttavia c'è un collegamento, tra Schiebinger e i primi salimi parigini, che m'interessa; ha qualcosa a che fare anche con la scienza e in qualche modo con il tuo progetto. L'autrice sostiene che le moderne istituzioni scientifiche provengono, innanzitutto dai monasteri e dalle università medievali, e poi dalle corti rinascimentali dei principi e dalle accademie reali. Ora quello che ti chiedo, Max, è: cosa hanno in comune tutte queste cose?" "Va avanti", le dissi, pensando con invidia al "grande maestro" Nishimura. Scommetto che nessuna donna giapponese farebbe domande simili. "Sono tutte istituzioni esclusivamente maschili. Le donne non avevano alcuna possibilità nella scienza dell'epoca". "Quindi?" "Quindi arrivano i salotti tanto influenti quanto le prime accademie europee che rompono il confino della vita intellettuale femminile. Tre delle maggiori salonnières la Marchesa di Lambert, Madame Tencin e Madame Geoffrin non solo attiravano attorno a loro gli scienziati, ma avevano il potere di fare o disfare la reputazione di un accademico. Gli osservatori contemporanei uomini, ovviamente non erano certo entusiasti di ciò". "Ovviamente" feci eco diligentemente. Mi sbirciò per vedere se le stavo facendo il verso, mentre io le restituii uno sguardo innocente. Ero tutto orecchie. Ed ero veramente interessato, perché tutto quello che aveva a che fare con il nostro gruppo di ricerca non poteva che interessarmi. "Rousseau si lamentava, con una segretaria di Madame Dupin, che a sua volta aveva avviato un salotto, del fatto che le donne stavano rovinando le lettere e le arti della Francia: 'Qualsiasi donna a Parigi scriveva colleziona nel suo appartamento un harem di uomini più effeminati di lei'. Ancora oggi si sentono dire cose simili delle donne al potere nelle industrie o al governo: che si circondano di uomini impotenti". "Pensi che sia vero?" Mi fissò inarcando le sopracciglia: "E tu?" Mi strinsi nelle spalle, ma prima che potessi rispondere, lei aveva già ripreso a parlare: "Sai bene cosa scrisse nel suo primo numero l'editore di La Spectatrice: 'a volte ammiro la superiorità degli uomini, che accusono noi donne di inconsistenza e frivolezza. A me sembra che quanto ad ambizione, amore e molte altre cose, desideriamo più degli uomini e, quando desideriamo, perseveriamo non meno di loro". Per un istante restammo entrambi in silenzio. "I salotti, ovviamente, non sono sopravvissuti alla Rivoluzione", Diana continuò, girando il suo tè freddo. "Non credo che le donne abbiano più avuto questo tipo di patronato sulla scienza. Piuttosto tutto questo potrebbe rivivere adesso, alla fine del ventesimo secolo". Mi fissò a lungo, così a lungo che alla fine distolsi lo sguardo. "Ad eccezione della causa femminista, non mi sono mai addentrata nelle questioni sociali. Mi sono resa conto che il tuo Bourbaki non rappresenta una causa 'tipica', al contrario fa risuonare in me una qualche corda. Mi piace l'idea di fare qualcosa di puramente intellettuale e di dargli una piega rivoluzionaria". Non so se fu il rumore che feci nello schiarirmi la gola, forse un po' apprensivo, un po' imbarazzato, a spingerla a prendermi la mano. "Non ti preoccupare", disse, "quello che voglio io non interferirà con la tua ricerca. La renderà solo più elegante". "E cos'è che vuoi?" Qualcosa mi diceva che la precisione era essenziale a questo punto, come se si stesse discutendo la stesura di un contratto legale. "Riunire uomini e donne nella scienza; riconciliare la scienza alle materie umanistiche; riconoscerle per quello che realmente sono: parti integranti di qualcosa di più vasto; qualcosa che difficilmente possiamo indicare per nome". "Tutto qui?" chiesi, ma lei non sorrise. "Fino ad ora gli scienziati non hanno avuto parte alcuna nella mia vita. L'averli conosciuti, come preside, non conta: allora eravamo piuttosto su fronti avversi. Mi piacerebbe vedere come lavorate, qui dentro, intendo dire", e mi picchiettò con l'indice sulla fronte, per quattro volte e con una certa forza. "E magari potrei essere il vostro collante istituzionale", aggiunse. | << | < | > | >> |Pagina 137[...] C'è una storiella, le dissi, sull'importanza di un buon mentore: quella della volpe che interrompe la dissertazione di laurea del coniglio. La guardai in attesa di un suo cenno."Non l'ho mai sentita", disse. Sospetto che l' avesse sentita e che fosse soltanto una ragazza ben educata, ma andai avanti e gliela raccontai comunque. Non era una brutta storiella, anche raccontata da me. "Il coniglio sta battendo a macchina la sua tesi", cominciai, "quando arriva una volpe. 'Non mangiarmi proprio ora', disse il coniglio. 'Lasciami finire, prima'. 'Che co'è?' chiese la volpe. 'La mia dissertazione di laurea', disse orgoglioso il coniglio. 'Oh! E qual è il titolo?' domandò la volpe. 'Come i conigli catturano le volpi'. 'Ma è tutta sbagliata: sono le volpi che catturano i conigli'. 'Vieni, lascia che ti mostri come', disse il coniglio, conducendo la volpe in una caverna là vicino. Dopo poco, il coniglio tornò da solo e riprese a battere a macchina. Ben presto fu interrotto da un lupo e si ripetè la conversazione avuta con la volpe. Quando il coniglio tornò nuovamente alla macchina da scrivere, un picchio, che aveva osservato la scena, chiese: 'Che sta succedendo qui? Cosa hai mostrato alla volpe e al lupo?' 'Vieni a vedere nella grotta'. Affacciandosi cautamente all'entrata, il picchio vide un leone che stava finendo i resti della volpe e del lupo. 'Vedi', gli spiegò il coniglio, 'il titolo della dissertazione non è importante. Come non lo è chi la scrive. Tutto ciò che conta è il tuo supervisore'. Aspettai la risata che questa storia solitamente suscita soprattutto quando la racconto ai laureandi ma Jocelyn si limitò a sorridere, con quella grazia che ci viene data soltanto per nascita e che mi fece sentire sciocco. "Io metterei un altro finale: in ultimo il coniglio rititolò la sua tesi 'Come i conigli usano i leoni'". "Davvero?" Chissà perché tutti, in quei giorni, sentivano il bisogno di rivedere le mie conclusioni.
Si strinse nelle spalle. "Θ la versione dei laureandi".
Credevo di aver conosciuto la gran parte degli umori di Charlea, ma la sua voce al telefono, quella mattina, era indecifrabile. "Credevo che avessimo avuto un solo predecessore", disse. "Nicolas Bourbaki. Eri stato molto persuasivo a riguardo". "Aspetta un attimo, Charlea. Ti metto sul vivavoce". Mentre mi stendevo sul divano l'unico arredo di lusso che ero riuscito a far entrare nel mio ufficio cercavo di ricordare chi di noi avesse per primo suggerito di usare il vivavoce nelle conversazioni lunghe. Non lo rammentavo, ma non era importante: il vivavoce era diventato un'abitudine. Era utile per prendere appunti, vagare per l'ufficio o, come in questo caso, ascoltare da una posizione supina. Ad ogni modo, ti metteva in una migliore predisposizione all'ascolto. VAi al punto, Charlea, avrei voluto dirle. Ma sapevo che non mi avrebbe portato lontano. "Quindi?" dissi e attesi. "Quindi ho delle novità per te. Non sei il primo ad aver pensato di seguire la linea di Bourbaki. Mai sentito parlare di Isadore Nabi?" "No", dissi, a rischio di sembrare petulante. "Aha. Ne ero certa. Lui o esso o loro sta proprio qui, a Chicago". "Bene, raccontami, allora". Non avevo idea di cosa stesse parlando, ma con Charlea non è mai troppo presto per mettersi sull'offensiva. "L'ho scoperto soltanto ieri. A pranzo con Leigh Van Valen, l'editore di Evolutionary Theory". "Vuoi dire che gli hai parlato di noi?" dissi, sollevandomi dal divano. "Non essere sciocco, Max. Io non gli ho detto un bel niente. Lui mi ha raccontato". "Va avanti", dissi e mi rimisi steso. "Richard Lewontin, Richard Levins, Robert MacArthur e Van Valen rivoluzionari della Chicago anni Sessanta sono stati i primi a utilizzare la matematica a fini ecologici e a legarla alla biologia delle popolazioni. Non è il mio campo, ma sentii parlare di loro, quando arrivai a Chicago. Alcuni di loro soprattutto Levins e Lewontin hanno ottenuto anche una certa notorietà politica. Sapevi che Levins ha rifiutato la candidatura della National Academy of Sciences. "No, non lo sapevo". In verità non sapevo proprio nulla di loro. "Neanche che ha fatto accludere la sua iscrizione al partito comunista in Who's Who? O che Lewontin si è dimesso dalla NAS? Che razza di gruppo! Ad ogni modo, pare che abbiano una simpatia per i biologi 'soft' della popolazione". Potevo praticamente vedere la faccia con cui aveva detto 'soft'. C'erano ben pochi dubbi su dove riponesse le sue simpatie. "Organizzano le loro piccole riunioni estive a casa di uno dei loro congiunti, a Marlboro, nel Vermont. Sanno tutto di Bourbaki. Un giorno, Lewontin ha proposto agli altri tre di pubblicare insieme sotto pseudonimo". Si fermò. Sapevo che lo stava facendo per accentuare l'effetto, ma stranamente mi sentii ferito nell'orgoglio. "E allora? Che nome si sono dati?" "Nabi. Isadore Nabi" | << | < | > | >> |Pagina 177Era stata un'idea di Sepp. Non il viaggio in sé: eravamo infatti tutti d'accordo sul bisogno di cambiare aria, per scrivere i risultati degli esperimenti sulla PCR. Ma la destinazione Villa Malaparte a Capri era stato un suggerimento di Sepp. Dopotutto, aveva puntualizzato, sono sempre venuto io dalla vostra parte dell'Atlantico. Non era forse giunto il momento di invertire la rotta? Senza contare che Sepp e Hiroshi erano stati invitati a un seminario della NATO alla Stazione Zoologica di Napoli. Charlea aveva il suo finanziamento del NIH, che copriva gran parte delle spese del viaggio a Capri abbinandolo a una visita alla European Biophysical Society di Heidelberg. Restavo solo io. In genere i miei viaggi a carattere scientifico erano spesati. Dovevo solo pagarmi gli extra: come le acciughe o i peperoni sulla pizza. Ma per la prima volta in molti anni, mi ritrovai a pagare di tasca mia un aereo per l'Europa.Al nostro arrivo, Sepp era in uno stato di agitazione che non gli avevo mai visto: esuberante e gioviale. "Aspettate di vedere Villa Malaparte", aveva detto con orgoglio. "Il posto è incredibile, fantastisch". Anni prima, l'aveva vista durante una gita in barca: ancorata in cima a un promontorio roccioso, accessibile soltanto via mare e con la sua vista sui faraglioni, aveva lasciato su di lui un'impressione indelebile. Di recente, aveva saputo che era stata acquistata da una fondazione, che la usava per seminari di architettura e, all'occasione, la offriva a studiosi e artisti per i loro incontri. Senza dire niente a nessuno, si era dato da fare per convincere la Fondazione Giorgio Ronchi a concederci la casa per una settimana. Ed eccoci qui, a Capri: noi cinque, senza Jocelyn, che non poteva perdere un corso obbligatorio a Princeton, ma con Diana. La Fondazione Giorgio Ronchi non le diceva molto, ma lo scrittore Curzio Malaparte le diceva abbastanza da auto-invitarsi al nostro ritiro. "Perché no?" aveva detto Sepp. "Ci sono sei camere da letto". Stavamo ansimando su per gli scalini di roccia, che dal minuscolo approdo ci portavano all'edificio rosso pompeiano, costruito in cima a una sporgenza rocciosa su Punta Masullo. Due scalinate poste ai lati della villa, e simmetriche l'una all'altra, portavano alla terrazza, con uno stile che mi ricordava quello dei templi Maia. Arrivati in cima, rimasi stupito nel vedere qualcosa che violava tutti i codici architettonici americani: per tre lati il terrazzo non aveva parapetto o balaustra che potesse impedire a un visitatore di precipitare, per più di cento metri, sulle rocce sottostanti fino al mare. Ci guardammo bene dall'avvicinarci al bordo del terrazzo. Dal centro, invece, sembrava di galleggiare sul Mar Tirreno, circondati ai lati e dietro dalle ripide pendici di Capri. Una volta preso possesso delle nostre stanze, Diana si dilettò in un'inaspettata lezione di storia, che ovviamente si era preparata per il nostro arrivo. "Sapevate che il vero nome di Malaparte era Kurt Erich Suckert?" Sepp la guardò attonito, come se fosse stato appena accusato di averci nascosto questo oscuro segreto sugli ascendenti tedeschi di Malaparte. Ma Diana lo aveva oltrepassato con lo sguardo, andando a cercare la parete di roccia che separava le vetrate panoramiche del salone. In contrasto con l'azzurro del cielo, la vista mi retsituì l'immagine di una gelida cella frigorifera. "Cambiò il suo nome all'inizio degli anni Venti", disse, "quando, sotto Mussolini, molte persone italianizzarono il loro nome. Dapprima fu fascista" colsi subito il disagio di Sepp, che andava crescendo man mano che lei parlava "ma poi diventò un fervente antifascista. E poco prima della sua morte, nel 1957, si convertì al Cattolicesimo e lasciò la sua villa a Mao!" "Suvvia, Diana", cominciai con tono di rimostranza, "non vorrai mica dirmi che siamo in una villa cinese di Capri". "Questo è il fatto", disse compiacente, "ma fortunatamente per noi, i cinesi e gli italiani non avevano relazioni diplomatiche negli anni Cinquanta e, pertanto, il testamento di Malaparte non è stato eseguito". Ci guardò e scoppiò a ridere. "Penso sia meglio se mi dedico a qualche faccenda domestica, prima di unirmi a voi". Si era trattato soltanto del suo pallino per la storia o D3 stava cercando di dirci qualcosa? "Sapevate che il suo libro più famoso s'intitola Kaputt?" Scosse la testa. "Malaparte... Kaputt... Siete certi che tutto questo non porterà sfortuna al capolavoro della vostra Skordylis? Senza dubbio, il posto è spettacolare". Si voltò verso di me e bisbigliò: "Max, devi venire in camera mia. Non credo che tu abbia mai visto nulla di simile". La mia stanza da letto mi aveva sorpreso, molto, ma non in una misura tale da spingermi a mostrarla ad altri. Hiroshi, Sepp ed io occupavamo tre delle quattro camere a pian terreno: piccole, scure, quasi simili a celle monastiche. Solo una volta aperti gli scuri, la luce e la vista dissipavano quell'atmosfera claustrale. Charlea e Diana occupavano le due stanze al piano superiore, raggiungibili solo attraverso il salone. Erano così diverse? "Qui è dove Malaparte ospitava la sua amante", mi spiegò D3 appena aperta la porta. Sebbene più ampia della mia e con due letti, non c'era nulla di eccezionale nella sua camera, eccetto un pavimento di mattonelle fiorate e uno splendido camino fatto di maioliche che salivano fino al soffitto disegnando una piramide. Non male, rispetto alla mia camera, pensai, ma difficilmente meriterebbe una visita privata. Come se mi avesse letto nella mente, Diana bisbigliò: "Non questa" e mi condusse nell'adiacente bagno "Questo". Dinanzi all'entrata c'era una lussuosa vasca da bagno incassata - in verità, una piccola piscina - delimitata per tre lati da mattonelle a righe grigie e bianche. Il pavimento sembrava di alabastro o marmo. "Non male, mormorai. "Guarda la vista".
"Il Faraglione di Matromania".
|