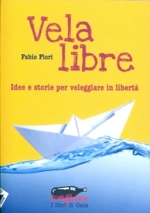
|
|
|
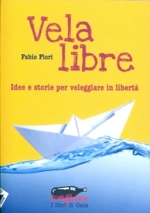
|
|
|
| << | < | > | >> |Indice
Prima di mollare le cime 5
1. Vela, ecologia e libertà 19
2. Un uomo, una barca 29
I velisti 29
Le barche 36
Le storie 42
3. Barca minima, rotta massima 54
Due orizzonti: l'usato e l'autocostruzione 58
Terzo orizzonte: l'imbarco 62
Un tempo, un sogno 64
4. Altre vele 83
Acquee 84
Terrestri 90
Aeree 92
Prontuario velico 95
Scie librarie 110
Web Ocean 118
Gran pavese 123
|
| << | < | > | >> |Pagina 2| << | < | > | >> |Pagina 4Barche amarrate
...
Le vele le vele le vele
Che schioccano e frustano al vento
Che gonfia di vane sequele
Le vele le vele le vele!
Che tesson e tesson: lamento
Volubil che l'onda che ammorza
Ne l'ombra volubile smorza...
Ne l'ultimo schianto crudele...
Le vele le vele le vele
Dino Campana, 1912 | << | < | > | >> |Pagina 5
Alcuni anni fa... avendo pochi
o punti denari in tasca e nulla di particolare
che m'interessava a terra,
pensai di darmi alla navigazione
e vedere la parte acquea del mondo.
Herman Melville, Moby Dick, 1851
Come bambini che scoprono il mondo, con tutta la loro carica di vitalità, cominciamo ad affermarci con tre indispensabili no. Le domande ci vengono da un vecchio pedante e oggi anche consumista, chiamato Luogo Comune. Per l'occasione il vegliardo ha un secondo cognome: Nautico. Per andare a vela è necessario essere dei superuomini? No, assolutamente, tanto che la vela permette il confronto, anche sportivo, tra uomini e donne, vecchi e bambini. In mare, l'abilità vale più della prestanza fisica, la conoscenza è più utile della forza. Addirittura c'è chi fa della vela una pratica terapeutica, chi ancora prende il mare per affrontare una malattia o la vecchiaia. Molteplici sono i progetti di recupero da problemi psichici e fisici legati alla vela. Un'attività sportiva e culturale che meglio di altre si presta per stimolare interessi e curiosità, per creare relazioni e superare difficoltà di diverso tipo. In mare, i problemi sono affrontabili attraverso una solidale partecipazione dell'equipaggio. A bordo tutti, dal comandante al mozzo, devono fare la loro parte, perché la buona riuscita della navigazione dipende da chi traccia la rotta, da chi sta al timone, da chi regola le vele, da chi prepara un caffè caldo. Anche su una piccolissima barca, impegnata in una breve veleggiata lungocosta, ognuno deve avere il suo ruolo ed essere consapevole delle sue responsabilità. A bordo, non sono necessari superuomini individualisti, anzi sono pericolosi quando le condizioni diventano impegnative; sono invece utili i marinai che hanno ben chiara un'antica regola: "Una mano per sé e una per la barca". Non a caso la parola equipaggio, che deriva dal francese équiper ossia fornire del necessario, rimanda a equo, equità, equilibrio, cioè all'origine latina, Çequus, uguale. Si è parte di un equipaggio quando si riconosce l'uguaglianza di tutti, nella diversità dei ruoli. Anni fa, sull'Isola di Lussino in Croazia ho avuto la fortuna di conoscere un tedesco paraplegico che trascorreva tutte le estati da solo, navigando con la sua barca a vela di otto metri tra le isole istriane, dalmate e greche. Negli anni, il marinaio e la barca erano diventati un perfetto e coordinato organismo marino. L'acqua aveva ridato a quell'uomo la leggerezza, il vento gli aveva restituito la forza. Sul mare era riuscito a superare tante difficoltà motorie e a realizzare, in modo ecologico, la sua passione per il viaggio, in completa autonomia e libertà di movimento. Epica rimane l'esperienza di Francis Chichester che nel 1966, a sessantacinque anni, decise di mettersi in mare con il Gipsy Moth IV, una barca a vela di sedici metri, per circumnavigare il Globo in solitario senza alcun scalo. Raggiungerà i mari australiani in centosette giorni, per ritornare al porto inglese di partenza in altri centodiciannove giorni, ricevendo una meritata, entusiastica accoglienza. Molto clamore fece allora l'età avanzata del protagonista, perché l'avventura venne vista anche come una sfida alla vecchiaia. Ma fu lo stesso Chichester a liquidare questa stortura, scrivendo che era assolutamente consapevole di avere a disposizione un tempo misurato. Non voleva contrastare l'invecchiamento, ma pretendeva da se stesso il miglior rendimento, per poter vivere appieno, con soddisfazione. Visto che la maggior parte di noi non ha certo questo tipo di velleità oceaniche e che la vela è innanzitutto un esercizio fisico e mentale nei mari di casa, fino a diventare una pratica zen, si può subito concludere dicendo che tutti, dai sei ai cento anni possono veleggiare anche da soli. Bisogna scegliere la barca giusta e la rotta adeguata alle proprie possibilità, mai dimenticando che, per quanto atletici, esperti e preparati, il mare rimane per tutti infinitamente più potente. È Joseph Conrad , grande marinaio prima che altrettanto grande scrittore, a ricordare che il mare non è mai stato amico dell'uomo. Qualche volta è complice delle nostre irrequietezze o ambizioni. Il mare è stato, e sarà sempre, un dio severo, capace di dispensare inusitate gioie e terribili pene. Forse parte della fascinosa attrazione del mare sta proprio in questa ambivalente complicità, perché ci sono giorni in cui navigare è esperienza dolcissima, altri in cui è prova severa. Per noi, che sul mare non lavoriamo, le prime dovrebbero essere le occasioni più frequenti, quelle offerte da un Mediterraneo che è da millenni culla del mestiere del navigare, riprendendo le parole di Conrad.
Quindi, per navigare a vela in sicurezza e con piacere, alla
forza è da preferirsi l'abilità, all'audacia la prudenza, all'esuberanza la
pazienza. Con gli anni e le miglia, a queste
tre qualità s'intreccerà l'esperienza, dandoci la più robusta
delle cime di sicurezza, preziosa quanto l'indispensabile
life-line
di bordo. Una vela manovrata con abilità, prudenza
e pazienza, porterà lontano, oltre qualsiasi nostro immaginato orizzonte,
geografico ed emozionale.
Per andare a vela è necessario fare un corso? No, anzi, dispiace dirlo, ma ho conosciuto bambini che dopo un corso di vela non hanno più messo piede in barca. Perché non vincevano, non avendo la miglior barca con la miglior attrezzatura. 0 ancora perché la vela era diventata una pratica militare e la disciplina aveva soffocato la fantasia. Attenzione: ciò non significa che non ci voglia impegno e dedizione per imparare a manovrare vela e timone, ma istruzione non significa per forza corso. Anche perché la stessa parola è probabilmente inadatta ad un'iniziazione alla vela. Corso si ricollega al latino cŭrrere, correre, e per il nostro modo di andare per mare questo verbo non è necessario. Per altro, in passato "correre il mare" significava esercitare la pirateria, mentre al contrario ciò che ci interessa è un vagabondare, libero, ecologico e pacifico. La miglior iniziazione alla vela passa attraverso un'uscita in barca con un amico o, per chi non ha questa fortuna, in una prima cima raccolta in banchina, da sempre il preludio a una concreta occasione per lasciare la riva. Giorno dopo giorno, miglia dopo miglia, impareremo a orzare e poggiare, a cazzare e lascare, ma soprattutto scopriremo gli infiniti piaceri offerti gratuitamente dall'acqua e dal vento. È sempre l'insuperabile scrittore anglo-polacco a ricordaci che sono necessarie molte lezioni, dell'uomo e del mare, per forgiare un vero marinaio, che non deve però perdere l'ancestrale richiamo di libertà regalato dalle onde e dal vento. Se poi le curiosità e le ambizioni si fanno impellenti, vale la pena di iscriversi a un corso, con le idee però un po' più chiare. Consapevoli che nessun istruttore potrà imporci il correre come fine, che le boe rimarranno prima di tutto galleggianti per l'ormeggio, che si può, anzi si deve, andare a vela senza alcun spirito competitivo. Certi che la regata sia al massimo parte di una più grande avventura, di un più duraturo amore. Sempre inseguendo l'arcana rotta delle parole, per descrivere il primo approccio alla vela, il termine più adeguato potrebbe essere iniziazione, visto che iniziare, initiare, significa introdurre ai misteri religiosi, e il mare ha innegabilmente una dimensione spirituale. Seguendo la lezione orientale, se la vita senza scopo è argomento fondante di tutte le arti zen, allora praticando la vela senza scopo, consciamente o inconsciamente, ognuno di noi si avvicina al vuoto meraviglioso. Ogni volta che alziamo una vela e lasciamo la riva portati dal vento, senza alcun fine se non quello di assecondare gli elementi, entriamo a far parte dell'armonia della Natura. Una Natura a cui l'uomo appartiene, senza alcuna velleità di dominio. Una veleggiata nella luce augurale dell'alba o in quella nostalgica del tramonto, nel buio punteggiato dalle stelle o in quello luminoso della luna, è un haiku, una poesia senza parola. Ritornando in Occidente, quale parola migliore del latino ōtĭum possiamo associare alla vela? Ozio nella sua accezione positiva, inteso quindi non come inerzia, né pigrizia, ma come tempo libero ragionevole e dignitoso. Non dimentichiamo, poi, che ōtĭum nel mondo latino aveva sostituito il greco schole, scuola. Perciò l'ozio velico, praticato sulla più piccola e semplice delle barche, è tempo libero nell'accezione sportiva e culturale, è scuola di manualità ed ecologia. Perché, per andare a gonfie vele bisogna saper assecondare le nostre esigenze a quelle del mare e del vento; perché ogni volta che issiamo una vela ci rimettiamo all'ordine naturale. Partendo dalle illuminanti considerazioni filosofiche, religiose e letterarie sull'ozio sviluppate da Seneca e Petrarca o, in tempi più recenti, da Bertrand Russell e Hermann Hesse , potremmo approdare alle nostre più leggere riflessioni sull'ozio velico. Un tempo saggiamente sottratto agli obblighi, anche a quelli vacanzieri, troppo spesso altrettanto stringenti. Un viaggiare lento, in cui il tempo non deve per forza essere succube dello spazio. Anzi, andando a vela dedichiamo ore, giorni e stagioni ai luoghi, vicini e lontani, raggiunti nella grazia dei venti. Vela libera, orizzonti aperti, un vento largo. | << | < | > | >> |Pagina 11Per andare a vela è necessario essere ricchi?No, perché se il mare è libero e il vento gratuito, non può certo essere costoso viaggiare a vela. La considerazione è talmente retorica che non occorrerebbe dilungarsi, se non fosse che il diporto si è sviluppato negli ambienti aristocratici inglesi dell'Ottocento, per essere poi spesso declinato nel Novecento nella sua dimensione consumistica. Scriviamo consumistica e non commerciale, perché chi non riesce a fare a meno di possedere una barca dovrà in qualche modo acquistarne una, preferibilmente usata, o comprare i materiali per costruirsela. Quindi, la dimensione commerciale è, nella concretezza dell'oggi, una parte imprescindibile per chi vuole prendere il largo con la propria vela. Inutile, anzi deleteria, è invece la frenesia consumistica del "metro in più" che infetta tanti appassionati, ossia la malattia di una barca sempre più grande, comoda, tecnologica, luccicante. Eppure, la grandezza non è detto sia sinonimo di sicurezza, la comodità come insegnano gli stoici è un vizio, la tecnologia è spesso inaffidabile, la lucentezza è madre di tante inutili fatiche, un tempo cruccio di marinai, proprio costretti a "lucidare gli ottoni". Per andare a vela serve certamente qualche soldo, l'equivalente del prezzo di una buona bicicletta o di uno scooter usato, ma non è assolutamente necessario essere ricchi. Al contrario la barca grossa e nuova induce spesso a schiavitù lavorativa o pirateria finanziaria. Schiavitù e pirateria che con gli antichi eroismi di alcune storie marinaresche non hanno niente in comune. Veleggiando su una piccola barca, si scopre l'immutato fascino di sostantivi oggi desueti, quali sobrietà e frugalità, assieme ad altri spesso ridondanti perché vuoti, quali sostenibilità e serenità. Tutto questo non significa immaginare e dedicarsi a una pratica di sacrificio ascetico, ma svincolarsi dalle catene del quotidiano, almeno per un giorno. Magari per un mese o un anno, per riscoprire l'eterna saggezza epicurea che invita alla rinuncia del superfluo, perché ciò che serve lo si può trovare facilmente, l'inutile più difficilmente.
In questo caso basta una piccola vela, un mare e un vento
propizio. Con una certa facilità, ancora oggi ci si può imbarcare come semplici
marinai. Oppure se si vuole essere
completamente liberi e magari solitari, è sufficiente una
vecchia, minuscola deriva. Quattro metri di barca, sette
metri quadrati di tela, un remo che non guasta mai, è tutto quello che serve per
solitarie veleggiate verso infiniti
orizzonti o deserte spiagge fortunatamente ancora non
raggiungibili via terra. Ricco non è chi ha un super-yacht,
con dieci uomini d'equipaggio, con cui lascia l'ormeggio
abituale solo d'agosto per raggiungere affollatissime banchine di grido. Ricco è
chi, al contrario, può armare sulla
spiaggia di fronte casa la sua barchetta tutti i pomeriggi,
per andare da solo o in compagnia di un figlio, di un amore o di un amico, a
godersi il tramonto nel silenzio del mare. Certi che i colori, gli odori e i
rumori dei crepuscoli d'autunno, d'inverno e di primavera sono altrettanto
affascinanti di quelli d'estate e che una
bella giornata
vince la storia, come insegna
Raffaele La Capria.
Una bella giornata mediterranea, in cui il mare è tutt'uno con il cielo, uniti
da quel vento che muove le onde e le nuvole, o che gratuitamente può spingere i
nostri sogni. Vivendo lungo le rive,
quale migliore occasione di quella offerta da una dolce
brezza per cogliere la bella giornata? La felicità è farsi portare al largo da
un venticello che riesce appena a screziare
la superficie del mare, sufficiente a muovere la nostra piccola, sobria vela
verso un grande, magnifico, orizzonte di libertà.
Attraverso i no il giovane velista che è in noi si è liberato della soggezione nei confronti del vecchio Luogo Comune Nautico.
Ora non resta che rispondere a un'ultima domanda, sganciata dallo spirito
dei tempi.
Per andare a vela è necessario avere tempo? Sì. Se il tempo è diventato la vera ricchezza dell'uomo occidentale, allora mi devo subito contraddire per affermare che per andare a vela è necessario essere molto ricchi. Ma questa è ovviamente una contraddizione solo apparente, perché, svincolati dalla retorica di questi anni, stiamo parlando di un bene immateriale. Ancora una volta viene in aiuto la saggezza greca, attraverso un aforisma di Epicuro: "La ricchezza della natura è delimitata e facile da avere, quella delle vane opinioni si perde nell'infinito". Del tempo, una fortuna regalataci con la vita dalla natura, dobbiamo riappropriarci, consapevoli che avere tempo è una di quelle virtù strettamente connaturate con la felicità, perciò inalienabili. A vela, oggi come sempre, si naviga più o meno a quattro nodi che, per chi non ha ancora troppa confidenza con l'acqua, equivalgono a circa sette chilometri all'ora. Certo, sia con una piccola deriva che con un moderno cabinato, in condizioni di mare e vento favorevoli, si possono raggiungere velocità più elevate. Ma l'esperienza insegna che quando la rotta si allunga, e come in Mediterraneo le condizioni si fanno spesso variabili, alla fine i quattro nodi rimangono una buona media. A ciò si aggiunga che, anche d'estate, capitano giornate di maltempo o venti contrari. Queste condizioni impongono soste forzate al navigante, spesso occasioni per inaspettati incontri e nuove scoperte. La vela richiede tempo, molto tempo, o forse, come qualsiasi altra forma di viaggio, semplicemente un giusto equilibrio tra spazio e tempo. Diversamente la si confonde con il charter, quell'essere aviotrasportati in luoghi più o meno remoti per salire su un'anonima barca a noleggio che, come un povero cane alla catena, ha un limitatissimo orizzonte, del tutto privo di fascino. La vela ha bisogno di tempo anche nella meticolosa preparazione della barca, nella indispensabile attenzione al meteo, nella scrupolosa pianificazione della rotta. La barca, le vele, le attrezzature, devono essere continuamente controllate prima e durante il viaggio; dalla loro accurata manutenzione dipende la sicurezza e il piacere della navigazione. La sua durata non è solo legata alle nostre capacità e alle qualità della nave. Perché il vento e il mare dettano i loro tempi, favorevoli o sfavorevoli, capaci di diventare fausti o infausti. Tempo va poi dedicato allo studio geografico del viaggio, breve o lungo che sia, ai caratteri delle coste da raggiungere, delle baie dove gettare l'ancora, dei porti d'approdo. Se tutto ciò non pesa, se ogni ora e ogni giorno dedicato alla barca come alla cultura marinaresca è vissuto piacevolmente, allora siamo pronti ad alzare una vela facendo rotta su sconfinati orizzonti. La nostra isola, le nostre terre al di là del mare, magari vicinissime geograficamente, rimarranno sempre luoghi di reconditi misteri, abitate da popoli sconosciuti, capaci di rivelare inaspettati segreti. Solo il tempo chiesto dalla vela, quello lungo, comune al remo, al cammino e alla bici, può rivelare ancora oggi paesaggi inesplorati. Utopia non è lontana, non si trova nel nuovo mondo, come lo chiamavano i contemporanei di Tommaso Moro. Noi, a differenza loro, non ci vergogniamo a confessare di non conoscere dove si trovi quell'isola. Siamo invece certi che ognuno, andando a vela, riuscirà ad approdarvi, tempo permettendo. Nel silenzio della riva, una voce odissiaca c'invita ad attendere il vento propizio che gonfierà benevolmente la nostra vela. La riuscita del viaggio sarà poi soltanto una questione di tempo, quello necessario non solo a riprendere confidenza con l'eterna mobilità delle acque, ma anche quello utile a fantasticare geografie e genti utopiche. E ancora, prima di ogni altra cosa, il tempo ci servirà a ritrovare una sensibilità ambientale pericolosamente perduta. Perché il mare obbliga le mani a stringere cime e barre, gli occhi a vedere cirri e stelle, le orecchie ad ascoltare fruscii e gorgoglii, il naso a fiutare odori di terra e largo, la bocca a sentire acque dolci e salate. Quella ecologica è una crescita culturale che richiede una quotidiana immersione sensoriale, ossia un'imprescindibile materialità del vivere, in armonia con la natura. | << | < | > | >> |Pagina 25Il vento è gratuito, il mare è libero, la vela è ecologica.
Fissati in maniera chiara questi tre assiomi, ognuno può
formulare e sperimentare una propria aritmetica del viaggio e del piacere
velico. Rotte personali, diventando collettive, fanno scoprire le gioie della
condivisione. Rotte attuali, intersecandosi con quelle storiche, restituiscono
una necessaria appartenenza culturale. Rotte reali, faticate nel
vento e nel sale, ridanno un senso ai luoghi. Rotte fantastiche, alimentandosi
con racconti e visioni, permettono di mantenere vivo un rapporto con il mare.
Vela e libertà o libertà e vela; come nella più elementare delle operazioni, il risultato non cambia invertendo l'ordine dei termini. Diverso è invece l'ordine dato dagli uomini nei secoli a questi due sostantivi. Infatti oggi la vela è una pratica dilettantistica, sportiva, filosofica o di viaggio, diventando per alcuni il mezzo per scoprire e godere della libertà. Per secoli, al contrario, la libertà era il fine raggiungibile spesso solo attraverso la vela. Orizzonti libertari erano quelli agognati dagli eroi omerici, dai coloni greci, da tanti pirati oceanici o mediterranei, secondo alcune argomentate riletture storiche. Tra gli altri, Markus Rediker ha studiato le numerose esperienze di utopie libertarie inseguite e tragicamente combattute da una gente di mare multietnica, indispensabile paradossalmente per la nascita del capitalismo, anche nella sua spietata ultima metamorfosi finanziaria. Una gente di mare storicamente invisibile, perché fin dall'origine repressa con violenza, schiavizzata, incatenata, anche nel buio della stiva. Nell'immaginario comune, frutto spesso di una storia scritta dai vincitori, la pirateria ha un'accezione esclusivamente negativa. Non va dimenticato invece che tanti rinnegati, schiavi e ammutinati, cercarono di ribellarsi alle catene di un feroce capitalismo, costruendo sui ponti di velieri avventure di emancipazione e comunione. La storia reale e quella fantastica, non meno importante, è costellata di isole raggiungibili solo a vela: le pelasgiche Elettridi, l'odissiaca Itaca, la platonica Atlantide, la rinascimentale Utopia, la profetica Taprobana, l'egualitaria Eleuthera, la leggendaria Libertalia. Un vero e proprio arcipelago mitologico, le cui sognate coste si disvelano solo a chi con coraggio e audacia si mette in mare, alzando una vela e confidando nell'aiuto dei venti. Ciò non significa idealizzare la vela, dimenticandone i sanguinari usi militari e commerciali. Perché la vela è stata per secoli asservita alle più spietate vicende umane. Utilizzando il titolo di un famoso libro di Carlo Cipolla , vele e cannoni hanno viaggiato sulle rotte di ogni oceano. Nel Cinquecento, inglesi e olandesi presero il definitivo sopravento marittimo perché seppero impiegare in maniera massiccia ed efficiente micidiali macchine del vento e del fuoco. Quella che Cipolla chiama era marittima dell'energia umana, dei rematori delle galee, si è chiusa con il perfezionamento della vela, altrettanto pericolosa ma sicuramente più efficiente sulle lunghe distanze. In quegli anni le fortune militari e commerciali si costruirono sostituendo i remi con le vele, le balestre con i cannoni, oltre a impiegare non più rozze e numerose risme di rematori, ma ridotti equipaggi di marinai, abili alle manovre di vascelli sempre più grandi e veloci. L'Europa atlantica ideò, realizzò e sperimentò con tragico successo velieri armati di fuoco, nel corso del XIV e XV secolo. Un'invenzione che rese possibile l'espansione europea e le conseguenti terribili nefandezze. L'incredibile ascesa delle nazioni atlantiche è legata anche alle abilità di costruzione e impiego di caravelle, caracche, galeoni, fregate, corvette, brigantini, armati di decine di cannoni bocche di fuoco. Rimangono comunque indiscutibilmente associate a idee libertarie tante storie di vela, a cominciare appunto dalla più antica narrazione mediterranea di viaggio: l' Odissea. Sarà una vela, gratuitamente offerta dal re Alcinoo, a riportare Odisseo nell'amata Itaca, a ricondurlo sull'isola dopo aver patito tanti dolori sul mare. Ai giovani Feaci è dato il compito di scortare l'eroe sulla rotta del ritorno. Marinai ferrati al timone, al remo e alla vela. Bianche vele spiegate a un vento finalmente benevolo, che spinge la flotta verso le acque di casa.
Ogni volta che riprendiamo il mare sulla nostra piccola barca, possiamo
incrociare le vele della storia e del mito. Vele
leggendarie, corsare o letterarie, tutte accomunate dal voler portare oltre
l'orizzonte un sogno di libertà. Su quella
scia mettiamo il nostro quotidiano bisogno di muoverci liberamente, attenti solo
alle onde e ai venti. Rimaniamo ancora oggi in cerca di un'isola dove gettare
gratuitamente l'ancora, nella speranza di incontrare nuovi
utopiani
e apprendere come le loro istituzioni continuino ad essere
prudentissime e giustissime,
come delle loro qualità, noi abitanti di questa bulimica
Distopia,
continuiamo ad avere un disperato bisogno.
Per concludere con la necessaria ironia questa divagazione velica, tra filosofia, ecologia e cultura, un invito: "Velisti libertari di tutti i Paesi, unitevi". | << | < | > | >> |Pagina 29
Avevo un bisogno assoluto
di ritrovare il soffio dell'alto mare...
Non si chiede a un gabbiano addomesticato
perché ogni tanto provi il bisogno di sparire
verso il mare aperto. Ci va, e basta. È una cosa semplice
come un raggio di sole, normale come l'azzurro del cielo.
Bernard Moitessier, 1968
I velisti Ma chi è la o il velista? a quale particolare varietà di essere umano scopriamo di appartenere, giorno dopo giorno, miglia dopo miglia o anche pagina dopo pagina? | << | < | > | >> |Pagina 31SognatoreChi vive la vela come esperienza innanzitutto onirica, a prescindere dall'ora, dal giorno, dalle stagioni, dell'anno e della vita. La barca ha per lui significati arcadici, è luogo di vita idilliaca, separato dalla realtà, di certo lavorativa, a volte famigliare. Perciò, piccola o grande, in acqua o a secco, pronta alla navigazione o solo progetto ideale, diventa comunque un rifugio ameno e romito. Mentre non nega a nessuno di guardarla, centellina attentamente l'invito a bordo. Quando la barca è in banchina, preferisce l'ormeggio di prua. Tenendo il pozzetto più lontano dalla riva cerca un distacco dal mondo e un'intimità con i fedeli. In questa visione religiosa, il ponte diventa il nartece, il pozzetto la navata, il boccaporto l'iconostasi che separa dal presbiterio. Scesi gli scalini, si raggiunge un mondo oscuro, immerso in un rumoroso silenzio acqueo. Lì, preferibilmente disteso su una ascetica panca di legno, il sognatore vive esperienze marine mistiche, di navigazione oceanica, orizzonti infiniti, isole lontane. Della vela non importano i ferzi e le bugne, il taglio e i materiali, ma prima di ogni altra cosa l'usura. La vela come sindone eolica, immagine di venti favorevoli e contrari, di burrasche e bonacce, di incaute attraversate o sapienti approdi. Il viaggio concreto sfuma in quello ascoltato dai marinai, le miglia percorse in quelle narrate dai libri, le onde tagliate in quelle dipinte su tela. La navigazione è dissolvenza, in un infinito mare forse mai solcato, di certo fantasticato.
Il velista sognatore nella più elevata incarnazione può arrivare a praticare
la rinuncia, alla barca o addirittura alla navigazione. L'ascesi velica, al pari
di quella religiosa, è un esercizio spirituale e fisico. Attraverso digiuno,
isolamento, meditazione, astinenza all'acqua e al vento, sublima la passione per
la vela. Ho conosciuto sognatori che non sapevano nuotare e non erano mai saliti
a bordo, ma conoscevano tutto di barche, vele e ancore, di onde, venti e porti.
Vagabondo Chi vive la vela come concreta, ecologica ed economica possibilità di viaggiare o restare che, come insegnano i più illuminati antropologi, sono esperienze profondamente intrecciate. Ciò che accomuna le due opzioni è l'idea del vagare, la consapevolezza del valore insito nell'andare senza meta o scopo preciso. La barca, di proprietà o d'imbarco, è valutata per le sue qualità marinaresche; una sempre perfezionabile sintesi di semplicità ed efficienza. Questo secondo aspetto è svincolato dal primato della velocità o della capacità di stringere il vento, dalla possibilità di andare in qualsiasi direzione a prescindere dalle condizioni meteorologiche. Al contrario, la barca del vagabondo tendenzialmente asseconda i capricci delle onde e dei venti, insuperabili dispensatori di inaspettate meraviglie. Consapevole del fascino delle scoperte legate alla casualità; pronto a vivere il cielo e il mare come luoghi imprevedibili per definizione. Vagabondo, nell'accezione velica, è insieme giramondo e nomade. Ossia, colui che ama viaggiare per il mondo, lontano e vicino, senza direzione prevista, perché vuole assaporare appieno significati ed emozioni dell'incontro con genti e approdi, barche e coste, culture e tradizioni, arcaiche o contemporanee. Il vagabondo condivide, magari inconsciamente, con il nomade il piacere di non avere fissa dimora, di cui la barca anche se eternamente ormeggiata nello stesso porto incarna l'archetipo. Perché quando è nel suo elemento, anche quando non si sposta di un miglio, gode dell'eterna mobilità dei flutti. Il vagabondo apprezza della vela le doti utili a portarlo lontano, con poca spesa e molta resa, in miglia e avventure. Una barca deve essere molto robusta, facilmente manovrabile, adatta alle tante condizioni che il mare impone. È più importante poter vegliare sonnecchiando, che dover vigilare sempre con la massima attenzione, magari solo per guadagnare qualche nodo di velocità, per raggiungere un'ora prima un approdo, per scegliere uno scalo di qualche miglia sopravento. Viaggiare e restare sono due verbi solo apparentemente antitetici. Lo spiega bene l'antropologo Vito Teti che sostiene, senza enfasi retorica ma con profonda e vissuta consapevolezza, che restare è la forma estrema del viaggiare. Soprattutto in un tempo come il nostro, in cui il mondo sembra a portata di click e l'esotico è più una faccenda da turisti che da viaggiatori. Solo la vagabonda pratica quotidiana del restare permette il rivelarsi dei luoghi, terrestri e acquei. Solo il velista vagabondo può ri-scoprire isole lontane o vicine, acque placide o tempestose, venti favorevoli o contrari, rinnovando il fascino di odissiache narrazioni. Capaci di rivelare i misteri del viaggio, che non è mai esclusivamente una questione di miglia percorse. | << | < | > | >> |Pagina 42Le Storie
Per meglio restituire le qualità del velista, di colui che, senza obbligo
esteriore ma con grandissima spinta interiore,
decide di prendere il largo, ci saranno d'aiuto tre storie
emblematiche. Quelle di uomini e barche che nel Novecento, attraversando gli
oceani, sono diventate un tutt'uno,
compiendo una vera e propria metamorfosi, diventando
forme mutate in corpi acquatici nuovi, parafrasando
Ovidio.
Nel mito, le navi care a Cibele diventano Naiadi marine, con prue che si
trasformano in volti, remi in gambe e
braccia, pale in mani e piedi, chiglie in colonne vertebrali,
cordami in chiome. Nella storia, i marinai devoti a Nettuno
diventano tritoni particolari, per metà uomini e per metà barche.
Joshua Slocum e Liberdade "Questa mia barca letteraria, di modello e attrezzatura indigeni, parte carica di fatti strani che sono capitati in una casa galleggiante". Con questo incipit, Joshua Slocum , avvia il primo dei suoi reportage marinareschi, Il viaggio della Liberdade, pubblicato nel 1890. Un viaggio, velico e letterario, che aprirà a Slocum ancor più ampi orizzonti, quelli del primo navigatore solitario capace di portare a termine un giro del mondo, nel 1898. La barca con cui compì L l'impresa era lo Spay, lungo appena undici metri. | << | < | > | >> |Pagina 46Bernard Moitessier e Joshua"Una volta che la prua è verso il largo ci si sbroglia sempre". Con queste poche parole Bernard Moitessier sintetizza perfettamente migliaia di miglia percorse, centinaia di pagine scritte, decine di anni trascorsi a bordo, invitando tutti quelli che sentono l'attrazione del mare a non tergiversare, a mollare gli ormeggi al più presto. Moitessier lo fece la prima volta a ventisei anni, a bordo dello Snark, trainato da un dragamine verso la foce del fiume Saigon. Nel Golfo del Siam, lui e un amico alzarono le vele su una barca divorata dalle teredini che, secondo il suo racconto, imbarcava cento litri di acqua al giorno. Malgrado le difficoltà e l'inesperienza, di chi era stato capitano solo a bordo della sua piroga, era partito verso l'Australia. Voleva lasciarsi alle spalle le terribili violenze dell'Asia e rimanere lontano dalle chiacchiere della vecchia Europa. | << | < | > | >> |Pagina 50Alex Carozzo e Zentime"Avevo solo un desiderio: costruire per navigare e navigare con il minimo di mezzi", raccontava Alex Carozzo negli anni Novanta, a riguardo della sua ultima traversata in solitario dell'Atlantico. Un'avventura unica, perché fatta a bordo di una scialuppa di salvataggio di sei metri, trasformata in barca a vela con materiali di fortuna, battezzata Zentime. Un nome che è già un manifesto d'intenti, sintesi appropriata delle storie marinaresche di questo novecentesco Ismaele, mezzo genovese e mezzo veneziano. | << | < | > | >> |Pagina 89L'ultima novità velica è il kitesurfing, diffusosi solo nell'ultimo decennio. Kite in inglese significa aquilone e antichissime sono le sperimentazioni di utilizzo per il traino. Le origini mitiche non possono che farci volare in Oriente, da sempre terra di aquiloni. L'interesse per questo tipo di vela si accese, poi, in Inghilterra nell'Ottocento, dove George Pocock progettò, sperimentò e raccontò le sue avventure a bordo del charvolant. Carrozze trainate da aquiloni, pur tra mille difficoltà, diventarono sperimentali macchine eoliche.Oggi con kite di forma alare, manovrati da due o quattro lunghi e sottili cavi, chiamati linee, collegate a una barra di controllo, a sua volta unita mediante un trapezio al kiter, si raggiungono grandi velocità, paragonabili solo a quelle del windsurf e dei poliscafi. Le ali, completamente in tessuto, a seconda dell'intensità del vento vanno da 8 a 16 metri quadrati di superficie, le tavole lunghe circa 1,5 metri, pesano solo qualche chilogrammo e le linee sono lunghe una trentina di metri. Possono navigare in un ampio intervallo di intensità del vento, da 8 a 30 nodi. Quindi si possono usare con una brezza sostenuta, fino a condizioni impegnative anche per barche più grandi. Ormai non c'è spiaggia dove non sia possibile assistere allo spettacolo di queste vele colorate che ondeggiano dolcemente in aria. Trainano invisibilmente nuovi equilibristi che corrono veloci sulle onde, divertendosi e facendo divertire, sperimentando consciamente o inconsciamente nuove soluzioni ecologiche di trasporto. | << | < | > | >> |Pagina 95Composizione: principi attivi, 30 vocaboli marinareschi e alcuni loro contrari, di uso comune su velieri piccoli e grandi, di ieri e di oggi; eccipienti: brevi divagazioni etimologiche, folkloristiche e letterarie. Indicazioni: trattamento preventivo utile al mozzo per entrare a far parte dell'equipaggio, al marinaio per scoprire qualche isola sconosciuta. Controindicazioni: al momento, non ne sono state segnalate. Posologia: una parola al giorno per un mese. Effetti indesiderati: a bordo dei più recenti glamour-yacht, la maggior parte di queste parole risultano assolutamente inutili, a volte disdicevoli. Avvertenza uno: alcune parole sono proprie del linguaggio tecnico, altre molto comuni; tutte celano significati o storie inusuali, anche per i marinai più esperti. Avvertenza due: chi naviga con piacere tra le parole come tra le onde, troverà infinite gioie nell'insuperabile Vocabolario marino e militare di Alberto Guglielmotti, pubblicato nel 1889 e ancora ristampato.
Avvertenza tre:
l'antica ricchezza verbale della lingua
marinaresca italiana si lega indissolubilmente alle differenti lingue
mediterranee che in passato contribuirono a comporre una lingua franca, parlata
dal Medioevo all'Ottocento a bordo dei velieri, a prescindere dalla loro
bandiera, e nei porti, da tutte le genti di diversa fede o etnia.
Addugliare
Raccogliere correttamente una cima in spire concentriche, in
matasse chiamate duglie. Antico verbo d'ascendenza genovese, quasi scomparso
sulle barche, piccole e grandi. Eppure, di
cime ne rimangono tantissime a bordo, e raccoglierle in modo corretto è
indispensabile per non trasformarle in pericolosi e inestricabili grovigli, per
non incattivirle, usando un altro
termine marinaresco. Si adduglia la cima sempre a partire
dall'eventuale dormiente, la parte fissa, togliendo a mano a
mano le volte al corrente, la parte libera. Canapi e catene che
non si tengono in mano si abbisciano, cioè si dispongono a
spirale in modo da poterle poi svolgere senza difficoltà.
Alare
Tirare con forza una cima, il più delle volte riferito a una
barca portata fuori dall'acqua. Così, in un funambolico gioco di parole, la
barca si ala, mette le ali, quando lascia l'acqua per l'aria. Il suo contrario,
altrettanto magico, è il varare. Il varo è un momento topico nella storia della
barca che chiede come ogni battesimo un officiante e una liturgia, sacra, pagana
o profana, comunque altamente simbolica.
Tanto che se alare è rimasto verbo d'uso solo marinaresco,
varare ha assunto ben più ampi e articolati significati.
Ancora
Vocabolo antichissimo e mediterraneo per eccellenza. Davano fondo all'
āncora
i Latini e, prima di loro, all'
ánkyra
i Greci. Emblema di speranza nell'esemplare descrizione di
Joseph Conrad e, forse per questo motivo, l'ancora è il simbolo più tatuato sui
corpi dei marinai. Attenzione: l'ancora
non si getta mai! La si leva o gli si dà fondo. Lungo sarebbe l'elenco delle sue
forme, diverse le parti. Quelle comuni a tutte sono la cicala, l'anello di
collegamento alla catena, il fuso, l'asse principale, e le marre, una o più
parti che vanno a infilarsi nel fondo. Imprescindibile avere sempre a
disposizione un'ancora di salvezza. Per la gente di mare era
semplicemente il ferro.
Armare
A bordo significa attrezzare, di materiali e di uomini, entrambi utili alla
navigazione. Così si arma tutte le volte che si decide di prendere il largo e la
barca è in armamento quando, completa di attrezzature ed equipaggio, può mollare
le cime. Tutte le operazioni di armamento si fanno all'ormeggio, poi in
mare le manovre prendono nomi propri. Ad esempio, si borda una vela, quando si
regola, o si dà mano ai remi, quando il vento molla. "Compagni, preparate e
armate la nera nave e imbarchiamoci per compiere il viaggio", è l'esortazione di
un antico comandante, per stirpe di Itaca, figlio di Odisseo.
Beccheggio |