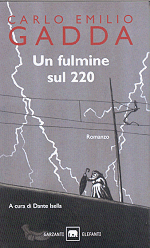
|
|
|
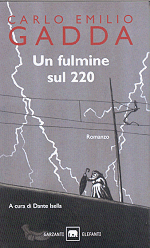
|
|
|
| << | < | > | >> |Indice
Avvertenza 5
I. (1932)
Primo getto 11
II. (1933-1935)
Capitolo primo: La crisi domestica 57
Capitolo secondo: Pane al disoccupato 75
Capitolo terzo: Un'orchestra di 120 professori
[parte prima] 93
[parte ultima] 113
Capitolo quarto: Nuove battute sul Politecnico vecchio
Ouverture (Il simposio) 197
III. (1936)
Capitolo primo: Vita difficile nei prati di San Colombano
[A] 217
[B] 225
[C] 233
Appendice
La moglie del Cavicchio [prima stesura di II 1] 237
APPARATO CRITICO
Dossier 253
Postille e note di lavoro 269
Nota al testo 275
Documenti 305
|
| << | < | > | >> |Pagina 15Se tutto è ragione a sto mondo, e se ogni fatto deve avere la sua causa, dove cercarla, dove cercarla per un fatto simile? Sono cose che fanno dubitare della Divina Provvidenza! ma no, no, Vergine Santa, è impossibile, è impossibile, bisogna proprio diventar matti. Tra le lacrime, si soffiavano il naso: breve e sommessa, in un bel fazzolettino donna Ernesta, moglie del Pizzigoni, perentorio e potente, seduto e piantato a gambe larghe, in un gran fazzolettone, il Pizzigoni medesimo, liquidissima e complicata, con un seguito di rumori brodosi e spugnosi, la sorella del Pizzigoni, signorina Teresa; e la signora Adalgisa, l'altra cognata, piena di singhiozzi di protesta, contro il destino. Era lei che parlava e protestava per tutti. Erano tutti abbastanza ben vestiti; lui d'un vestitone bleu, dove poteva starci abbastanza comodo, per quanto enorme fosse, con una cravatta verde scuro, cioè anzi marron, da funzionario delle Ferrovie dello Stato, ma era invece il gerente della vecchia ditta Pizzigoni Giovanni e Figli, quella del Ponte Vetero, nota casa fabbricante di cartonaggi. Sua sorella era adorna di una volpe un po' patita, ma pur sempre patetica, e nel cappello di una penna eretta, la dirittura della quale puntava verso l'alto e contrastava singolarmentea con il suo silenzio piangente, rotto soltanto dai soffiamenti di quel naso così acquatico. Donna Ernesta, come al solito, si era meravigliata anche lei, sull'esempio dell'altrui meraviglia, e piangeva anche lei dato che gli altri piangevano. Era una figura molto distinta, dal viso dolce e rassegnato, natante in un boa nero e piumoso; soffuso di quella dolcezza un po' accorata della donna lombarda, con due orecchini un po' troppo lunghi, che il boa veniva a nascondere, con un senso pieno di buone intenzioni casalinghe. La sua voce, un po' velata, la si sentiva raramente, poche volte era lei che parlava e quelle poche si era certi di assaporare un congiuntivo sbagliato. Ma la signora Adalgisa pareva proprio la più disperata di tutti. Robusta ancora e vegeta, eccelleva nel lasciar andare certi schiaffi a' suoi quattro figli che li sentivano di là dal «tavolato» i vicini, per solito con la bocca piena e il fiato corto. Erano quattro maschi, uno più brutto e più disperato dell'altro, come accade spesso nelle più distinte famiglie lombarde. Questi quattro esseri non avevano ancora avuto occasione di manifestare la loro maschilità se non rincasando a pranzo dopo scorribande sporchi e frusti; e «con via il culo», come diceva con bella e casalinga ipotiposi lombarda la loro casalinga mamma, alludendo al fondo dei pantaloni. Gli schiaffi li prendevano in silenzio, sorvolando via con una naturalezza tranquilla a mangiar altre castagne, dopo il contraccolpo rapido con cui la stabilità della persona aveva reagito alla manata materna. Ossuti e nasuti, era un po' una cera di famiglia, infarinati di castagne lesse tutto il davanti de' giubbetti, e coi ginocchi nudi ridotti dal freddo e dalla terra come al derma rugoso dell'elefante, salutavano i raffinati parenti mettendosi le lunghe dita nel lungo naso dove frugavano e frugavano con la paziente sagacia d'un chirurgo indefesso che accanitamente cerchi e più non trovi quel che s'era messo a cercare. Oppure, dopo un lungo silenzio pieno di otto occhi imbecilli, uscivano improvvisamente in una sghignazzata collettiva di cui nessuno riusciva a spiegarsi il perché. Finché tre o quattro schiaffi tremendi li lasciavano completamente interdetti, loro e anche tutto il parentorio, incerto fra la cristiana compassione e il cristiano senso del «ben meritato!». Ma insomma, sono particolari di poca importanza: nonostante i pantaloni frusti dei quattro disperati e l'acquisita parentela dei Pizzigoni, (parenti però, alla lor volta, dei nobili Pizzigoni di Gavirate, quelli di via Spiga), la famiglia da cui discendevano Donna Ernesta e suo fratello il nob. Gianmaria Cavigioli, era una delle più distinte famiglie della nostra vecchia e cara Milano. Gente ancora di vecchio stampo, intendiamoci, ossia, quel che è giusto è giusto: non si può pretendere di rimaner sempre allo stesso punto, una nazione moderna deve pur evolversi, deve progredire, anche il compianto nob. Emmanuele Lattuada lo diceva sempre, fra un domino e l'altro, alla Patriottica, suscitando la giusta ammirazione. Ma si dice per dire, la serietà, la dirittura del carattere, quel bisogno di fondarsi sul solido, quei principi sani e nello stesso tempo moderni, che sono la più sicura base della famiglia e nello stesso tempo della società: che sono l'«arra», come diceva la Perseveranza. E invece quel po' po' di disgrazia! Neppure il delegato, così i Cavigioli e ramificazioni chiamavano il cav. Lo Cascio, della polizia giudiziaria, neppur lui era in grado di farsi un'idea. «E chi ce ne capisce un cavolo?», aveva detto fra sé e sé l'emerito funzionario, nel mentre cercava di gettare un ponte di possibili intese idiomatiche fra sé e la vecchia Milano. | << | < | > | >> |Pagina 35Carità, gentilezza e vivezza facevano della signora Margherita la stella mattutina de' poveri e degli sconsolati; il suo viso era paragonato spesso a quello delle Madonne, come s'è veduto, e non solo dai Cavigioli. Mentre tutti della sua casa erano inclini a quella serietà e a quelle virtù globali che rendono così assenti certi ceti borghesi dai dibattiti primi della vita collettiva; dono primo e divino la parola, che è fatta per dire l'animo e per sentire bei verbi ben coniugati, ma certe persone serie credono che sia un imbroglio de' venditori ambulanti su fiera; e avevano verso la gente quel tono di distacco che consegue all'idea d'una superiorità metafisica, mentre si tratta semplicemente d'un paltò scuro e d'una congenita incapacità morale e civile a ricordarsi che la vita è una < >, non una < >, d'una ottusa trascuranza de' doveri primi e perentori, in guerra e in pace, in guerra a versare i pitali e in pace a stigmatizzare gli arrivisti: e non salutavano per via se non chi fosse pari loro, cioè serio come loro, impaltonato come loro, inutile come loro nella storia degli uomini e pietosamente come loro tollerato e servito, pro bono pacis; la signora Margherita sentiva quasi circolare tutta sta miseria popolare e sta chiacchiera dentro la sua calda sensibilità di donna, bella, d'antico vigore e dolcezza, che il povero Carlo aveva fin troppo amata e il nob. Gian Maria si era dimenticato di fecondare.– Fra la trombosi e la sciatica passavano, sullo schermo effimero della fantasia, della povera gente, dei tram, dei garzoni di lattaio.Affetto da una varicosi assai pronunziata, il suo povero Carlo era, in fondo, un bell'uomo: quando aveva finito di spogliarsi sui polpacci aveva dei gnocchi di vene turgide, rossobluastre, peloso, ma come Jago non c'era nessuno che potesse stargli a paro... Quando raccoglieva il fazzoletto, un fremito correva tra la folla... Però, adesso i ritratti, ne' quattordici album, avevano come perduto un po' del dominio che allora esercitavano su di lei. Adesso anche i tempi eran precipitati, tra Secolo illustrato e Mattino illustrato, fra l'Illustrazione che trovava da Armando, durante la pettinatura, e la Domenica del Corriere a cui s'era abbonata in sordina (perché i Cavigioli la trovavano un po' sospetta, oh Dio, c'era anche quel numero che poteva andare...), adesso, a furia di foot-ball e di «Spiagge nostre» sul Secolo illustrato e sul Mattino illustrato, a furia di articoli Hollywoodiani sul Corriere, ad opera dei minotauri pregni dell'estetica nazionale, adesso di gambe de' figli di Eva e d'Adamo ne sapeva anche lei qualcosa di più di allora e non tutte eran varicose. Vigorelli, ad esempio, il portiere della Juventus aveva due gambe! Martinetti, lo springer della sei giorni berlinese, idem idem, Learco Guerra non erano da buttar via neanche quelle... il terzino destro del Bologna... La signora Margherita conchiudeva «poveri ragazzi», ignara che la povertà è più veramente propria d'un altro genere di professionisti.
Le gambe di suo marito, di Gian Maria, erano d'un bel giallo, tra
l'alabastro e l'avorio, con pochi peli ma sentiti, tra il pollo e il fico
d'india: non erano varicose però; erano magre e poco propense, purtroppo, a
quella vibratilità così nervosa e meravigliosamente allusiva, che fermava
tanto facilmente il suo sguardo, nel «Luce», su quelle del terzino destro, del
centro sinistro e del corner, Juventini o Ambrosiani
E le gambe dei Cavigioli come dovevano essere?... Ma del resto, senza andar
tanto nel difficile, anche quel mascalzone... da ragazzo!... Era il ragazzo,
ossia il mascalzone, che la Signora Vigoni aveva insignito del suo sdegno, sulla
porta della chiesa... In quei quattro anni, dopo le sue nozze, s'era fatto un
giovane, e da giovane era andato e era tornato «di soldato», doveva essere uno
sportivo... veniva con la cesta colma, lasciava il suo chilo di filetto o
difesa...
Saliva di corsa le scale, i potenti muscoli mangiavano quattro a quattro i
gradini... Ridisceso infilava la bicicletta senza curarsi di nulla.
E Donna Margherita tornava con il pensiero ai suoi poveri, alla vecchia
Caterina – nel suo stambugio tossicolosa e malata – con quella latrina sul
terrazzino – in fondo in fondo... che pareva, prima d'arrivarci, di dover
precipitare nel vuoto del cortile; rivedeva la Teresa, la povera bimba della
lavandaia «dei panni di colore», lasciata sola in casa, con un bavaglino sucido,
sbrodolato di briciole e del caffé latte. «Buon appetito» c'era scritto sul
bavaglino, il fuoco era spento, il gatto era via - inorridito da quel
gelo - le manine si screpolavano dai geloni... la bimba piangeva... piangeva...
E quando diceva le sue bugie, franco e sicuro che non ci credevano ma
facevano il possibile per crederci... Diceva una bugia prima di mezzogiorno,
all'Alice, per poterne dire un'altra alla Regina, alle sei alla Pierina... «Come
è bravo lei...» diceva l'Alice ballando. «A ballare con lei, sì, che mi
diverto... quel sciavatton d'on camola d'on sò amis el dovarìa imparà propri de
lü...»
Cugini, amici, rivali, con botte e senza botte, impallidivano spesso: ce
n'era tante di donne a sto mondo! da venirne stufi.
Il bello era stato con la Noemi, una bella mora, levò la fotografia che
teneva ancora con sé: «questa era una donna», si disse... La fotografia
rappresentava una bella mora al naturale, cioè nella sua natural condizione, una
specie di velo, una specie di sofà, tra l'harem del Kedivé e quello del vicolo
Scaldasole: un velo che evaporava facilmente, al primo strale d'amore, come la
mattutina nebbia, ai primi raggi del sole. E dire che da lui non aveva mai
voluto un centesimo! E gli aveva voluto bene davvero. Se gli aveva voluto bene.
Che donna! Sorrise, orgoglioso, al ricordo... L'unica volta che aveva rubato,
era stato per lei: mezzo kilo di lacetto, al padrone: perché dovevano fare
un risotto, coi tartufi... in famiglia. Le aveva regalato un anello, un anello
vero, ma bello... per ricordo... Aveva un bambino a balia, un bel piccinino –
quando parlava del bambino quasi piangeva... Che stupida! gli faceva vedere
il ritratto... «Sto baüscia». Quante sigarette gli aveva regalato... quanti
baci... «Domani vieni anche domani a trovarmi?...» gli diceva sempre,
baciandolo, baciandolo, piena di paura e di speranza... Che gli amici dicevano
sei diventato signore, guarda, fumi le Sultana, le Kedivé, fammele sentire un
po' come sono... Era tutto un Egitto, tutta una roba moresca, un palmizio...
Svoltato via, passato appena il pisciatoio di via Scaldasole; un altro mondo
insomma!
Robusta e calzata di tutto punto, definita e piena, entrò costei col noto
sorriso e con una borsetta di pelle, a salutar donna Elsa, che s'era levata. In
seno alla famigliola, però, ella si teneva in arnese casalingo ed eccelleva da
anni nel lasciar andare certi schiaffi ai suoi quattro figli che li sentivano di
là dal tavolato i vicini, all'ora di tavola, con la bocca piena e il fiato
corto. Erano quattro maschi, quattro nasi, otto mascelle, una più cagnazza
dell'altra, poveracci. Questi quattro esseri riapparivano a pranzo, dopo
scorribande ne' prati delle Ròttole, a cui essi conferivano i nomi immaginosi
dell'India, della savana e della giungla, popolandoli di sogni e di paurose
tigri, gattopardi e serpenti, e rivestendoli d'una vegetazione tropicale:
sebbene sian fertili solo di vecchie scarpe marce e di qualche sorpresa anche
più carogna.
Come maschi, non avevano ancora avuto occasione di manifestare la loro
maschilità se non rincasando trafelati e strapazzati, sporchi e frusti, dopo le
cacce d'Africa, e con «via il culo», come diceva con bella ipotiposi lombarda
la loro mamma, prima di averli presi a schiaffi. Per il fondo dei pantaloni,
ecco, nessuna carità, non c'era più speranza, nemmeno per lucidare i parché.
Vergogna! Seguiva la commemorazione dei sacrifici fatti per «educarli» e «farli
studiare».
Gli schiaffi li prendevano in silenzio, come niente fosse, scivolando via
con una naturalezza tranquilla a mangiar di sottecchi altre castagne altre
aràchidi, dopo il contraccolpo elastico con cui la stabilità della persona aveva
reagito alla sberla materna. Regolarmente privi di fazzoletto, come potevano, di
quando in quando, allorché un gocciolone stava per formarsi sotto il doccione
del naso, «tiravan su l'affitto», come si dice da noi; non avevano, al riguardo,
grandi esigenze. L'Adalgisa, interrogata premurosamente, s'era proprio indugiata
a parlar di loro e Donna Elsa se li vedeva davanti, uno a uno. Ossuti e
precocemente nasuti, era un po' una cera di famiglia, infarinati di castagna
lessa il davanti de' giubbetti, e coi ginocchi ridotti dalla vita della giungla
ad esser come il derma rugoso dell'elefante. Donna Elsa li vedeva in imagine
salutare imbarazzati, arrossendo, i parenti, ottemperando quasi con fatica
all'esortazione materna, e poi subito mettersi il lungo dito nel lungo naso:
oppure, sotto lo sguardo severo della mamma, che anelava solo a far pompa dei
suoi Gracchi al quadrato, e dopo un silenzio pieno di confusione, uscivano
improvvisamente in una sghignazzata collettiva di cui lì per lì nessun parente
riusciva a spiegarsi il perché. Finché allora tre o quattro schiaffi tremendi li
lasciavano completamente interdetti, «così imparerete, vergogna!», e impietosito
tutto il parentorio.
Il discorso dell'Adalgisa prese una piega strana, dietro le cacce d'Africa.
In realtà era successo, (ma certi dettagli l'Adalgisa non li riferì), che il
Giovanni s'era messo a far la tigre reale, dietro un cartellone di «Terreno da
vendere», e avrebbe dovuto inseguire e tentar di azzannare il fratello Luigi,
ove la carabina di quest'ultimo (una Wetterly di grande qualità) non fosse stata
abbastanza pronta, ed eventualmente sbranarlo. Per procurarsi con opportuna
mimesi la sensazione delle quattro zampe, che fanno così temibile l'andatura del
vellutato felino, il Giovanni s'era messo davvero a gattoni e procedeva già,
dimenando adeguatamente il treno posteriore della persona, sprovvisto, ahimè!,
di coda, da una decina di metri; tutto peso sulle ginocchia e sulle palme delle
due mani, con le dita aperte tra i fili dell'erbetta a significar l'unghie, e la
faccia ed il naso levati, in un ruggito paurosissimo, quasi temesse e
preannunciasse la sorpresa del cacciatore. Quando tutt'a un tratto le cinque
dita di destra gli andarono a finire dentro una delle più insidiose sorprese di
quel «terreno da vendere».
Alle nari, esterrefatte, della giovanissima tigre reale, l'insidia della
giungla si rivelò subito in tutto il suo orrore, non meno che al tatto, il quale
però, per suo conto, propendeva ancora sperare si trattasse di marmellata di
susine.
|