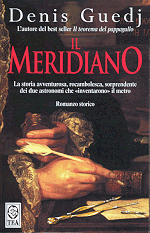
|
|
|
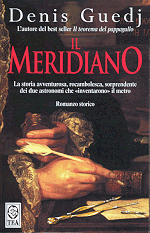
|
|
|
| << | < | > | >> |Pagina 7Una frase Tutto è cominciato con una frase: «Al fine di determinare la lunghezza del metro campione, fra il 1792 e il 1799 gli astronomi Pierre Méchain e Jean-Baptiste Delambre, attraversando la Francia da un capo all'altro, hanno misurato la Méridíenne». Mi misi a tremare per l'eccitazione. Estate 1792: non era la fine della monarchia? Autunno 1799: non era l'inizio del Consolato? Brumaio, eccetera... Fra queste due date... la Repubblica! Così, per offrire al mondo una nuova unità di misura, due astronomi avevano misurato il territorio francese in tutta la sua lunghezza per tutto il tempo della Repubblica. Una misura del territorio che era stata una misura della Storia. Chi ricorda che, nel testo della legge che ne decretava ufficialmente la nascita, il metro fu denominato «misura repubblicana»? Storia e geografia unite per dare, insieme, una misura al mondo! Questa frase, estratta da un trattato di metrologia, la stavo leggendo addossato alla porta di uno scompartimento della metropolitana fra Monceau e Barbès nel momento in cui, emergendo dai sotterranei di Parigi, il treno tornava all'aperto. In un attimo, la metropolitana era diventata aerea. Appena a casa, mi precipitai: dizionari ed enciclopedie mi lasciarono inappagato. Il giorno dopo partivo, per un viaggio nelle biblioteche di Parigi. | << | < | > | >> |Pagina 2124 GIUGNO 1792. Le Tuileries mostravano ancora le tracce della marea umana da cui erano state sommerse poco prima: carta straccia, sterco, brandelli di tessuto, aiuole di fiori calpestati... Un gruppo di giardinieri valutava i danni, ignorando volutamente l'alberello che, tre giorni prima, era stato piantato da un grandioso corteo popolare nonostante l'opposizione delle guardie del re. Un bell'albero, che durerà almeno sino alla fine del secolo, se nulla - fulmine, scure, fuoco o parassiti - ne interromperà la crescita. Appuntata sul tronco, sbocciava una coccarda tricolore. In fondo al viale, davanti a un padiglione, due carrozze dal carico pesante, parcheggiate posteriore contro posteriore, erano in procinto di partire. Identiche tranne che nel colore, una verde, l'altra ramata, erano munite sul retro di un grosso baule dalla forma strana. Intorno a esse era riunito un piccolo gruppo: Lavoisier, chimico di fama, Condorcet, filosofo e deputato all'Assemblea legislativa, e il Cavalier de la Borda, fisico. C'erano anche una donna e i suoi tre figli. Tutto il gruppetto prendeva commiato dai cittadini Pierre Méchain e Jean-Baptiste Delambre, che si accingevano a lasciare la capitale. «Allora, Méchain, a voi il Sud, a me il Nord», gridò il secondo. «Così ha deciso l'Assemblea», rispose il primo. «Quanto a me, resto a Parigi», concluse triste Lavoisier, porgendo a ognuno dei due una piccola cassetta con lettere di credito e monete d'oro e d'argento. Poi fu la volta di Borda, che consegnò ai viaggiatori una custodia contenente i lasciapassare e le lettere di raccomandazione firmate dal re. Thérèse Méchain si sforzava di nascondere la sua inquietudine. Rimaneva in disparte, dignitosa nel suo silenzio. Tuttavia, allorché Delambre le si avvicinò per salutarla, si lasciò sfuggire: «Se almeno voi partiste insieme con lui!» Condorcet le si fece accanto per confortarla: le assicurò che sarebbe rimasto sempre in contatto con i due viaggiatori e l'avrebbe tenuta costantemente informata. Méchain montò sulla carrozza ramata, Delambre su quella verde; i loro sguardi si incrociarono, avevano gli occhi che brillavano. Era l'eccitazione della partenza, o il riflesso dei fuochi di San Giovanni che la notte prima avevano illuminato le alture di Montmartre? Si fecero un cenno con la mano. «A Rodez! A Rodez!» esclamarono all'unisono.
Le due carrozze si avviarono nello stesso istante,
allontanandosi in direzioni opposte.
Per Lavoisier, quel giorno era un anniversario. Esattamente nove anni prima, aveva preso posto come di consueto nel suo laboratorio all'Arsenale. Quella mattina, in una campana a chiusura ermetica, combinando aria infiammabile e aria vitale in proporzioni predetermínate, aveva creato... l'acqua! Appena poche gocce, ma di una purezza assoluta, che avevano imperlato la superficie di vetro in tutta la sua lunghezza. L'acqua delle origini! I gas che davano vita all'acqua! Dunque, uno dei quattro elementi su cui i grandi miti degli uomini fondavano il mondo non era altro che una sostanza composta. Ormai non c'era più da credere negli elementi primari, corpi aristocratici collocati al di sopra degli altri. Era una rivoluzione! Allontanandosi dal palazzo delle Tuileries, Lavoisier, ricordandosi di essere uno dei padri di quella Repubblica delle cose, in cui tutti gli elementi godevano degli stessi diritti, non poté fare a meno di temere che nascesse anche quella degli uomini. Al suo fianco camminava Condorcet, animato da un desiderio opposto. Lui, il filosofo, l'ultimo sopravvissuto degli Enciclopedisti, il presidente della Legislativa, si augurava che venisse il tempo della Repubblica, perché, diceva, l'assenza di un re vale più della sua presenza. Quanto a Borda, benché legato alla monarchia, si era battuto al fianco dei «ribelli» americaní per aiutarli a liberarsi della Corona inglese... I tre uomini non erano riuniti nel cortile delle Tuileries per discutere del governo dei popoli, ma in quanto responsabili di una missione votata dall'Assemblea e approvata dal re. Quale motivo aveva dunque Thérèse per essere tanto preoccupata? Non era la prima volta che suo marito partiva in missione. Ma in tre anni ne erano successe di cose importanti! Proprio lì, alle Tuileries, l'ospite e la sua dimora avevano cambiato nome. Il Pavillon de Marsan, a nord, era diventato Liberté; quello al centro, Unité, mentre Flora, a sud, adesso si chiamava Egalité. E sui tre edifici svettava giorno e notte un'alta fiamma tricolore. Quanto al re di Francia, ormai si chiamava «re dei francesi», e i francesi da parte loro si chiamavano «cittadini», mentre il corpo di guardia aveva preso il nome di «Gendarmeria nazionale». A due passi da lì, una settimana prima, era stato acceso un grande falò in cui avevano gettato le «onorificenze della nobiltà»: un'enorme quantità di brevetti, diplomi di duchi, marchesi, visconti, visdomini, era andata in fiamme ai piedi della statua di Luigi XVI, a lungo lambita dalle fiamme. Erano state fissate le imposte dirette, e in tutta la Francia non si poteva più disporre di schiavi. Mentre la Sorbona erà stata chiusa, la Corsica si apriva al continente; il ponte di Avignone era diventato francese; si mettevano al bando i dialetti e i gerghi che, si diceva, impedivano ai cittadini di capirsi. | << | < | > | >> |Pagina 28«La più lunga misurazione geodetica di tutti i tempi, come l'ha definita Borda, comincia male», borbottò Méchain risalendo in carrozza. Navigatore, fisico e inventore di strumenti, Borda ne aveva appena messo a punto uno meraviglioso, un ripetitore, di cui due dei tre esemplari realizzati erano nelle casse di Méchaín.Quanto tempo sarebbe durata la spedizione? I più ottimisti parlavano di un anno, Méchain riteneva che ne sarebbero stati necessari almeno due. In realtà non lo sapeva nessuno, né quelli che l'avevano proposta in Assemblea, né quelli che all'Accademia ne avevano gettate le fondamenta, non più di quanto ne sapessero i componenti della Commissione pesi e misure che ne avevano resa possibile la preparazione. Nelle tribune della Costituente, e poi in quelle della Legislativa, Méchain aveva ascoltato i discorsi di Talleyrand, di Condorcet, di Prieur de la Cóte-d'Or. Ricordò l'emozione che l'aveva colto allorché, davanti all'Assemblea piena da scoppiare, Condorcet aveva detto che la spedizione era «per tutti i tempi, per tutti gli uomini». Ah, quell'uomo aveva il dono degli slogan, ma, dio, che pessimo oratore! Méchain ricordava quasi una per una le sue parole: «Questa operazione», aveva tenuto a precisare, «finalizzata all'accrescimento dei Lumi e alla fraternità dei popoli, dovrà occuparsi non tanto di cercare ciò che possa essere facile, quanto ciò che si avvicini al culmine della perfezione».
Ma di quale operazione si trattava? Nientemeno che di
misurare, con la massima precisione possibile, la lunghezza
del meridiano fra Dunkerque e Barcellona! Era per eseguire
questo compito eccezionale che Méchaín e Delambre, entrambi
astronomi e accademici, erano stati scelti. Ciascuno dei
due sarebbe partito da un'estremità e avrebbe raggiunto
Rodez.
Unità di lingua, di governo, unità contro i nemici esterni e interni: dopo tre anni, c'era l'ossessíone dell'unità, si aborriva l'arbitrarietà, ci si sentiva universali. La misura è quantità - è la sua stessa ragion d'essere -, ma, nel desiderio che sia al tempo stesso «qualità», la si è voluta universale, eterna, invariabile. Quel che è isolato, che non è unito a niente, l'arbitrario, affermavano, non è fatto per essere durevolmente adottato. A dimostrazione di ciò adducevano la lunga storia dei popoli. Nel predisporre la scelta della nuova unità di misura, avevano deciso di non prendere in considerazione nulla che non fosse intimamente connesso a oggetti invariabili, niente che, col passare del tempo, dipendesse dagli uomini o dagli avvenimenti. Un simile sistema non era esclusivo di una nazione in particolare, si poteva accarezzare il sogno di vederlo adottato da tutte. Chi altri, se non la Natura, possiede queste qualità? E nella Natura, che cos'altro più dello stesso globo terrestre può farsi garante di invariabilità, universalità, eternità? Tutto era pronto: l'epoca, gli uomini, le istituzioni e i mezzi tecnici. Ecco allora arrivato il momento solenne della definizione. Si proclamò che la nuova unità di lunghezza sarebbe stata una piccolissima parte del globo: «la quarantamilionesima parte di un meridiano terrestre»! | << | < | > | >> |Pagina 37Condorcet impiegò un po' di tempo ad accorgersi della presenza di Delambre. Non si facevano tante cerimonie e gli invitati non venivano presentati al loro arrivo. Il filosofo chiese il silenzio per presentare l'astronomo ai suoi ospiti. Subito Delambre fu oggetto di numerose domande: perché scegliere un meridiano? Perché quello e non un altro? Perché Dunkerque e perché Barcellona? Una fanciulla giovanissima chiese: perché la quarantamilionesima parte e non, che so, la tremilaquattrocentododicesima, per esempio?Delambre fece un gesto come per arginare la ressa. Cercando disperatamente Borda, lo scorse in disparte, visibilmente divertito dalla situazione. Supplicando il suo aiuto con lo sguardo, vide il compagno dirigersi con ostentazione verso il buffet, sorridendo malizioso. Fu (dunque senza l'assistenza di Borda che Delambre rispose a tutte le domande. Spiegò di aver scelto quel meridiano perché era quello che passava per Parigi, e in quanto tale era già stato oggetto di molte misurazioni. L'ultima in ordine di tempo, che risaliva a circa mezzo secolo prima, era stata effettuata da Cassini de Thury. «Noi contiamo di ispirarci molto al suo lavoro e di utilizzarne i risultati», precisò Delambre, «anche se, per esempio, un mulino del villaggio di Jonquiéres, di cui lui si era servito come segnale, è inutilizzabile per le nostre misurazioni. Quanto a Dunkerque e Barcellona, sono state scelte perché, essendo attigue al meridiano, ed entrambe a livello del mare, agevoleranno le operazioni di calcolo.» Sophie venne a portargli un bicchiere di vin cotto; Delambre si alzò, sperando di poterlo gustare in santa pace. Ma qualcuno gli ricordò la domanda sulla quarantamilionesima parte. «Il mondo antico adorava i giochi al punto che dalle parti di Assuan, sul Nilo, l'unità di misura si chiamava 'stadio'. Eratostene misurò la distanza fra Assuan e Alessandria e su tale base dedusse la lunghezza della circonferenza della Terra: 250.000 stadi, che equivalgono a circa quaranta milioni di mezze tese del Perù», terminò Delambre prima di vuotare il bicchiere d'un sol fiato. «Vi augurate che la nuova unità di misura diventi universale e poi la determinate senza la collaborazione di altri Paesi: ecco una contraddizione!» fece notare qualcuno. Intervenne Condorcet: «La Francia ha fatto di tutto perché altre nazioni si unissero a lei. L'Assemblea costituente ha emanato un decreto in cui 'si supplicava il re di scrivere a Sua Maestà britannica' affinché scienziati della Royal Society di Londra accompagnassero i loro colleghi francesi. Luigi XVI ha scritto, ma gli inglesi hanno mostrato diffidenza. In seguito alla presa della Bastiglia, Londra, Berlino, Vienna, Mosca, trattano Parigi come un'appestata. Ma l'Europa non può impedire alla Francia di realizzare i propri sogni. E dal momento che i governi non sono i popoli, abbiamo deciso di fare a meno di loro». Il filosofo prese a citare a memoria il decreto dell'Assemblea: «Abbiamo ritenuto che non fosse necessario attendere la partecipazione delle altre nazioni, né per decidere sulla scelta dell'unità di misura, né per cominciare le operazioni. Infatti, abbiamo escluso da questa scelta ogni determinazione arbitraria, ammettendo soltanto quegli elementi che appartengono allo stesso modo a tutte le nazioni. Dunque non appaiono motivi che diano adito al rimprovero di aver voluto ostentare una sorta di preminenza. In una parola, se la memoria di questi lavori dovesse cancellarsi, se ne restassero soltanto i risultati, essi non ci offrirebbero niente che possa servire a far conoscere quale nazione ne ha concepito l'idea e ne ha realizzato l'esecuzione». Anacharsis Clootz, che aveva cancellato le frontiere fin nel suo intimo, al colmo della felicità, abbracciò Condorcet. Delambre uscì sul balcone: sotto scorreva la Senna. D'un tratto al suo fianco comparve Borda: «Ho trovato!» L'astronomo lo guardò sorpreso. «Metro, lo chiameremo metro.» E disparve altrettanto bruscamente. Avevano entrambi una passione per la lingua greca, ma una cosa li separava: Borda preferiva l' Iliade, Delambre l' Odissea. Le luci delle Tuileries danzavano sulle placide acque della Senna. Il giorno dopo, l'astronomo avrebbe lasciato Parígi per Dammartin-en-GoŽle. | << | < | > | >> |Pagina 102Quel giorno la visuale era straordinariamente netta. La presenza, alta nel cielo, di una cappa di nubi intorno alla capitale teneva lontano il minimo vapore. Come se tutto quel che poteva nuocere alla limpidezza dell'atmosfera - il sole e le sue brume, l'umidità evanescente - fosse stato allontanato e saldamente mantenuta al di fuori di quella cintura. Non era buio; l'aria era chietra, ma non luminosa, e il grigio regnava incontrastato: ardesia di tetti, selciati di vicoli, pietre di muraglie. Non c'era nulla che appesantisse i contorni; tutto concorreva al rigore dei rilievi, alla precisione delle fotme, alla definizione dei dettagli. Delambre rimpianse di non aver preso i suoi strumenti. Erano condizioni ideali per l'osservazione.Innanzitutto c'era, a una gomena di distanza, pesante come una montagna e affilata come un picco, la mole di Notre-Dame che si tuffava nel fiume. Quella mattina non si vedeva particolare movimento sulle grandi anse della Senna. Non più di tre o quattro chiatte nel porto della Rapée. Non lontano dalla riva, un vuoto impressionante imponeva allo sguardo di fermarsi: il cantiere della Bastiglia. A furia di essere smozzicata, tagliata, rosicchiata, della struttura muraria non restava che qualche sporgenza qua e là. Si sentiva che era un vuoto attivo, che aspirava con tutte le sue forze il formicaio di Saint-Antoine, lasciando comparire la materia vivente e inquietante del temibile faubourg, pronta a colmare quell'oscena ferita nel corpo denso della città. Voltandosi, Delambre addentrò lo sguardo in Saint-Marcel, scrutando a lungo fra i vicoli: Saint-Marcel e i suoi conciatori, Saint-Paul e i suoi muratori, i cenciaioli del Roule, i fabbri di Chaillot. Che osservatorio! Ma non il minimo corteo: quella mattina, Parigi dormiva della grossa. Una decina di postazioni come quella, ed ecco la città completamente quadrettata. Non un solo movimento della plebe parigina sarebbe sfuggito a sguardi polizieschi. Nessuno ancora aveva utilizzato luoghi simili per fini di quel genere. Delambre si rallegrò che astronomi e gendarmi non operassero in garitte gemelle, gli uni per spiare gli astri, gli altri gli uomini... | << | < | > | >> |Pagina 136Qualche giorno più tardi, fra Englemont e Mailly, Delambre ricevette una lettera di Lavoisier che gli annunciava che tutte le accademie erano state soppresse. L'astronomo se l'aspettava. Come avrebbe potuto sopravvivere un'istituzione del genere, mentre intorno ogni cosa cambiava?Già nei primi giorni della Rivoluzione, Mirabeau aveva dubitato della fiducia degli accademici nelle nuove idee: «Sarà anche vero», diceva, «che in simili momenti di crisi le Accademie mostrano tanto patriottismo, ma non si dovrebbe fare troppo affidamento sulla durata di questa lieta disposizione, e forse un giorno si vedranno, nell'Accademia stessa, filosofi pentiti scrivere o parlare in maniera irriguardosa contro la Rivoluzione!» Marat aveva ancor meno dubbi. «Per il bene delle scienze e delle lettere, è importante che in Francia non ci siano più corpi accademici, ma è indispensabile che si incoraggino coloro che coltivano le lettere e le scienze.» Quanto all'abbé Grégoire, membro del Comitato di istruzione, non usava certo i guanti di velluto: egli affermava che si dovevano rovesciare le poltrone di quell'istituzione parassita! Delambre, che era stato eletto nel febbraio '92, e su cui nessuno aveva niente da ridire, non poté impedirsi di pensare al titolo che avrebbe portato da quel momento in poi: l'ultimo accademico. A stretto giro di posta, rispose a Lavoisier che gli sembrava impossibile che la Convenzione volesse distruggere per sempre un'istituzione che aveva fatto tanto onore alla Francia. «Sicuramente», precisò, «si sarà inteso soltanto rinnovarla, e forse la scienza e gli scienziati avranno da rallegrarsi dei cambiamenti che ci si propone di fare. In ogni caso, questo evento, lungi dal frenare il mio zelo, non farà che dargli più slancio.»
Nel chiudere la lettera, Delambre rivide per un momento
la faccia del sanculotto di Lagny che gli gridava:
«Cademie, cademie, non ci sono più cademie!»
Come aveva scritto Delambre a Lavoisier, la soppressione delle accademie non aveva avuto lo scopo di mettere da parte scienziati giudicati sovversivi per il nuovo ordine, non più di quanto non avesse avuto come effetto quello di ostacolare il processo del pensiero. Al contrario, c'era una bulimia di sapere, fosse quello coperto dalla patina del tempo, o quello delle conoscenze di nuova acquisizione, come il telegrafo dei fratelli Chappe, i palloni dei fratelli Montgolfier, la chimica di Lavoisier, e così via. Rousseau, Voltaire, l'abate Condillac e Hobbes, la Grecia e Roma antica, i primi pensatori della democrazia... E non si trattava di pura forma letteraria, o di una semplice figura di stile! Mai, per creare il nuovo, ci si era altrettanto nutriti del senno degli uomini del passato. E se si rivendicava il primato del «realizzare», con la stessa fierezza si asseriva la propria filiazione nel lungo solco della storia. Ci si dichiarava fondatori, ma c'erano dei padri. Agli occhi di coloro che avevano la responsabilità della Francia, il sapere era cosa preziosa. Per convincersene, bastava tenere il conto delle innumerevoli riunioni tenute da assemblee su assemblee allo scopo di elaborare un nuovo sistema di insegnamento. Si amava la ragione, la sua era la voce del progresso. Le scienze, in particolare, non erano affatto sospette. Non si dimentichi che fra i componenti della Convenzione c'erano: Fourcroy, chimico; Monge, studioso di geometria; Romme, matematico. Per non parlare dei non accademici, come quel deputato del Monte Bianco, Marcoz, professore di Matematica a Chambéry. Alcuni, che conoscevano le carenze del Paese in materia tecnica, chiedevano agli scienziati di lavorare per la Repubblica. | << | < | > | >> |Pagina 305Aprivano la fila Van Swinden e Aeneae, i due batavi, poi venivano Balbo il sardo, Bugge il danese, i due spagnoli Ciscar e Pédrayes, il toscano Fabbroni, il romano Franchini, il cisalpino Mascheroní, il ligure Multédo, e infine lo svizzero Tralles. Poi i francesi: Laplace, Legendre, Lagrance e Lefevre-Gineau, e tutti gli altri commissari dell'Institut. Monge e Berthollet, sempre accanto a Bonaparte, erano in Egitto. Bellet e Tranchot venivano dietro. Borda non c'era: la morte l'aveva colto proprio prima della consacrazione di questa spedizione che gli doveva tutto. Dei tre uomini che il 25 giugno 1792 avevano assistito alla partenza delle due berline nel cortile delle Tuileries, nessuno era arrivato alla fine del viaggio. Né Condorcet, né Lavoisier, né Borda.La sala dell'Assemblea era sontuosamente decorata, il Corpo legislativo era al completo, le tribune gremite: la folla delle grandi occasioni. Il decreto di Pratile che impediva alle donne non accompagnate di entrare nella sala era stato mitigato per la circostanza. Thérèse e sua figlia erano con Augustin, diventato quasi un cittadino in età di voto. Le vedove Lavoisier e Condorcet, risposate, erano venute con i loro mariti. Quella ragazza con i capelli ricci era Eliza. La signora Vernet stringeva il braccio di Sarret. La signora Leblanc-Pommard era venuta con suo figlio. C'era anche Etienne l'agrimensore: lo si poteva vedere fare grandi gesti per spiegare al suo vicino l'uso del circolo ripetitore. Il corteo aveva raggiunto la sbarra, i commissari si allinearono su due file. La voce nitida di un usciere annunciò: «I cittadini Delambre e Méchain dell'Institut!» I due astronomi entrarono, commossi, eppure goffi, abbagliati. Si poteva esserlo, tanto il rosso dominava fra i circa settecento abiti nuovi dei deputati. Méchain indossava l'abito tagliato dal sarto di Saint-Germain. Un po' in disparte, Talleyrand covava la scena con sguardo soddisfatto. La musica attaccò, un basso massiccio fece risuonare i muri della sua voce potente, i deputati si levarono in piedi. Gli squilli di tromba accentuarono il carattere sacro del momento. I presenti erano talmente affascinati dai musicisti che nessuno aveva visto entrare due uomini. Ma presto tutti gli sguardi si fissarono su di loro. Sulle braccia tese, il primo reggeva un cuscino di velluto porpora, il secondo un altro cuscino di pizzo malva. Su di uno brillava, sfavillante Graal dei tempi moderni, una barra di platino; sull'altro si stagliava, fuso nello stesso metallo, un cilindro spesso e luminoso. Incedendo con passo solenne sul folto tappeto che li conduceva a un podio drappeggiato di bandiere tricolori, i due officianti salirono i gradini. Poi, insieme, si girarono verso la sala e rimasero immobili. Il silenzio era totale. Lentamente, molto lentamente, il primo dei due sollevò il cuscino, e, con un lungo movimento circolare che assecondava la forma dell'emicido, espose alla folla la barra di metallo. «Cittadini rappresentanti del popolo, ecco il vero metro, il metro campione!» annunciò il presidente del Corpo legislativo. Seguì un'ovazione. I colli si tesero, ci si urtava, drizzandosi sulla punta dei piedi. In prima fila, Delambre riconobbe il deputato Descombérousse che applaudiva vigorosamente. Si fece di nuovo silenzio. E, come in un balletto perfettamente regolato, il secondo uomo alzò il cuscino coperto di pizzo malva ed espose il cilindro. «Cittadini rappresentanti del popolo, ecco il chilogrammo della natura, il chilogrammo campione!» Lassù in alto, al limite delle tribune, due vecchi, Alfred e Alexandre, i due fìlologi, che avevano difeso a caro prezzo i loro posti, continuavano la loro interminabile polemica. «Gutturale o no, chi logrammo, con 'chi', è un'infamia linguistica!» argomentava Alfred. «Smettetela di ki occiare, caro Alfred, finirete col farmi ki udere le budella!» Si sentì un grido, immediatamente coperto da una cascata di «Sstt!» Alla sbarra, qualcuna annunciava: «Cittadini, sono in grado di comunicarvi che la lunghezza del metro è di 3 piedi, 11 linee, 296/1000 della tesa del Perù!» Sentendo proclamare ufficialmente il valore esatto del metro, Delambre non poté impedirsi di dire: «Cinque anni per guadagnare soltanto 145/1000 di linea sul metro provvisorio! Un'inezia!» Fra le tribune, un ragazzo allargò le mani di suo nonno, cieco, per indicargli la lunghezza della barra. Accanto a Etienne, un brontolone corpulento, poco favorevole alle nuove misure, strepitò: «Parlano solo del metro! E il chilo, quanto pesa? Mica ce lo dicono!» L'agrimensore si sporse si sporse e gli sussurrò all'orecchio, come in segreto: «Pesa 2 libbre, 5 grossi, 35 grani». L'altro lo guardò sbalordito. Etíenne si sporse di nuovo: «O, se preferite, 18.827 grani antichi pesi di marco». La cerimonia proseguiva. Un deputato avanzò verso la sbarra, con in mano un foglio: «Eccola, infine, questa unità di misura fondata sul più grande e più invariabile dei corpi che l'uomo possa misurare: il globo terrestre!» Poi, richiudendo il foglio, lasciò che un sorriso gli si disegnasse sul viso, e in tono confidenziale concluse: «Che piacere sarà d'ora in poi per un padre di famiglia poter dire a se stesso: il campo che dà da mangiare ai miei figli è una precisa proporzione del globo. Entro tale proporzione, io sono comproprietario del mondo!»
L'ultima frase risuonò nella sala silenziosa. Questa
volta la cerimonia era finita davvero. Le nuove misure,
lanciate dagli uomini dell'89 in nome dell'Universalità,
dell'Unità e dell'Eternità, venivano messe al servizio della
Proprietà.
Già dieci anni! Ed erano stati necessari due secoli per
passare da «signore e padrone della natura» a
«comproprietario del Mondo...»
|