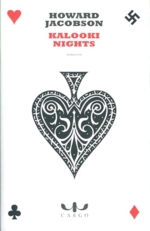
|
|
|
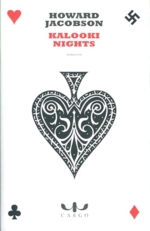
|
|
|
| << | < | > | >> |Pagina 11
L'Albatro al collo in luogo della croce
M'appesero i compagni.
Coleridge, La ballata del vecchio marinaio
In un periodo in cui nessuno comprava le mie vignette, mi misi a scopiazzare le illustrazioni di Tom of Finland per un editore pirata di erotismo gay privo di scrupoli. Sadici e succhiacazzi senza collo, dai deltoidi ipertrofici e chiappe sode e tornite come pesche, con berretti di pelle ed espressioni curiosamente benevole, intenti a giochetti lascivi in un sodomitico asilo che non c'è, liberi da bisogni e divieti di mogli e madri. Per essere un etero, che di Tom of Finland poteva apprezzare al massimo il tratto pulito del disegno e l'assenza di fantasie o smancerie eccessive, a parte sodomia e fellatio a volontà, devo dire che non me la cavai male nel copiare le sue creazioni. Mi avrebbe fatto anche bene, pensavo, vivere per un po' in quel semi-Eden sconosciuto. Alleviava almeno in parte lo stress cui ero sottoposto. Uno stress dovuto a un matrimonio in crisi e a una carriera mancata — le solite cose, insomma — ma anche al fatto di appartenere a una minoranza etno-religiosa, o comunque la si voglia chiamare, che per sua stessa natura non arriva a concepire nessuna forma di divertimento irresponsabile. Per gli ebrei non esiste un paradiso da riconquistare. Per la mia gente, una volta fuori sei fuori. I cancelli ti si chiudono alle spalle, i cherubini sguainano le loro spade fiammeggianti, e fine della storia. Ecco cosa significa il Vecchio Testamento. Sei sempre consapevole di aver perso la tua occasione di divertimento. Adesso avevo finalmente la possibilità di spassarmela un po', anche se per procura. Eccomi qua, di nuovo nel Giardino. Se ho fatto cilecca in qualcosa, è stato nel raffigurare l'evidente rigonfiamento che tutti i personaggi di Tom of Finland avevano tra le gambe. Tanto per cominciare, non mi ero neppure accorto che in quel posto ci fosse un rigonfiamento. Ma anche quando me lo fecero notare, non riuscivo a copiarlo in maniera convincente. Non riuscivo a catturare la tensione che precede l'atto, a rendere la pressione esplosiva tra glande e jeans. Alla fine dovetti ammettere che non ne ero capace perché non avevo mai portato jeans o pantaloni di pelle, e non capivo la fisica di quella spinta proveniente dall'interno. Gli ebrei indossano pantaloni larghi e comodi con doppia piega. E forse, se fa freddo, un cardigan sopra. Gli ebrei considerano inopportuno mostrare a un estraneo, che sia dell'uno o dell'altro sesso, il contorno del proprio glande. Non che al riguardo ci siano comandamenti, che io sappia. Semplicemente non si fa. Ed è per questo, come diceva sempre mio zio a proposito di qualsiasi cosa avesse a che fare con gli ebrei, che i nazisti hanno cercato di sterminarci. La replica di mio padre, se per caso si trovava nei paraggi, mi ricordava il gesto di chi schiaccia una mosca: «Da quando in qua i nazisti hanno cercato di sterminare te, Ike? Te personalmente? Se avessi pensato che i nazisti ti cercavano, gli avrei detto dove trovarti anni fa». Al che mio zio, il quale stando ai miei ricordi viveva con noi da sempre, si faceva bianco in volto, accusava mio padre di non essere meglio dello stesso Hitler, e filava a nascondersi in camera sua. Possibile che scherzassero? Che continuassero a ripetere quella scenetta perché la trovavano spassosa? Quando sei piccolo, è difficile decidere se persone grandi il doppio di te dicono sul serio oppure no. A volte tutto quello che fanno sembra un unico grande scherzo. Ma il nome di Hitler non suonava affatto divertente. E "sterminare", come venni a sapere da un piccolo dizionario che mia madre teneva chiuso in vetrina, neanche fosse prezioso quanto le sue porcellane o i trofei di boxe di mio padre, significava distruggere completamente, porre fine a (persone o animali), mandare via, mettere in fuga, eliminare (specie, razze, popolazioni, opinioni). Dal che dedussi che no, mio padre e mio zio non scherzavano: quelle discussioni dovevano essere per loro una specie di esorcismo, un modo per scongiurare il male ed evitare che venissimo mandati via, eliminati, messi in fuga eccetera eccetera. Così sono cresciuto a Crumpsall Park negli anni Cinquanta, tra i ghetti e il verde di North Manchester, con la parola "sterminio" nel vocabolario e i nazisti in salotto. Perciò, quando Manny Washinsky, in cambio di qualche fumetto, mi diede la sua copia de Il flagello della svastica, la breve storia dei crimini di guerra nazisti scritta da Lord Russell di Liverpool, ero già pronto a recepirne il contenuto, anche se allora avevo poco più di undici anni. «L'uccisione da parte dei tedeschi di oltre cinque milioni di ebrei europei» spiegava Lord Russell di Liverpool «costituisce il più grande crimine nella storia del mondo». Una conclusione che mi elettrizzava, non perché fosse proprio una novità, ma perché non l'avevo mai vista messa per iscritto. Oltre cinque milioni! Ecco cosa significava porre fine a qualcosa! Quelle cifre mi conferivano un destino solenne. Non è mica roba da poco essere una tra le vittime del più grande crimine nella storia del mondo. Ovviamente, secondo una qualsiasi definizione corrente della parola "vittima", io non lo ero affatto. Ero nato al sicuro, in un periodo fortunato e in una parte del mondo priva di pericoli, da genitori che mi amavano e mi proteggevano. Ero figlio della pace e del riparo. Come Manny. Solo che dai morti non c'era scampo. Perché, proprio come i peccatori trasmettono le loro colpe alle generazioni a venire, lo stesso accade per coloro che le hanno subite. «Ricordati di me» dice il fantasma del padre ad Amleto, e Amleto è fottuto.
Manny non era l'unico nella mia strada a conoscere
Il flagello della svastica.
Lo aveva letto anche Errol Tobias, un ragazzo di uno o due anni più grande di
noi. Non che fossimo
un gruppo di studio o una specie di club del libro. Poiché mi
vergognavo di essere amico di Manny quand'ero con Errol, e
di essere amico di Errol quand'ero con Manny, stavo ben attento a non farli
incontrare e, se proprio non potevo farne a
meno, evitavo ogni accenno ai nostri rapporti. Presi singolarmente, neanche
esistevano l'uno per l'altro. Manny troppo
devoto, Errol troppo profano. Erano diversi come il diavolo e
l'acqua santa, come la più alta delle vette e il più profondo
degli abissi. E non esagero. In Manny si celavano insondabili
profondità, in Errol una tale componente diabolica che
anche solo stargli vicino faceva paura. Quando, durante i nostri giochi, veniva
colto da uno dei suoi osceni accessi d'ira,
gli occhi gli ribollivano nel viso come vulcani; la sua rabbia si
poteva fiutare, come un serpente allo spiedo; e la pelle si faceva traslucida,
neanche Dio stesse cercando di guardargli
dentro. Eppure dei due, alla fine, il gesto diabolico non è
stato lui a compierlo. Sarà ingiusto, ma è così. A quanto pare,
non è necessariamente il carattere a determinare il destino di
un uomo. Possono condizionarlo anche fatti accessori, come
prestare troppo ascolto ai fantasmi dei propri padri. Ma allora tutti e tre, una
volta cresciuti, saremmo dovuti diventare
assassini, e non solo Manny Washinsky.
Comunque, per tornare agli ebrei che non mostrano agli estranei il contorno del loro glande, Errol Tobias era l'eccezione che conferma la regola (oppure era stato sostituito per sbaglio nella culla). Da ragazzino fissato con il sesso si era trasformato in un uomo fissato con il sesso. Manny e io, invece, eravamo più in carattere. Ed era proprio il nostro comune senso del pudore a darmi la certezza assoluta che i nazisti – per prendere a prestito l'espressione preferita di mio zio – avrebbero cercato di sterminarci. Come vignettista, sono incline alla caricatura e all'esagerazione, ma non in questo caso. È possibile tracciare seri nessi causali tra il rapporto degli ebrei con il proprio corpo – il riserbo, la purezza, la terribile solennità del patto della circoncisione – e la persecuzione operata dai tedeschi a loro danno. Per ragioni che reggerebbero al più approfondito degli esami, il mondo teme e odia chiunque consideri le proprie parti intime una seccatura. Credo che il problema sia tutto qui: non nel prepuzio, ma in questo senso di fastidio. Ogni volta che l'antisemitismo, da semplice prurito, si organizza in vero e proprio movimento, finisce per rifugiarsi in una ideale Sparta – una Finlandia di sodomiti dalla mascella quadrata che fanno baldoria nelle palestre o nei bagni pubblici, perfettamente a loro agio con i propri genitali e con quelli degli altri. E che cos'è questa, se non nostalgia per un'epoca in cui gli ebrei non avevano ancora imposto il dominio della probità sul corpo? Non si torna nel Giardino. E non c'è nessun ritorno alla Natura. Una volta cacciati dal paradiso, la vita – come attività della mente e non degli organi sessuali – la vita comincia sul serio.
Una simile devozione all'intelletto e alla consapevolezza
non possono perdonarcela.
Quanto a Tom of Finland, non c'è altro da aggiungere. Pensatela pure come vi pare, Max di Muswell Hill, nei suoi comodi pantaloni di flanella, sembrava abbastanza simpatico, ma non avrebbe certo fatto soldi a palate nei sex shop di Soho. Non mi sorprenderebbe sapere che sono stato il primo e l'ultimo ebreo – perlomeno inglese – impiegato nel mercato omoerotico di serie B. Ebrei, ebrei, ebrei. Perché, perché, perché, come domandava sempre mio padre, finché quella domanda non lo uccise, perché deve sempre avere tutto a che fare con gli ebrei, ebrei, ebrei? | << | < | > | >> |Pagina 26Quali che fossero le ragioni, ero un bambino triste e introverso dall'aspetto visibilmente biblico – quando mio padre non era a portata d'orecchio, Tsedraiter Ike mi chiamava Mendel, cercando di convincermi che quel nome era il corrispettivo, in ebraico biblico, di Max; e continuò a usarlo in segreto, preferendolo al "mio vecchio palomino", ogniqualvolta il mondo dell'ebraismo nel quale cercava di irretirmi assumeva tonalità più cupe – e tale rimasi, biblico e introverso, per tutto il mio stadio di crisalide. Finché un giorno, seduto in grembo a mia madre sul treno che ci riportava a casa dopo un pomeriggio trascorso su una fredda spiaggia di New Brighton assieme alla famiglia di Liverpool Ike, ossia con i miei cugini di terzo grado Lou e Joshua, dissi: «Giu, giu, giu, giu...deo, giu, giu, giu, giu...deo...».«Credo che volesse imitare il treno» ipotizzò mio padre quando mia madre più tardi lo raccontò a tutti eccitata. «Ho ragione, Maxie? Era il rumore che fa la locomotiva? Ciuf ciuf, ciuf ciuf...». «Giu-giu, giu...deo» ripetei io, serrando i denti attorno alle "g" iniziali. «Giu-giu, giu...deo, giu-giu, giu...deo...». «Allora probabilmente si trattava del fischio, eh? Tu-tuuu! Tu-tuuu!». Scossi la testa insistendo: «Giu-giu, giu...deo, giu-giu, giu...deo, giu-giu...deo, giu-giu...deo, giu-giu...deo...». Mio padre mi riservò uno sguardo gelido. Come se gli avessi appena comunicato che da grande intendevo fare il rabbino. O che il mio sogno era tornare in quella lontana Russia di cui a casa non si parlava mai. A Novoropiscisk, come la chiamava lui, un posto sperduto in mezzo al vomito e al piscio. Vicino a dove il Danubio riversava la sua merda nel Mar Nero. Patria spirituale se non reale di Tsedraiter Ike. «Tutta colpa tua» disse a mia madre. «Colpa mia?». «Kalooki di qua, kalooki di là. Il bambino non fa che sentire quest'unica parola». «Che c'entra adesso il kalooki con questo?». «Come ti aspetti che cresca in un mondo libero da tutto quel pattume degli shtetl se glielo ricordi in continuazione? Kalooki, kalooki... giorno e notte kalooki! Siamo a Crumpsall e questo è il ventesimo secolo, non il Medioevo del tuo kalooki». «Jack, kalooki non è il nome di uno shtetl». «Ah no? Beh, è quello che dici tu». Dopodiché si precipitò fuori di casa. Anni dopo controllai sull'atlante per vedere se per caso ci fosse, a uno sputo o a una pisciatina da Novoropiscisk, un posto di nome Kalooki. Non lo trovai. Ma c'era una Kalocsa in Ungheria, una Kaluga che si trovava circa centocinquanta chilometri a sud-ovest di Mosca, sulla sponda sinistra del fiume Oka, e una Kalush in Ucraina, dove gli ebrei avevano vissuto e subito le umiliazioni di sempre. Così probabilmente mio padre confondeva la parola "kalooki" con quelle tre città, che gli ricordavano il pantano del nostro infernale passato. Può darsi che sia solo frutto della mia immaginazione, ma dopo quell'episodio mi sembrò che mio padre prendesse un po' le distanze da me, come un uomo che indietreggia in preda alla paura e al raccapriccio di fronte al fantasma di qualcuno che credeva di aver ucciso, tanto tempo prima, per poi sbarazzarsi del cadavere. E non è impossibile che anche i suoi amici socialisti da quel momento si siano allontanati da me, piccolo cancro nel corpo della loro speranza di rinnovamento. Avrebbero anche potuto evitare di darsi tanta pena. Non sono diventato rabbino. Né sono tornato a Novoropiscisk. E non ho nemmeno seguito l'esempio di Tsedraiter Ike. A meno che il fatto di sentire giu-giu, giu-giu, giu-giudeo ogni volta che un treno attraversa una galleria, non equivalga a una di queste opzioni, o a tutte e tre. Di questa ipersensibilità, almeno, mi dichiaro colpevole. Sono una di quelle persone per le quali un treno non potrà mai più essere semplicemente un treno. Innanzitutto devo sapere, gentilmente, chi e che cosa il treno sta trasportando. In secondo luogo, chi ha predisposto il viaggio. Infine, qual è la destinazione finale. Giu-giu, giu-giu... Auschwitz Express. Naturalmente di Auschwitz non potevo sapere nulla all'epoca in cui, precoce profeta biblico, sedevo in grembo a mia madre ed emettevo l'orrido fischio. Ma passi riecheggiano nella memoria, e chi può dire quali passi, passati o futuri, racchiude la memoria di un bambino? Per quel che vale, credo che riusciremmo a percepire persino il passo di Adamo, se solo sapessimo in che parte della memoria cercare. Sentiremmo Abramo uscire dalla tenda per accogliere il patto. E il mio omonimo Mosè salire, alla sua veneranda età, sul Monte Nebo, in vetta al Pisgah. E gli ebrei di Belsen e Buchenwald levare alte grida implorando di essere ricordati. Ebrei, ebrei, ebrei. Quel che invece mio padre cercava di fare era cancellare quella parola, che considerava sinonimo di sofferenza. Non per dimenticare coloro che avevano viaggiato su quel treno, ma allo scopo di reinventare il futuro per loro. Una sorta di sionismo muscolare della mente, senza la necessità di fondare davvero uno stato sionista e andare, come diceva lui, «a dare di matto nel paese di qualcun altro». Anzi, senza la necessità di recarsi da nessuna parte. O almeno, adesso che era scampato alla vomitevole Novoropiscisk e si trovava al sicuro nel Nord dell'Inghilterra, da nessuna altra parte. Ma non puoi mai sapere cosa ti riservano i geni. Mio padre voleva un nuovo inizio ed ebbe me. Avrebbe anche potuto andargli peggio. Avrebbe potuto avere Manny Washinsky. Avrebbe potuto avere Manny Washinsky e finire ammazzato nel suo letto. Anche se, chissà, se fosse stato lui suo padre, forse Manny non sarebbe diventato affatto un assassino. | << | < | > | >> |Pagina 36«Perché devi sembrare sempre così ebreo?».È Zoë che parla. Zoë, che ogni volta mi sorprendeva con le spalle cariche delle sofferenze del mio popolo. Zoë, la mia seconda biondissima Übermadchen moglie gentile, nel nostro settimo, turbolento anno di matrimonio. Zoë, Chloë, Björk, Märike, Alÿs, e Kätchen, piccola Kate... che vorrà mai dire il fatto che le uniche persone con le quali riesco a entrare in intimità hanno sempre una dieresi o un umlaut nel nome? Probabilmente che sono uno stupido, sosteneva Zoë. Meno male che non ho incontrato Der Führer a un'età influenzabile. Con Zoë ero sempre impressionabile. Nel senso che recavo impressa nella carne l'impronta visibile dei tormenti che mi infliggeva. E poiché in genere calavo il capo accettando di portare quel fardello sulle spalle, non aveva alcuna ragione per smettere. Fatti crescere i baffi, tagliati quei baffi. Metti una cravatta, lascia perdere la cravatta. Cerca di essere più gentile con gli altri, abbi il coraggio di lottare per ciò in cui credi. Andiamo a vivere in campagna, perché non possiamo prendere un appartamento in città? Fatti un'amante, come osi anche solo guardare un'altra donna? Fottimi piano, fottimi forte, e infine non fottermi affatto. Ma l'argomento sul quale mi metteva più in croce erano gli ebrei. Perché in passato gli ebrei l'avevano trattata male. Un'unica volta in realtà, se si esclude il trattamento che le riservavo io, ma una sola volta può bastare. Nei pressi della casa in cui era cresciuta, su uno di quei fazzoletti di bosco spazzati dal vento che si trovano tra un cimitero e un golf club nella parte nord di Londra, abitava una famiglia di ebrei. Per "cresciuta" si intende che vi aveva abitato a partire dall'età di nove anni o giù di lì, quando inizia quella decisiva fase ormonale in cui, come Zoë stessa spiegava fantasiosamente, era sul punto di "trasformarsi da vegetale in persona". Un periodo da non confondersi con quello che trascorse assieme a me, durante il quale si trasformò, sempre nelle sue parole, "di nuovo in un vegetale". E la metafora vegetale rappresentava qualcosa di più di una semplice figura retorica. A sentir lei, gli ebrei interferivano con il naturale processo di crescita; in pratica, non erano naturali. Quando era triste, Zoë si sedeva ai piedi di un albero. E ogni volta che litigavamo si dedicava al giardinaggio. Nella terra trovava l'antitesi a me. E presumibilmente anche ai Krystal, la famiglia che ne aveva arrestato lo sviluppo. Conoscevo a memoria il dramma del loro tradimento, me l'aveva raccontato infinite volte. All'inizio, quando li conobbe, li adorava, e nella sua innocenza non faceva nessuna distinzione tra l'affetto che provava per i genitori, Leslie e Leila, e quello che nutriva per i due figli, Selwyn e Seymour. Era importante che io capissi questo punto: lei li amava tutti, e li amava senza alcuno scopo recondito. Giocava con loro, mangiava con loro, studiava con loro, con loro visse il passaggio dalla tarda infanzia all'adolescenza, finché all'improvviso, in una limpida giornata, sotto un cielo azzurro pastello, venne messa alla porta. Quando Zoë compì quindici anni – «esattamente il giorno dopo, non poteva nemmeno aspettare una settimana» – Leila Krystal la prese da parte e le disse che con la sua bellezza e il suo corpo avrebbe fatto senz'altro fortuna come puttana in qualche caffè di Berlino. Voleva che sgomberasse il campo, che si tenesse il più lontano possibile, laddove non avrebbe potuto accendere alcuna fiamma (a volte le fire-yekelte sono ben accette, altre invece no) nei cuori di Selwyn, di Seymour o di entrambi. A quindici anni, mi diceva Zoë singhiozzando nel letto, da un giorno all'altro era diventata una specie di maledizione. «Mi guardavano come se non mi avessero mai vista prima. Nel momento in cui divenni una donna, ai loro occhi non fui altro che un essere immondo. Una prostituta. Niente di più. Ecco perché» spiegava «sono innamorata di te». «Perché così hai una ragione in più per odiare gli ebrei?». «Perché mi hanno privato del mio diritto ad amarli». Mi sembrava un affare piuttosto equo. Grazie tante, Leila Krystal. Io avevo Zoë, e lei in cambio poteva amare un ebreo. Tuttavia, a quanto pare, avevo esagerato. Ora Zoë si domandava perché io dovessi sembrare così totalmente ebreo per tutto il tempo. «Perché io sono un fottuto ebreo» le ricordai. «Sempre e comunque?». «Ogni fottutissimo minuto». «Smettila di imprecare». «Smetterò di imprecare quando tu la finirai con le tue fottute domande sul perché sono sempre così fottutamente ebreo». «Perché devi rendere sempre tutto così complicato? Perché non puoi smettere di imprecare e di sembrare ebreo?». «Cosa vuoi che faccia, una fottuta plastica nasale?». Ci pensò su un attimo. Mi mostrò il suo sfacciato, impenetrabile profilo gentile, in cui ogni tratto era nettamente separato dagli altri. I miei lineamenti, checché se ne pensi, sono in buoni rapporti tra loro, intrattengono un'affabile conversazione l'uno con l'altro. Il volto di Zoë, invece, sembrava una specie di apartheid. «Buona idea» disse alla fine. «Facciamolo». «Ti piaceva il mio naso». «Mi piacevi tu». «Beh, allora perché limitarsi al naso? Perché non rifarmi tutto?». | << | < | > | >> |Pagina 78Che io fossi andato apposta a New York scegliendo di rinnegare Manny, è un'accusa che all'epoca avrei senz'altro respinto. Adesso però non ne sono più tanto sicuro. La scusa che mi ero imbastito era questa: Manny era stato mio amico in un periodo della vita al quale ben poche amicizie sopravvivono. Nessuno ricorda mai con chi collezionava francobolli o scambiava figurine da bambino. Perché io avrei dovuto ricordarmi di Manny? Io però non lo avevo dimenticato, anche se per me era un ricordo piuttosto imbarazzante. E qui, suppongo, sta la malafede. Non volevo ammettere di aver avuto per amico uno spostato. Criminale sì, potevo anche accettarlo, fanatico religioso, no. Così, di fronte allo svolgimento e all'esito del processo, mi tappai le orecchie. Scelsi di non sapere. In questo, non mi comportai diversamente dal resto della nostra comunità. Noi tutti – gli ortodossi non meno dei secolarizzati – ci rifiutavamo di riconoscere Manny come uno di noi. Perché lui esprimeva una forma di ritorno al passato, mentre noi andavamo avanti. Come il tempo. Il delitto risaliva a più di un anno prima. All'inizio aveva fatto enorme scalpore, ma adesso era solo una notizia stantia, oramai soppiantata da avvenimenti ben più interessanti. Basta. «Basta» come affermò Tsedraiter Ike «dare soddisfazione agli antisemiti. Bisogna solo rinchiudere quel meshuggener». E pareva non sussistere alcun dubbio circa l'esito del processo. Per sua stessa ammissione, Manny aveva fatto quel che aveva fatto, e sarebbe finito in prigione o in un ospedale psichiatrico. Alla polizia aveva raccontato di aver seguito l'esempio di Georg Renno, flautista di nascita austriaca e sostenitore del programma eutanasia, vicedirettore del centro di sterminio delle SS a Hartheim. All'epoca del suo tardivo arresto nel 1961, Renno, stupito che si potesse fare tanto rumore per nulla, aveva reso una dichiarazione per la quale il suo nome verrà sempre ricordato. «Aprire il rubinetto del gas» affermò «non era niente di straordinario». Era stato per verificare quell'asserzione che Manny aveva aperto il rubinetto del gas mentre i genitori dormivano. Come sostenne in seguito nella sua deposizione, Renno si sbagliava. Aprire il rubinetto del gas era qualcosa di straordinario. Proprio sulla base di simili affermazioni i suoi avvocati sostennero, e con successo, che le sue facoltà mentali dovevano essere compromesse da una condizione di anormalità. Nessuna persona normale, per quanto ossessionata dalla storia dell'Olocausto, si sarebbe spinta nelle sue ricerche fino a quel punto.Nella secolare Crumpsall avevamo la nostra interpretazione profana di cosa ci fosse di sbagliato in Manny. Non mi riferisco alle circostanze specifiche, o a quelle che, con una certa maldicenza, supponevamo fossero le circostanze specifiche che avevano condotto all'assassinio: l'infelicità che Asher aveva portato nella sua famiglia quando, tanti anni prima, si era messo con la fire-yekelte; i continui litigi, così rumorosi e violenti che avrebbero potuto resuscitare i morti; l'ignominia che sembrava aver macchiato i Washinsky per sempre, anche se Asher era svanito nel nulla e della fire-yekelte non si era più sentito parlare; il senso di vergogna che emanava dalla loro stessa casa, come se anch'essa se ne stesse a capo chino, in silenzio, rifuggendo ogni possibile interazione con il mondo; la nostra impressione che il loro animo si stesse lentamente decomponendo dall'interno, al punto che la catastrofe finale ci apparve il frutto dell'ineluttabile, il prezzo richiesto dal fato o dalla natura, una tragedia che tutti, bene o male, ci eravamo sempre aspettati. Secondo noi erano questi i presupposti o persino, se si vuole, le vere e proprie cause scatenanti del grandioso atto di Manny. E tuttavia non bastavano a spiegare cosa ci fosse di sbagliato in lui, cosa affliggesse la sua anima, ma soltanto perché ciò che vi era di sbagliato si fosse manifestato proprio in quella maniera. E quel che vi era di sbagliato in Manny era che lui era Manny. Le sue "anomalie" erano intrinseche all'osservanza religiosa. Credere nel modo in cui credevano i Washinsky era di per sé una forma di alienazione mentale. I coniugi Washinsky avevano inflitto la propria pazzia a entrambi i figli, che a loro volta l'avevano inflitta ai genitori. Uno se n'era scappato, l'altro era rimasto. Non c'era bisogno di andare a cercare altri motivi o ragioni. Il mistero non stava nel perché Manny avesse fatto quel che aveva fatto, ma nel perché tutti i ragazzi ebrei ortodossi nella sua condizione – quelli che non erano scappati – non facessero lo stesso. In tutti gli anni trascorsi a Crumpsall non ho mai incontrato un ebreo che, per quanto scettico, non credesse almeno un po', nelle occasioni, per così dire, speciali. Persino Ike il Grande, del quale correva voce si dilettasse di satanismo, divenne credente in occasione del matrimonio di sua figlia Irene: indossava lo yarmulke in casa e prese lezioni di ebraico per poter leggere la benedizione sui pasti (nella versione lunga naturalmente) durante la cerimonia. Ma quando Irene tornò dalla luna di miele a Rimini, aveva già ripreso – con sollievo di tutti – a danzare attorno a una capra a Pendle Hill. Guardavamo con indulgenza a queste infatuazioni per la fede, fintantoché erano passeggere. Era perfettamente sensato, quando si trattava di avvenimenti importanti – nascita, matrimonio, morte –, credere un po'. Ma credere molto era tutt'altra cosa, e solo un pazzo poteva farlo. Di qui la convinzione dell'intrinseca follia della religione nella quale sono stato allevato. | << | < | > | >> |Pagina 296Quel che era capitato al mio naso non era privo di una sua ironia. Quantomeno, non era privo di implicazioni ironiche per Zoë. Quando non mi assillava perché me lo accorciassi, Zoë non perdeva occasione per lamentarsi dei rumori che facevo respirando. Non potevo farci granché, le obiettavo, se non smettere del tutto di respirare.Come sempre Zoë prestò la dovuta attenzione al mio suggerimento, mentre la più dolce espressione beffarda illuminava i suoi inappuntabili e insondabili tratti. Avevo una mia teoria in proposito: quella respirazione così rumorosa, che – non avevo difficoltà ad ammetterlo – talvolta poteva risultare ben più che percepibile, era l'effetto della stessa condizione patologica che mi causava frequenti perdite di sangue dal naso, l'epistassi ereditata dal mio defunto padre. «Anche tuo padre russava come un treno espresso?» volle sapere Zoë. «Che lo facesse o no» replicai «credo che mia madre dormisse come qualsiasi persona normale, quindi non se ne accorgeva». La mia era un'allusione a quella che consideravo la anormalità delle abitudini di Zoë durante il sonno, questione che rappresentava per noi frequente argomento di discussione, dal momento che lei era convinta di dormire esattamente come si dovrebbe, vale a dire tesa come una corda di pianoforte in uno stato tra la veglia e l'incoscienza, con gli occhi spalancati e ogni millimetro di carne che fremeva al minimo fruscio, che fosse il respiro proveniente dalle mie narici o il vento che muoveva una carta di caramella a tre isolati di distanza da casa nostra. «Non ci sarebbe niente di sbagliato nel mio modo di dormire, se solo mi fosse concesso di farlo» sosteneva lei. «Vale lo stesso per me» replicavo. «Non credi che potrei dormire più sodo, e quindi più silenziosamente, se non fossi costretto a restarmene disteso nel letto, cosciente anche quando non lo sono, ad ascoltare il rumore della tua veglia?». «Sei così ebreo» rispondeva allora. «Sei così fottutamente, illogicamente, polemicamente ebreo». Il che, immagino, era solo un altro modo di illustrare la mia opinione che siamo un popolo amante della dialettica. Alla fine risolvemmo i nostri dissapori. Lei mi mandò da uno specialista di orecchio, naso e gola. Che a sua volta mi mandò da un otorinolaringoiatra. Poiché non sapevo bene cosa mi avrebbero fatto, andai all'appuntamento assieme a Kennard Chitty, il chirurgo plastico che Zoë aveva rintracciato uno o due anni prima con lo scopo di fargli armonizzare il mio volto con il suo. Allora, lo stesso Chitty si era rifiutato di accostare il bisturi al mio naso, per via delle associazioni patriarcali che gli suggeriva. Era infatti dell'avviso che quello degli ebrei fosse l'aspetto più nobile della Terra, se non fosse stato per la mancanza di quella vera convinzione che deriva solo dal Cristo. «Gesù deve aver avuto un naso come il tuo» mi disse «perciò non sarebbe cristiano intervenire su di esso chirurgicamente». In un certo senso eravamo diventati amici, e lui aveva acquistato una serie di mie tavole sull'Antico Testamento per appenderle nel suo studio medico, accanto ad altra paccottiglia, mentre io gli consentivo di invitarmi alle sue feste di Natale e di rifilarmi opuscoli grossolanamente stampati, nei quali si spiegava come solo imparando ad amare gli ebrei i cristiani sarebbero infine riusciti a salvare il mondo. Prima, però, gli ebrei dovevano acconsentire a diventare cristiani. Ma lasciando da parte questo, Chitty mi disse di non preoccuparmi dell'otorinolaringoiatra, e mi segnalò persino una cura di cui aveva letto da qualche parte, adatta a quelli che si trovavano nelle mie condizioni. Si chiamava legatura dell'arteria sfenopalatina. Quando lo riferii a Zoë, la cosa la eccitò, perché credette che dopotutto mi sarei sottoposto a un intervento chirurgico. «Mentre te lo fanno...» iniziò. Ma dovetti chiarirle che l'intervento era interno e non esterno, e che se si aspettava che sarei tornato a casa con il nasino all'insù, faceva meglio a scordarselo.
E così arriviamo all'ironia cui accennavo prima. Alla fine
l'otorinolaringoiatra mi sconsigliò la legatura, a causa di un
qualche problema con il setto nasale che non riuscii bene a
capire. Così fui sottoposto a quello che, in mancanza di un
termine più appropriato, definirei un regime a base di "sbobbe": per un
intervallo di tempo non indifferente, il mio naso
venne imbottito con ogni tipo di sostanza, cosicché il risultato finale fu che,
anziché diventare più piccolo, divenne più
grande, anche se la descrizione di Manny – che il mio naso
sembrava essersi spalmato sulla faccia – era esagerata. Comunque sanguinavo meno
spesso, e russavo anche di meno.
Tuttavia per Zoë fu un duro colpo, e da allora trovò ancor più
difficile guardarmi.
|