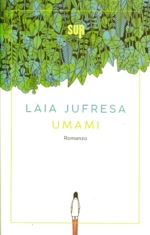
|
|
|
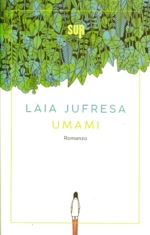
|
|
|
| << | < | > | >> |Pagina 34L'amaranto, pianta alla quale ho dedicato buona parte dei miei quarant'anni da ricercatore, ha un nome impossibile che, ora che sono vedovo, mi indigna.
Amaranthus,
il nome generico, deriva dal greco
amaranthos,
che significa: «fiore che non marcisce mai».
Sono vedovo dal 3 novembre del 2001. Proprio quella mattina mia moglie ha guardato ancora una volta l'altare che avevo improvvisato in camera nostra per il Giorno dei Morti. Era un po'precario: solo due vasi con denti di leone e garofani d'India, nient'altro, perché quell'anno non eravamo dell'umore giusto per le calaveras tradizionali. Noelia si è sistemata il turbante (non le piaceva che io la vedessi senza capelli), ha indicato il mio altare e ha detto: Pappappero. Pappappero cosa?, le ho chiesto. Ho vinto io, ha detto lei, sono arrivati senza di me e senza di me se ne sono andati.
Ma quel pomeriggio, quando le ho portato il suo caffellatte, Noelia se n'era
andata con loro. A volte credo che
quello che mi fa più male è che sia morta mentre io non c'ero. Mentre ero di
sotto, fermo come un idiota davanti ai
fornelli, ad aspettare che l'acqua bollisse. La maledetta acqua calcarea
clorificata di Città del Messico, ai suoi cazzo
di 2260 metri di altezza sul livello del mare, ci mette tutto
il tempo del mondo a far fischiare il bollitore.
Di cognome, Noelia faceva Vargas Vargas. I suoi erano originari del Michoacán, uno di Morelia e l'altra di Uruapan, e ogni volta che se ne presentava l'occasione giuravano pubblicamente di non essere cugini. Ebbero cinque figli. Mangiavano tutti insieme ogni giorno. Lui era cardiologo e aveva l'ambulatorio vicino casa. La mamma faceva la casalinga e aveva il solo vizio di giocare a canasta tre volte alla settimana. Di solito perdeva a carte buona parte dei soldi per la spesa, ma a loro non è mai mancato nulla. Eccetto dei nipoti. Almeno per quanto riguarda noi, ancora glieli dobbiamo. Per darsi una spiegazione, o quantomeno una consolazione, mia suocera mi ricordava sempre in tono apologetico che «da quando era piccola, Noelia ha sempre voluto essere figlia e basta». Stando ai suoi racconti, mentre le sue amichette giocavano a fare da mamma alle loro bambole, Noe preferiva essere la figlia delle sue amiche, o l'amica delle bambole, perfino la figlia di una bambola a volte, cosa che in generale risultava inaccettabile per le sue compagne di giochi perché quando si è mai vista, la apostrofavano con quella crudeltà acuta che sanno avere le bambine, una mamma così carina? Incredibilmente mia moglie, che attribuiva tanti dei suoi problemi alla sua condizione di figlia senza figli, non ha mai voluto toccare quell'argomento con me. Si rifiutava di discutere il fatto che era stata sua madre, alla fine, la prima a utilizzare, parlando di lei, l'espressione «figlia e basta». E non è forse possibile, mi viene in mente ora, Noelia cara, che la tua ossessione venga proprio da questo? Che non sia qualcosa che hai scelto consapevolmente, ma che te l'abbia inculcato tua madre? Non fare lo stipetto, Alfonso, risponde mia moglie che, ogni volta che ha bisogno di dare dello scemo a qualcuno, sostituisce l'insulto con un qualunque altro sostantivo che inizia con la s.
O lo sostituiva, lo sostituiva. Devo imparare a coniugare che ormai non c'è
più. Il fatto è che, quando l'ho scritto
qui, Non fare lo stipetto, Alfonso, è stato come se non l'avessi scritto io. È
stato come se l'avesse detto lei.
Forse la nuova macchina, quella nera, servirà proprio a questo. Sì, ecco perché me l'hanno portata: così Noelia ricomincerà a parlarmi. Ho un collega all'istituto che a cinquantadue anni si è sposato con una donna di ventisette. La vergogna li ha colti solo l'anno in cui lei ne ha compiuti trenta e lui cinquantacinque, perché d'improvviso il quarto di secolo che c'era tra loro era alla vista di tutti, senza bisogno di uno sforzo aritmetico. Qualcosa di simile è successo a noi del comprensorio: i numeri ci hanno lasciati stupefatti quando, lo stesso anno in cui è morta mia moglie, a cinquantacinque anni, è morta la figlia piccola della mia inquilina, che di anni ne aveva cinque. In confronto, la morte di Noelia sembrava quasi logica, solo perché l'altra appariva talmente incomprensibile, talmente ingiusta. La morte però non è mai giusta, e cinquantacinque anni non sono tanti. Questa macchina la posso usare anche per lamentarmi, se mi va, del fatto che sono rimasto prematuramente vedovo e nessuno sembra essersene minimamente accorto. Quello che mi cercava più spesso era Páez. Ma Páez pensava più alla sua angoscia che alla mia. Mi chiamava la sera tardi, ubriaco, tormentato dalla scoperta che nemmeno la sua generazione era immortale. Diceva: Non dormo se la immagino da solo in quella casa, amico. Mi prometta che non smetterà di uscire. E poi, quello stronzo sconsiderato è morto pure lui. Noelia diceva che le brutte notizie arrivano sempre tre a tre. Anche a lavoro, non glien'è fregato molto. Si prenda un anno sabbatico, mi hanno detto. Marcisca in vita. Se ne vada a fermentare di tristezza in quella sua cazzo di milpa urbana nella quale non abbiamo mai creduto. Inaridisca pure tra le sue piante di amaranto. E io, sereno, scemo: Dove devo firmare? È stata una cazzata tremenda perché ora sto diventando pazzo a stare tutto il giorno in casa. Non ho nemmeno internet. Di sicuro questa macchina nera avrà il wi-fi, ma non sono riuscito ad attivarlo. Preferisco la televisione, almeno so come si accende. In queste settimane mi sono affezionato ai programmi di metà mattina, sono fantastici. Da quando ho firmato per l'anno sabbatico non avevo più avuto nessuna notizia dall'istituto. Però due settimane fa sono venuti a lasciarmi questa macchina. Dicono che è il mio bonus da ricercatore per il 2001, sebbene quell'anno maledetto sia finito sei mesi fa e sia stato in assoluto il meno produttivo della mia carriera. A meno che «Convivenza con il cancro al pancreas di tua moglie» e, dopo, il «Duelis extremis dei primi mesi di vedovanza» non si possano considerare i miei argomenti di ricerca. Suppongo che gli avanzasse uno di questi aggeggi e me l'abbiano mandato perché avrebbero dovuto pagare per restituirlo. La burocrazia dell'istituto è sempre stata gestita in modo del tutto illogico, anche se loro si credono tanto coerenti. Per esempio, dicono che la devo usare, la macchina, per la ricerca, però me lo mandano a dire dal ragazzo delle consegne. Bisogna dirlo, però, insieme al computer il ragazzo mi ha portato anche un documento. Perché all'istituto non succede mai nulla che non venga stabilito da un documento in carta intestata firmato dal direttore. Il ragazzo delle consegne ha tirato fuori dalla sua Nissan Tsuru una scatola di cartone e me l'ha, appunto, consegnata. Ha detto: È un laptop, signore, dicono all'ufficio che deve usarlo per la sua ricerca. E io: Ma se ho preso un anno sabbatico. E lui: Be', senta, a me mi hanno detto di lasciarglielo e basta. E io: Vabbe', lasciamelo e basta, allora. Me l'ha lasciato e io l'ho lasciato lì nell'ingresso, con scatola e tutto. Questo è stato due settimane fa. Poi oggi, ho finalmente affittato la Casa Amaro. Se l'è presa una ragazzetta magrissima, che dice di essere una pittrice. Mi ha portato un assegno e, come garanzia, i documenti di un ristorante italiano a Xalapa. So che è italiano perché si chiama Pisa, secondo lei è un gioco di parole perché, oltre a riferirsi alla torre, imita la pronuncia xalapena della parola pizza. Anche se in realtà dicono pitsa, mi ha spiegato, ma quello sarebbe stato troppo di cattivo gusto. A-ha, le ho detto. Io spero solo che non si droghi, o che si droghi poco, e che mi paghi puntuale. Non mi sembra di chiedere tanto, considerando che le ho fatto un buon prezzo. Lei era d'accordo su tutto tranne il colore delle pareti che danno sul vialetto. Sto pensando di ridipingerle, le ho detto. Ma è una bugia. Il bello è che dopo aver fatto il contratto, che abbiamo firmato a La Taza de Mostaza perché è accanto alla cartoleria e dovevamo fotocopiare i suoi documenti, sono uscito e mi sentivo bene, cioè: produttivo, o quasi. Sulla via del ritorno ho comprato un paio di birre e delle patatine, e mi sono messo in veranda con le bambine. Dopo averle sistemate in modo che potessero presenziare all'evento, ho aperto questa scatola su cui ora sto appoggiando i piedi, comodissima tra l'altro, e mi sono messo a montare la macchina. Confesso che ero leggermente emozionato quando l'ho aperta. Molto leggermente, ma è comunque l'entusiasmo più grande che ho provato finora nel 2002. La macchina nera è più leggera di tutte le precedenti. La sto usando per scrivere proprio ora. Sono particolarmente orgoglioso di quanto sono stato veloce a montarla. Montarla per modo di dire. La verità è che mi è bastato attaccare la spina. Il vero lavoro è stato tirarla fuori dalla scatola e rimuovere i rivestimenti di plastica e polistirolo, nient'altro. L'ho chiamata Nina Simone. Il mio altro computer, quel vecchio elefante che avevo nel cubicolo all'istituto, e con cui ho scritto tutti gli articoli degli ultimi dieci anni, si chiama Anacleto. Sul Windows di Anacleto nell'immagine del mio utente c'è una mia foto, ma ci aveva pensato un tecnico dell'istituto a caricarla. Io non arrivo a tanto. Sul Windows di Nina Simone il mio utente ha come immagine quello che prevede l'azienda: una paperella gonfiabile. Word vuole cambiare «gonfiabile» con «affabile». Word è uno stipetto. Cazzo, a Noelia veniva in mente ogni volta una parola diversa con la s e io non riesco a trovarne più di una.
Sono un soprabito. Un sottopentola. Un sommergibile.
Da bambina, Noelia non voleva fare la dottoressa come suo padre, ma l'attrice come una prozia che aveva fatto carriera ballando nei film muti. Dopo il liceo si è iscritta a un corso intensivo di teatro. Ma la seconda settimana, quando le è toccato improvvisare di fronte ai compagni, è diventata tutta rossa, non è riuscita a dire nemmeno una parola e, a sentire lei, le è venuta la tachicardia parossistica, che è una cosa davvero tremenda: è quando il cuore ti batte più di centosessanta volte al minuto. A me sì che è successo, non come a Noe, che se l'era solo inventato. Dopo il disastroso corso di teatro, Noelia si è iscritta all'UNAM, dove dopo qualche anno da incubo – io, fino a oggi e dopo una vita passata a convivere con dottori, ancora non so come fanno a sopravvivere – è diventata cardiologa. Lei direbbe: Medico in elettrofisiologia cardiaca, dolcezza. Tutto questo, Noelia me l'ha raccontato la prima volta che abbiamo cenato insieme. Mi sembrava assurdo che parlare in pubblico la spaventasse più di farsi strada tra le viscere umane. Le ho chiesto: Perché medicina?, perché non qualcosa di più semplice? Era il 1972 ed eravamo in un ristorante della Zona Rosa quando la Zona Rosa era ancora un quartiere decente, non come adesso che, be', la verità è che non lo so perché sono anni che di lì nemmeno ci passo. Mia moglie, che quella sera era una donna che avevo appena conosciuto, mi ha risposto: Avevo quest'idea, ovviamente sbagliata, che studiando medicina avrei sempre avuto a che fare con le persone una alla volta. Poi ha bevuto in un sorso la sua tequila e ha detto: È che sono sempre stata un tantino ingenua. E in quel momento ho capito che era un po' civetta, cosa che non si notava per niente a prima vista. Ed era davvero ingenua? Certo che sì. Ma solo per alcune cose, e di un'ingenuità che, d'altra parte, non la privava della sua astuzia. Diciamo che era ingenua quando le andava. Noelia era molto pratica, anche se un po' sbadata; era sincera al cento per cento, furba, bellissima e, per quella prima sera e per le successive tre settimane, vegetariana. A Noelia piacevano le persone una alla volta. Le piaceva prendere il caffè con le persone. Le piaceva uscire a fumare di nascosto con le infermiere e scoprire qualcosa sulla vita di cani e porci, come diceva lei. Ha smesso di essere vegetariana perché adorava la carne. Perfino cruda. La tartare. Per il suo compleanno ordinava sempre kibbeh o kebab. Non sono più tornato in centro perché ho troppi ricordi di quando andavamo all'Edén per il suo compleanno. Nessuno può metterti davvero in guardia ma i morti, o almeno alcuni di loro, si portano via con sé abitudini, anni, interi quartieri. Cose che credevi condivise ma in realtà erano tutte loro. Ed è giusto, dico io. Patti chiari, lutti lunghi. Noelia non mi ha detto, quella prima sera, che suo padre era stato un pezzo grosso di Cardiologia, all'ospedale di Tlalpan, prima di aprire la clinica privata nel Michoacán dove lei, a dodici anni, aveva imparato a leggere gli holter, cioè a individuare aritmie. Né mi ha detto che già allora, quando io l'avevo invitata a cena, era una delle cinque, cinque!, maggiori specialiste in tutto il paese. Questo me l'ha detto la mattina dopo. Eravamo nudi sul divano del suo salotto e io, subito dopo, ho finito il caffè, mi sono vestito e me ne sono andato dal suo appartamento senza chiederle il numero di telefono. O, come ha diagnosticato lei con esattezza la seconda volta che ci siamo visti, quasi un anno dopo: Te la sei filata, filone. Dire che me la sono filata è un eufemismo, ovviamente. In realtà, usando un'altra delle sue espressioni: me la sono fatta sotto. Morivo di paura e ho capito il mio panico solo a posteriori, quando ho iniziato a riflettere sul tipo di donne con cui ero andato a letto nei mesi successivi, tutte giovani, beneducate, umaniste, mie ammiratrici, praticamente: mie alunne. Ero stato perfino sul punto di sposarmene una, la Memphis, come Noelia l'ha soprannominata anni dopo, quando finalmente l'ha conosciuta, credo per gli stivali che portava, o forse per il taglio di capelli, che ne so. Per fortuna, poco prima di sposarmi con la Memphis ho fatto un sogno. Il fatto è che ero un codardo, sì, un filone pure, ma più di tutto ero superstizioso: una volta capita l'antifona, sapevo che avrei dovuto dare retta all'inconscio e ho deciso di presentarmi a casa di Noelia. Quasi non mi riconobbe. Poi si è fatta un po' pregare, per tipo due settimane. Ma poi ci siamo amalgamati con una tale diligenza che ora non so, lo giuro sul mio posto nel Sistema Nazionale dei Ricercatori, su tutti i certificati secondo i quali io so affrontare certe questioni complesse, io giuro che non lo capisco. Non capisco com'è che e faccio a respirare, se mi hanno strappato via un polmone. Il sogno che ho fatto. C'era Noelia ferma sulla soglia della porta, con tanta, tanta luce alle spalle. Nient'altro. Era un sogno statico, ma cazzo se il messaggio era chiaro. Perfino un po' minaccioso. Quando mi sono svegliato, ancora insieme alla Memphis, sapevo di avere due possibilità: rimanere sulla strada più facile o prendere quella più felice. Si direbbe: un'epifania. L'unica che ho avuto nella mia vita, ovviamente. | << | < | > | >> |Pagina 119A volte vado al negozietto dietro l'angolo a comprare un paio di birre, o qualcosa che mi manca, ma la spesa grossa me la fa Beto, e gliene sono grato. E non lo dico solo per farmi bello in caso ci restassi secco qui con il computer acceso. Perché ci ho pensato dal momento della morte di Noelia: chi dei vicini darà la notizia che io sono morto stecchito? E, a chi lo comunicherà? All'istituto? E quelli dell'istituto, che faranno? Mi metteranno in una cassa con la loro sigla? Mi seppelliranno in mezzo a delle rovine come fossi patrimonio nazionale? Ne dubito. Chi mi troverà dovrà semplicemente buttarmi nella spazzatura, senza tante cerimonie. Magari avrò già un brutto odore in quel momento, io che mi sono sempre tenuto così bene. In conclusione, credo proprio che sarà Beto a sentire la prima zaffata, quando porterà la spesa. Per questo, anche se non gli ho detto il motivo, gli ho già dato un mazzo di chiavi. Quando lo sento entrare, scendo a offrirgli una birra, perché sì, perché siamo vivi, e accetta quasi sempre. Ci sediamo nella veranda che dà sulla MM morta, dove prima il rosa profondo dei fiori di amaranto salutava con il vento, ed elaboriamo sterili piani per eliminare le piante secche e montare un barbecue o una piccola piscina. Parliamo del più e del meno finché non arriva per lui l'ora di andare a prendere sua figlia alla scuola di danza o di non so cosa. Beto chiacchiera con me, mi fa domande, è generoso e si mostra interessato; ora che ci penso, Beto è uno dei pochi uomini che ho conosciuto nella vita che mi ispirano fiducia. Forse perché sua moglie se n'è andata. O forse proprio per questo sua moglie se n'è andata. In fondo, credo di essere anch'io uno di quegli uomini. Ma può darsi che sia solo il mio ego a offrirmi quest'illusione e che in realtà io sia uno di quelli che ispirano pura indifferenza. Meglio indifferenza che repulsione, ovvio, ma non è nobile come la fiducia. Non un'indifferenza qualunque, nient'affatto, ma il prodotto naturale di anni di sforzi per passare inosservato. La timidezza cronica, sommata all'immersione totale in un buon matrimonio e a una serie di abitudini solitarie, è la formula della sparizione. Ti trasformi in una specie di Casper: amichevole ma assolutamente prescindibile. Da piccolo, quando dovevo scegliere tra i poteri magici, sceglievo sempre di poter viaggiare nel tempo. Quello che volevo era vedere senza essere visto. In fondo credo che sia proprio questo a definire la mia professione. Direi che gli antropologi possiedono una predisposizione naturale per l'osservazione e una sana dose di curiosità per gli esseri umani, ma senza arrivare alla sensibilità dell'artista, all'austerità del filosofo o all'opportunismo dell'avvocato. La nostra sana curiosità è lontana dal rigore sistematico, leggermente ossessivo, della spia o dello scienziato, dall'ingegno deduttivo del sociologo, dalla disciplina dello scrittore. Però abbiamo un po' di tutte queste caratteristiche, se vogliamo vedere il bicchiere mezzo pieno.Tornando al punto, e con una nota più ottimista, posso assicurare che: a) per la strada, la gente ancora mi schiva. Non mi guarda ma ancora mi circonda, rischia di urtarmi. Vale a dire che, almeno fisicamente, sono ancora percettibile. E b) per la prima volta quest'anno, non penso che morirò presto, non ora che intuisco un progetto, nei limiti che il lutto permanente impone. Non morirò proprio ora che ho fatto squadra con Nina Simone, a.k.a. la Negretta, e che, per la prima volta in quarant'anni, mi sono azzardato a scrivere senza usare note a piè di pagina. Ecco la mia nuova vita da quando non vado all'istituto: la mattina non metto la sveglia, gli occhi mi si aprono in automatico tra le otto e le nove. Considerando le storie da incubo di altri vecchi che ho conosciuto quando ero un ragazzo, mi sembra di essere fortunato. O forse i vecchi, più che insonni, sono esagerati. Anch'io, se avessi qualche giovane sottomano, ne approfitterei per farlo sentire in colpa di quanto mi alzo presto. Poi mi faccio la doccia, mi vesto e metto su il caffè. Ho ripreso a berlo come quando ero uno studente pretenzioso e pensavo che Dio fosse nei dettagli, sempre che i dettagli fossero europei: con caffettiera italiana, sia chiaro. A Noelia piaceva il caffè della macchinetta elettrica che non aveva nessun sapore e che quindi consumavamo in quantità poco appropriate a persone mature. Poi faccio colazione con una banana, o un uovo, a seconda di quello che ho. Poi spazzolo le bambine, le cambio, e ci sediamo tutti e tre nello studio, io con Nina Simone davanti agli occhi. Poi passo la mattinata a scrivere e scrivere. Faccio una pausa verso mezzogiorno per bere qualcosa a La Taza e brindare con Linda. Poi (io, che ho cucinato per tutta la vita) mangio in uno dei tre fast food del quartiere. Cucinare solo per uno dopo aver cucinato trent'anni per due, semplicemente non è cosa. Ormai sono già tre settimane che faccio così. Scrivo molto ma cancello anche molto, perché voglio farlo per bene: se non riesco a raccontare con ordine, almeno voglio raccontare le cose importanti. Due giorni fa ho fatto, nella prima pagina del documento, una copertina. Ho scritto a caratteri cubitali, al centro della pagina: NOELIA. Poi ho messo anche i cognomi e poi ho cancellato tutto, il suo nome non comprende tutto ciò che era. Ho scritto: Umami. È un po' scemo come titolo perché ho già scritto un libro che si chiama così ed è pura teoria culinario-antropologica. Ma per ora penso di lasciarlo perché, allo stesso tempo, Umami è il titolo perfetto. Cercare di raccontare chi è stata mia moglie è necessario e impossibile quanto spiegare l'umami: quel sapore che satura le papille gustative senza, proprio per questo, lasciarsi distinguere, oscillando con soddisfazione tra il salato e il dolce, un po' così, un po' cosà. Complesso e allo stesso tempo chiaro e tondo, come era anche la Noe: familiare e imprevedibile insieme. È un titolo perfetto perché nessuno lo capirà come io non ho mai capito davvero Noelia Vargas Vargas. Forse per questo non mi sono mai stancato di lei. Forse l'amore è proprio questo. E così è la scrittura: lo sforzo di descrivere a parole una persona sapendo che per gli altri resterà comunque un caleidoscopio: i suoi mille riflessi nell'occhio di una mosca. | << | < | > | >> |Pagina 165L'umami inizia in bocca. Inizia al centro della lingua, si attiva la salivazione. Si risvegliano i molari, vogliono mordere, hanno bisogno di movimento. Non poi così diverso, a dire il vero, anche se in proporzioni più modeste, dal movimento dei fianchi durante il sesso: in quel momento, l'unica cosa da fare è obbedire al proprio corpo, e il corpo sa cosa fare. Mordere è un piacere, e l'umami è la qualità di ciò che è mordibile. Mordibile non è una parola, ma masticabile non mi piace. Masticabile si dice della vitamina C in compresse. Mordibile mi sembra più ad hoc, è un capriccio, qualcosa di peccaminoso o, come direbbe Agatha Christie: delish.Negli articoli di divulgazione, per spiegare l'umami si usa la parola rich. Mi piace, rich, ma non funziona in traduzione, perché in inglese rich non significa semplicemente buono, ma anche complesso, convincente, soddisfacente. A essere precisi, forse l'umami non inizia in bocca ma con la vista, con la voglia. | << | < | > | >> |Pagina 172Visto che quando morirò qualcuno troverà questo scritto, voglio anche chiarire che Harvard ha già smentito pubblicamente la mappa dei sapori che mi aveva mandato Kikunae. Cosa che, in realtà, si sarebbe potuta scoprire con due neuroni e una goccia di limone sulla punta della lingua, l'area che apparentemente distingue solo il dolce, ma che non è venuta in mente a nessuno di noi che abbiamo preso per certa quella mappa principalmente perché arrivava da Harvard. Insomma, alla fine erano solo fesserie. Eppure era una buona mappa; almeno a noi è servita da modello per il comprensorio, con qualche licenza poetica.Gli alloggi di Villa Campanario sono disposti nel modo seguente: Al momento, nel comprensorio vivono: Casa Amaro: Marina. Una giovane pittrice che non mangia bene né dipinge molto, ma inventa colori. Per esempio: rosanto è il colore dei fiori dell'amaranto; questo l'ha fatto solo per me. Acquagno è il colore dell'acqua stagnante; questo l'ha fatto per lamentarsi che i tombini del vialetto non drenano bene. Tendaleno; questo è il mio preferito: è la luce multicolore che c'è sotto le tende di un mercato. Insomma, me ne dice uno nuovo ogni volta che la incontro sul vialetto. Casa Acido: Pina e suo papà, Beto. Sua mamma, Chela, se n'è andata nel 2000 e ha lasciato una lettera che Beto ha nascosto e Pina passa la vita a cercare. Questo me l'ha raccontato Agatha Christie. Casa Salato: Linda e Víctor. Musicisti dell'Orchestra Sinfonica Nazionale e gestori della scuola grazie alla quale la mia vita ha una perenne, insopportabile musichetta di flauto dolce in sottofondo. I loro figli: Ana a.k.a. Agatha Christie, Theo e Olmo. E Luz, in qualche modo. Casa Dolce: Accademia di Musica Pérez Walker. PW, dice la minitarghetta accanto al campanello. Nient'altro, perché non abbiamo nessuna licenza per mettere su una scuola vera. In ogni caso, io faccio finta di niente e lascio che Linda e Víctor diano le loro lezioni, perché c'è sempre di peggio nella vita che provare a insegnare solfeggio ai ragazzini. E poi, come me lo pagherebbero l'affitto altrimenti? Casa Umami: Alfonso Semitiel, a.k.a. il Bello, e «le bambine». Le bambine sono due bambole reborn che sono appartenute alla sua bellissima moglie, Noelia Vargas Vargas, che riposi in pace, e che ora lui veste e pettina. Una delle due respira. | << | < | > | >> |Pagina 180Ieri mi è arrivato un invito dell'istituto per un seminario con un titolo così retorico e pomposo che mi è venuta voglia di gridare. L'accademia è il posto in cui la classe media si riempie la bocca di parole senza senso e si mantiene vivo il mito secondo cui sapere è potere. Fandonie! Sapere è debilitante. Sapere gonfia l'ego e spompa l'ingegno. Sapere è usare il corpo sempre meno, vivere seduto. Sapere ingrassa! Grazie al cielo non devo seguire nessuna tesi in questo periodo, perché questo sarebbe l'aforisma con cui distruggerei le vacue teorie del dottorando di turno sullo pseudo-cereale più in voga (sicuramente la quinoa che, mi spiace dirvelo, NON si mangiava in Messico). Andate a raschiare il fondo di tutti i cocci che volete, dio santo, ma usate un po' il cervello e un altro po' il microscopio, e non inventatevi stronzate.
Sapere fa incazzare.
|