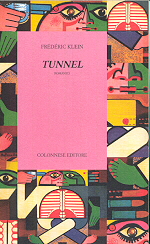
|
|
|
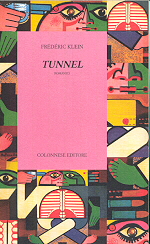
|
|
|
| << | < | > | >> |Pagina 11È buio, dappertutto. Il tenue lucore che filtra dall'alto della parete riesce appena a illuminare la volta. Nessun rumore; solo qualche goccia che ogni tanto trasuda e si schianta al suolo. Tra qualche minuto si concluderà la mia esistenza. Chi mi rimpiangerà? Sono stato un individuo abietto, fra i più odiosi criminali che siano mai esistiti, e nessuno lo dubita. Ho ucciso cinque persone che mi erano vicine, tra le quali un bambino; sono responsabile di un terribile disastro che rimane inspiegato; la forza del mio pensiero un giorno ha scatenato potenze devastatrici; per colpa mia, per poco non si è estinta la razza umana. Presto però tutti sapranno: verrà alla luce tutta la verità. Le cose avrebbero potuto continuare ancora a lungo, se non fosse stato per quel granellino di sabbia che ha finito per bloccare gli ingranaggi. Comunque non mi avranno vivo: ho preso le mie misure. Sul mio cadavere ancora caldo troveranno le mie confessioni. Tanta gente ne resterà sbalordita. | << | < | > | >> |Pagina 15Sono piccolo. Figlio unico. Vivo con i miei genitori in un quartiere popolare di un grosso centro industriale. Abitiamo in uno stabile con la facciata screpolata. Il nostro appartamento è al quinto piano. Non c'è ascensore: bisogna salire i novantatre gradini (li conto ogni volta) di una scala buia, che negli angoli puzza d'urina. Sullo stesso piano ci sono altri due inquilini. La sera tardi e fino a notte tengono accesi i televisori a un volume assordante. I miei genitori picchiano sulle pareti, li insultano, suonano alla loro porta; il più delle volte invano. Loro non si azzardano a dare fastidio agli altri: non hanno mai voluto comprare un apparecchio per paura che mi facesse trascurare i doveri scolastici. Mio padre scende in cantina ogni mattina con un grosso secchio nero che riempie con il carbone della riserva, per alimentare la stufa. Risale le scale ansimando. Il padrone di casa, un vecchio taccagno, non vuole aggiustare niente, si oppone a qualsiasi lavoro di miglioria. Arriva di persona a incassare l'affitto alla fine del mese, spalleggiato dalla consorte impellicciata. È di bella presenza, parla a voce alta e forte, mi dà sempre un buffetto sulla guancia, s'informa sulla mia salute e sui miei progressi. I miei genitori lo tengono in grande considerazione, perché ha una laurea della Scuola Politecnica e vive della rendita di sua moglie. Davanti a lui piegano la schiena: non osano mai fare nemmeno un reclamo. D'altra parte, di che cosa dovremmo lamentarci? Non abbiamo forse l'acqua corrente calda e fredda, e un gabinetto alla turca tra un piano e l'altro? | << | < | > | >> |Pagina 15Fin dove arrivano i miei ricordi, mi vedo sempre solo. Certe volte mi domando chi badasse a me quand'ero un neonato. I miei genitori, di me non si occupano affatto. Hanno altre faccende che giudicano più importanti: il lavoro, la casa, le lezioni, la cucina. Dopo cena mio padre corregge ancora i compiti dei suoi allievi e prepara le lezioni del giorno dopo; mia madre, intanto, lava i piatti, oppure cuce e rammenda. Sotto la lampada che pende dal soffitto, ognuno resta in silenzio. Io non ho il diritto di aprir bocca, salvo in casi eccezionali. Quando sono malato, come capita spesso, resto da solo, tutto il giorno, nell'appartamento deserto. Mi lasciano un pasto freddo e leggero per mezzogiorno e un po' di tisana da riscaldare. «Ormai è abbastanza grande», ribatte mia madre se mio padre azzarda un'obiezione. «Non gli dovremo mica pagare una balia, alla sua età!».
Se la febbre è troppo alta, mi ficco sotto le coperte. Due o tre
volte sono stato preso dal delirio. Ho l'ossessione che succeda ancora. Quando
posso rimanere alzato, mi vado a nascondere per ore sotto il tavolo di cucina,
per non cedere al panico.
Nelle mie prime fotografie dell'album di famiglia ho i capelli lunghi, biondi e ricci, come una bambina. Chiedo come mai non ho né fratelli né sorelle. «Per assicurarti un futuro migliore», risponde mio padre. «Così non devi dividere niente con nessuno e noi possiamo viziarti di più!». Quando dice "viziarti" sfoggia un sorriso soddisfatto. Ho la tentazione di ribattere che l'aria viziata fa male e si spalancano le finestre per eliminarla. Non ho neppure cugini, amici, compagni. Non frequento nessuno della mia età. Mi annoio. Eppure nel nostro stabile abitano altri bambini. Certe volte li incontro, li sento ridere a crepapelle dalla tromba delle scale. Ma mi è vietato divertirmi con loro. «Sono brutta gente», taglia secco mia madre. «Una razza di teppistelli! E poi, non è il nostro ambiente».
In realtà, quel divieto è un sollievo per me: avrei troppa paura a
confondermi con quei monelli.
Non mi hanno mai iscritto al nido e alla scuola materna. A cinque anni e mezzo, nel mese di settembre, metto per la prima volta il piede nel cortile di una scuola. Resto pietrificato in mezzo a quella turba urlante: mi piglia un tale spavento che tornerei subito a casa, se mio padre non mi spingesse avanti con decisione. «Vai a giocare con gli altri!». Vorrei ribattere che non ne sono capace, vorrei restargli aggrappato, chiedergli aiuto. Ma s'è già allontanato per unirsi ai colleghi. Eccomi qua, perduto, irrimediabilmente. Allora rimango da solo in un angolo, con gli occhi bassi, terrorizzato all'idea che qualcuno mi rivolga la parola, si prenda gioco di me, mi picchi, magari. La ricreazione sarà sempre il mio piccolo inferno quotidiano. Aspetto la campanella della fine come una liberazione. | << | < | > | >> |Pagina 43Mio padre coltiva due odi feroci: detesta l'esercito, i sottufficiali, l'istituzione militare, e non può vedere la religione cattolica, colpevole ai suoi occhi d'oscurantismo e d'intolleranza. Ghigna alla vista di una sottana o di un crocifisso, manda i preti a quel paese, li accusa di compromissione, di dubbi costumi, di pederastia. Però mi ha fatto battezzare. Mia madre, che su tali questioni mantiene una neutralità discreta, m'insegna il segno della croce, il Padre Nostro, l'Ave Maria. Mi mandano al catechismo, alla messa, presenziano alla mia prima comunione. Non mi dispiace andarmene da solo, tutte le domeniche mattina, alla chiesa della parrocchia. I bambini sono radunati su alcuni banchi da una parte e dall'altra dell'altare. Imparo presto a memoria i canti e tutto quanto c'è da sapere della liturgia latina. Invidio i due chierichetti che fanno tintinnare il campanello all'elevazione e che chinano il capo in un unanime atto di venerazione. Il vecchio curato nero e panciuto mi ha preso in simpatia. Certe volte mi fa le sue confidenze, fumando la pipa. Quando vado a confessarmi da lui, mi chiede con un tono terribile e misterioso se ho "cattivi pensieri". Non so proprio come rispondergli, non sapendo a quale peccato egli alluda. Evito accuratamente di accennare alla scena sul balcone o a quello che ho visto dal buco della serratura. Mi sento un sincero credente e lo manifesto. Mio padre si irrita per certe improvvise fiammate di devozione: teme che finisca per essere preso davvero dal gioco. Allora moltiplica i dileggi, i richiami all'ordine, in nome dell'antica tradizione anticlericale e laica. La messa domenicale resterà tollerata, ma la confessione è vietata. Dopo la solenne prima comunione, per la soddisfazione dei nonni e per tappare la bocca a chissà chi, la faccenda sarà chiusa. Io non riesco a vedere nessuna differenza tra la morale di mio padre e quella del clero. In entrambi i casi, la stessa ipocrisia: si predica l'obbedienza e la sottomissione, si rende servi pretendendo di liberare. La religione, però, mi sembra che offra il vantaggio di un'illuminazione divina, di una rivelazione d'amore. Comunque preferisco rinunciare al misticismo, per non rischiare di attirarmi sul capo i fulmini paterni. | << | < | > | >> |Pagina 45Tutti gli anni, in agosto partiamo per un mese al mare. I miei genitori affittano un monolocale che deve essere pulito da cima a fondo quando arriviamo. Io preferirei rimanere dal nonno, ma la mia opinione non è mai richiesta. Trascorriamo le giornate ad abbronzarci. Mi piacerebbe di più fare qualche gita: detesto la spiaggia, la calca; quando sono con gli slip, mi si vedono le costole. Non sono capace di fare amicizia con nessuno. Senza i miei libri mi annoio a morte. Mia madre, le cui bruttezze sono crudelmente rivelate dal costume da bagno, mi sgrida perché le resto sempre tra i piedi.
«Questo bambino non sa proprio divertirsi, non sa farsi qualche amico. Ma
insomma, va' a giocare come fanno gli altri, un po' d'iniziativa!».
Ho una paura folle dell'acqua. Quando compio nove anni, cercano di farmi imparare a nuotare. Senza successo. Il maestro si dispera; ammette comunque che non dipende dalla mia cattiva volontà. Ogni volta che un'onda mi arriva alla bocca e agli occhi, m'invade un terrore folle. So che sto per annegare e ho solo un'idea in mente: uscire dall'acqua, fuggire. Questo impossibile apprendistato finisce per guastarmi le vacanze. Per fortuna i miei genitori, furiosi di pagare le lezioni inutilmente, preferiscono rinunciare. Per il pranzo della domenica si offrono il lusso di un ristorante economico. Nel mezzo di uno di quei pasti, di ritorno dal bagno, esamino una carta della regione appesa accanto alla reception. Mi colpisce un dettaglio che non compare sulla copia che possiede mio padre. Mi precipito entusiasta a tavola. «Stanno costruendo una nuova linea e una stazione in paese!». Mio padre ci mette un po' a capire. «Ma no, stupido, è il contrario! Da molto tempo le ferrovie non costruiscono più niente... La carta che hai visto non è più recente, ma più vecchia della mia. Adesso la linea è dismessa, forse anche sferrata. Hai capito?». Chiedo il significato dell'ultimo participio.
«Hanno tolto le rotaie: resta solo la piattaforma, se non hanno
demolito anche quella!».
Sono costernato, ardo dalla voglia di andare sul posto a constatare íl disastro. Nonostante le mie suppliche, però, i miei genitori si rifiutano di cedere a quello che definiscono un capriccio. Decido di mettere il muso per tutta la giornata e mi riprometto solennemente, quando sarò libero e grande, di percorrere tutte le linee dismesse che mi capiterà d'incontrare. | << | < | > | >> |Pagina 59Mio padre è morto di cancro diciotto mesi fa. Ho seguito con impazienza il progredire del male e ho accolto l'esito fatale non senza sollievo. Invece di ammorbidirlo, la vecchiaia e la pensione l'avevano reso più scostante. Non aveva più allievi o figli da far tremare, si era rinchiuso nel suo ambiente, era diventato aggressivo, acido, dispotico: un doppio di sua moglie.
Pur non avendone molta voglia, ho partecipato ai funerali. Ovviamente ha
voluto un servizio religioso.
Mia madre è ancora in vita. È ormai molto anziana, paralizzata dai reumatismi. Visto che non sopportava la solitudine e si dimostrava non più in grado di farcela da sola, è stata messa in un ospizio, a venti chilometri dalla mia città natale. C'è voluto del bello e del buono per trovarle un posto. Vado a trovarla una volta all'anno, a Ognissanti. Ne approfitto per lasciare un vaso di crisantemi sulla tomba paterna. Per giustificare la rarità delle mie visite, adduco come pretesti la distanza, gli impegni di lavoro. Lei non è stupida e mi fulmina con occhiate di muto rimprovero. Ma che cosa potremmo dirci? Se almeno ci fosse ancora un treno da veder passare, come una volta... Aspetto che scompaia; spero che non ci metta molto.
Mi sembra che sarò finalmente libero, quando saranno entrambi defunti.
Certo, è solo un'illusione. Gli orfani non sanno quanto sono fortunati.
Un telegramma arrivato dalla provincia mi comunica l'improvviso aggravarsi delle condizioni di salute di mia madre. È caduta malamente ed è costretta all'immobilità. A quanto pare chiede di me; mi sento in obbligo a partire. Prendo imprecando il rapido del lunedì mattina. Un taxi mi porta a destinazione. La residenza è costruita su un poggio, in mezzo a un parco accogliente, dove un tempo s'ergeva un antico castello distrutto dalla Rivoluzione, del quale si vede ancora il fossato. Mia madre ha la fortuna di avere una camera singola. La trovo invecchiata, grinzosa, rattrappita; l'hanno sistemata con la gamba ingessata su una sedia a rotelle. Siccome è presente l'infermiera, faccio lo sforzo di posarle le labbra sulla fronte. Mi consigliano con insistenza di portarla a fare una passeggiata all'esterno, senza dubbio un buon sistema per sbarazzarsi di lei per qualche tempo: «Vedrà come le farà bene stare all'aria aperta! È così una bella giornata... E poi potrete chiacchierare: non riesce quasi più a parlare, ma capisce tutto. Avrà tante cose da raccontarle, dopo tutto questo tempo! Un figlio e la sua mamma, guardateli! Le mancava tanto».
«Anche lei a me», mi sento rispondere.
Spingo l'arnese a denti stretti. Lo dirigo verso i viali più remoti del parco, in prossimità del muro di cinta. Verifico che non ci sia nessuno in giro che possa sorprenderci. Poi mi fermo, mi pianto davanti a lei e l'apostrofo in tono trionfante: «Invalida, muta... Ormai sei in mio potere! Una giusta ritorsione!». Comincio a insultarla, scegliendo i termini più violenti, i più volgari e offensivi. Lei non batte ciglio, le spunta soltanto un lieve rossore sulle guance. La schiaffeggio con forza, per tre volte. Continua a fissarmi con quegli occhi duri e freddi. Allora il mio furore non conosce più limiti. La colpisco al volto, alle braccia, dappertutto; la copro di pugni e di calci, scuoto il gesso fino a romperlo. Alla fine le si appannano gli occhi, un colpo più brutale riesce a strapparle un lungo gemito.
Sogghigno: «Credi di commuovermi? Chi l'avrebbe mai detto,
eh? Mai fidarsi dei bambini troppo buoni!».
Sono deciso a non lasciarle tregua: giro la sedia a rotelle e la spingo rudemente nell'altra direzione. Dopo aver superato l'edificio principale, m'inoltro verso il lato ovest, dove la discesa è più ripida. Arrivo nel punto più adatto, aspetto che non ci sia nessuno in giro. Poi sciolgo la cintura di sicurezza che la cinge, allento i freni e spingo con forza le ruote che prendono velocità poco a poco. In fondo al viale c'è un muretto che sovrasta l'impressionante fossato dell'ex castello, dove abbondano i cespugli di rovi. Come mai nessuno ha pensato a riempirlo, per evitare incidenti ai pensionanti? Per la violenza dell'urto, mia madre è precipitata giù dal veicolo, con un volo superbo. Fingo di affrettarmi a soccorrerla, richiamo a gran voce il personale. Accorrono subito in tanti. Portano una scala, una barella. Io lancio grida strazianti. Sopravviene il direttore in persona, messo in allarme dal clamore crescente: allontana i curiosi e dirige le operazioni di soccorso. Si dimostra subito molto contrariato, m'interroga senza tanti complimenti, mi strapazza. Poi, vedendo che manifesto una profonda disperazione, il pentimento più sincero, si raddolcisce: «Via, mio povero amico, è chiaro che non ha potuto farci niente... È un terribile concorso di circostanze, una fatalità!».
Cambia bersaglio: se la prende con l'infermiera che ha affidato
la sua paziente a un tale imbranato. La quale infermiera mi scruta con
un'espressione di sospetto.
Quattro ore più tardi sono autorizzato a rivedere mia madre in camera sua. L'hanno ripescata dal fossato in condizioni pietose: il viso sanguinante e orribilmente tumefatto è avvolto da uno spesso bendaggio. Hanno dovuto toglierle una a una le spine con una pinzetta. Sembra respirare a stento. «Che brutto incidente», mi sussurra il dottore. «Il roveto l'ha straziata, ma le ha salvato la vita, le ha attutito l'urto. Nemmeno una frattura, niente!». Deglutisco a fatica. «Allora lei pensa che ce la farà?». Il medico ha un gesto d'impotenza rassegnata. «Non posso proprio dirlo, purtroppo! Fisicamente se la cava piuttosto bene, ma uno shock del genere, alla sua età, e nelle sue condizioni... No, sarebbe un vero miracolo». Respiro subito meglio. «E... soffre?». «Non voglio nasconderglielo: temo di sì... e sembra ancora cosciente».
Tiro un sospiro profondo.
La sera tardi mi offrono ospitalità su un letto aggiunto nella camera di
lei. Accetto con entusiasmo. Quella notte, accanto a mia madre, dormo il sonno
del giusto.
Al mattino prevale il pessimismo: gli esami clinici non lasciano nessuna speranza. Decido di aspettare la fine sul posto, telefono al preside della facoltà per giustificare la mia assenza. Verso le undici, l'infermiera mi prende da parte. «È riuscita a sussurrarmi qualche parola all'orecchio. Le ho inteso dire 'apposta': l'ha ripetuto più volte». Fingo di non capire che cosa voglia dirmi. D'altra parte dubito che mia madre sia riuscita davvero a parlare.
«Lei vuol dire 'posta'? Chissà, probabilmente ha la mente sconvolta... Una
donna tanto lucida, straordinaria per tanti aspetti... che triste fine!».
Mia madre muore la notte seguente. Resto al suo capezzale fino all'ultimo
istante.
Devo rimanere ancora qualche giorno per completare le formalità necessarie. Quanto tempo perso, quanti soldi buttati! Mi ha avvelenato l'esistenza fino alla fine. Scelgo la cassa meno costosa, di legno bianco. Niente annunci sui giornali, niente fiori o corone.
Lei voleva una cerimonia religiosa, voleva essere sepolta accanto un
al marito. Io opto per un servizio civile, seguito da una cremazione
con dispersione delle ceneri al vento.
Nella saletta a volta dell'obitorio, gli impiegati delle pompe funebri si ritirano per una decina di minuti, per lasciarmi solo con lei per un ultimo saluto. La pallida luce d'aprile entra tra le griglie delle alte finestre. Contemplo un'ultima volta l'odiato viso. L'hanno truccata per cercare di nascondere i graffi. Nella bara aperta, con quella pelle secca, screpolata, vizza, assomiglia a una mummia orrenda, pronta a infierire ancora. A vederla così, nello stesso tempo diversa e sempre simile a se stessa, a esaminare quella figura calma, posata, impassibile, quasi innocente, mi riprende la rabbia. Noto una magnifica rosa rossa che le hanno sistemato tra le dita, al posto del rosario o del crocifisso: l'afferro, la strappo selvaggiamente, ne calpesto i petali.
Quando rientrano i becchini per sigillare il coperchio, mi limito
a spiegare che mia madre detestava i fiori.
|