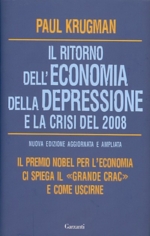
|
|
|
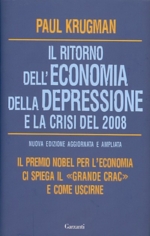
|
|
|
| << | < | > | >> |Indice
Introduzione 7
Questo libro, 10
1. «Il problema principale è stato risolto» 13
Il trionfo del capitalismo, 14;
Il ciclo economico addomesticato, 19;
La tecnologia come elemento salvifico, 27;
I frutti della globalizzazione, 30;
Gli scettici e i critici, 34
2. Un avvertimento ignorato:
le crisi dell'America Latina 37
Il Messico: dagli anni Ottanta in poi, 39;
L'Argentina rompe con il passato, 46;
Il difficile anno del Messico, 49;
La crisi tequila, 54;
Il grande salvataggio, 59;
Trarre le conclusioni sbagliate, 60
3. La trappola del Giappone 65
Quando il Giappone era il numero uno, 66;
La bolla, la trappola e il disastro, 70;
Una depressione nascosta, 76;
La trappola del Giappone, 77;
Il Giappone alla deriva, 81;
La ripresa del Giappone, 87
4. Il crollo dell'Asia 89
Il boom, 89;
2 luglio 1997, 97;
Il disastro, 100;
Il circolo vizioso della crisi finanziaria, 103;
Il contagio, 104;
Perché l'Asia? Perché il 1997?, 107;
Epilogo: Argentina, 2002, 111;
La domanda più importante, 114
5. Perversione politica 115
La mancata evoluzione del sistema monetario
internazionale, 117;
La minaccia speculativa, 124;
La fiducia in gioco, 126;
Il Fondo Monetario Internazionale
ha peggiorato la situazione?, 130
6. I padroni dell'universo 135
Il Mostro, 136;
La leggenda di George Soros, 138;
La pazzia del primo ministro Mahathir, 141;
L'attacco a Hong Kong, 143;
L'economia Potemkin, 148;
Il panico del 1998, 151
7. Le bolle di Greenspan 157
L'era di Greenspan, 158;
Il guidatore designato dell'America, 160;
Le bolle di Greenspan, 162;
Quando le bolle scoppiano, 170
8. Il sistema bancario-ombra 173
Storia semplificata dell'attività bancaria, 173;
Il sistema bancario-ombra, 178;
Indifferenza malevola, 182
9. La somma di tutte le paure 185
La crisi immobiliare e la sua ricaduta, 186;
La crisi delle banche-non banche, 190;
La FED perde efficacia, 193;
La madre di tutte le crisi valutarie, 197;
Una crisi globale, 200
10. Il ritorno dell'economia della depressione 203
Che cosa è l'economia della depressione?, 203;
Che cosa c'è in gioco?, 206;
Accusare le vittime, 208;
Proteggere i ricchi, 211;
Aiutare i poveri, 213;
Orgoglio e pregiudizio, 216
|
| << | < | > | >> |Pagina 7La maggior parte degli economisti, se per caso hanno avuto una propria opinione in merito, considerano la Grande Depressione degli anni Trenta una tragedia di cui si poteva tranquillamente fare a meno. Se solo Herbert Hoover non avesse tentato di portare il bilancio in pareggio in un momento di piena recessione; se solo la Federal Reserve non avesse difeso lo standard aureo a spese dell'economia nazionale; se solo fosse stato dato denaro contante alle banche sull'orlo del collasso, così da arginare il panico che si diffuse tra gli istituti di credito negli anni 1930-31; allora il crollo del mercato azionario del 1929 avrebbe portato solo a una recessione di poco conto, che sarebbe stata presto dimenticata. E poiché economisti e politici hanno imparato la lezione – oggi nessun ministro del Tesoro seguirebbe infatti il famoso consiglio di Andrew Mellon di «Disfarsi degli operai, disfarsi delle azioni, disfarsi dei contadini, disfarsi degli investimenti immobiliari... espellere il marcio dal sistema» – niente di simile alla Grande Depressione potrà mai fare ritorno. E se non fosse vero? Alla fine degli anni Novanta, un gruppo di economie asiatiche – economie che producevano circa un quarto dell'output mondiale e contavano una popolazione complessiva di oltre seicento milioni di abitanti – ha vissuto una crisi che ricorda sinistramente la Grande Depressione. Oggi come ieri quella crisi ha cominciato a dare i primi segnali in un cielo azzurro e sereno, quando la maggior parte degli esperti prevedeva che il boom sarebbe comunque continuato, anche se la recessione si stava avvicinando; oggi come ieri i tradizionali interventi macroeconomicì si sono rivelati inefficaci, forse anche controproducenti. Il fatto che qualcosa di simile possa accadere nel mondo moderno dovrebbe far venire i brividi a chiunque abbia un minimo di senso della storia. A me li ha fatti venire di sicuro. La prima edizione di questo libro è stata scritta in risposta alla crisi asiatica degli anni Novanta. Mentre alcuni la consideravano un fenomeno esclusivamente asiatico, io la consideravo un fosco presagio per tutti noi, un indicatore del fatto che i problemi dell'economia della depressione non sono venuti meno nel mondo moderno. È triste doverlo dire, ma avevo ragione a preoccuparmi: mentre questa nuova edizione va in stampa, gran parte del mondo, inclusi gli Stati Uniti, è alle prese con una crisi finanziaria ed economica che assomiglia alla Grande Depressione ancora più di quanto non le assomigliavano le vicissitudini asiatiche degli anni Novanta. Il tipo di problema che ha vissuto l'Asia un decennio fa, e che stiamo vivendo tutti noi, è proprio quello che pensavamo di avere imparato a evitare. Nel passato, durante i momenti di difficoltà, i grandi paesi industrializzati con governi forti – come la Gran Bretagna negli anni Venti – potevano non essere sempre in grado di rispondere a prolungati periodi di stagnazione e deflazione; ma negli anni a cavallo tra John Keynes e Milton Friedman eravamo convinti di essere ormai sufficientemente pronti a evitare che ciò succedesse di nuovo. Tempo fa le nazioni più piccole – come l'Austria nel 1931 – potevano anche restare in balìa dei dissesti finanziari e apparire incapaci di governare il loro destino economico, ma oggi ci si aspetta che esperti banchieri e funzionari governativi (per non parlare del FMI) siano in grado di intervenire rapidamente così da contenere le crisi prima che si diffondano. Un tempo i governi – come quello degli Stati Uniti durante gli anni 1930-31 – potevano assistere impotenti al collasso del sistema bancario nazionale; ma nel mondo moderno si presume che l'assicurazione dei depositi e la prontezza delle banche centrali nel fornire denaro contante agli istituti di credito in difficoltà possano prevenire il sorgere di queste situazioni. Nessuna persona di buon senso pensava che i problemi in economia fossero finiti; eravamo comunque sicuri che qualsiasi problema avessimo mai potuto incontrare in futuro sarebbe stato abbastanza diverso da quelli degli anni Venti e Trenta. Ma un decennio fa avremmo dovuto renderci conto che la nostra fiducia era mal riposta. Il Giappone si è trovato per quasi tutti gli anni Novanta in una trappola economica che Keynes e i suoi contemporanei conoscevano benissimo. Le economie asiatiche più piccole, per contro, sono passate dal boom alla calamità praticamente da un giorno all'altro; e la storia di questo tracollo sembra ambientata nel clima finanziario degli anni Trenta. All'epoca la pensavo così: era come se alcuni batteri che avevano causato gravissime pestilenze, ma che si consideravano ormai definitivamente sconfitti dalla medicina moderna, fossero riemersi in una forma resistente agli antibiotici standard. Ecco quello che scrivevo nell'introduzione alla prima edizione: «Per ora solo un numero limitato di persone è stato vittima di questo nuovo malessere incurabile; ma anche quelli che hanno avuto la fortuna di non essere contagiati sarebbero degli sciocchi se non cercassero nuove cure, nuovi accorgimenti preventivi, qualsiasi cosa occorra, per evitare di diventare le prossime vittime». Be', siamo stati veramente degli sciocchi. E adesso abbiamo in casa la peste.
Questa nuova edizione è dedicata in gran parte alla crisi
asiatica degli anni Novanta, che si è rivelata una sorta di
prova generale della crisi globale a cui stiamo assistendo adesso. Ma ho
aggiunto parecchio nuovo materiale, nel tentativo di spiegare perché gli Stati
Uniti si sono ritrovati nella stessa situazione in cui versava il Giappone una
decina di anni fa, perché l'Islanda si è ritrovata nella stessa situazione
della Thailandia, e perché i paesi colpiti dalla crisi originaria degli anni
Novanta si sono ritrovati ancora una volta sull'orlo dell'abisso.
Questo libro Permettetemi di dichiarare subito che questo libro è, in fondo, un trattato analitico. Non si occupa tanto di quello che è successo quanto del perché. La cosa importante, credo, è capire come questa catastrofe sia potuta accadere, come possano riprendersi i paesi colpiti e come possiamo evitare che la situazione si ripeta. Di conseguenza l'obiettivo ultimo è, come insegnano nelle aule di economia, sviluppare una teoria su questo specifico argomento, riuscire a capire come interpretare questa serie di eventi. Tuttavia ho tentato di non renderla un'esposizione teorica. Non ci sono né equazioni, né diagrammi complicati, né (mi auguro) parole incomprensibili. In qualità di economista di una certa fama sono assolutamente in grado di scrivere cose che nessuno può leggere. In realtà il linguaggio incomprensibile – il mio e quello degli altri – mi ha aiutato a giungere alle conclusioni che vi presento qui di seguito. In questo momento il mondo ha bisogno di decidere sulla base di informazioni concrete; di conseguenza le idee devono essere rese accessibili a tutte le persone interessate, non solo ai professori di economia. Comunque le equazioni e i diagrammi caratteristici dell'economia formale rappresentano, il più delle volte, solo un'impalcatura utilizzata per aiutare a mettere in piedi una costruzione intellettuale. Una volta che i lavori di costruzione abbiano raggiunto un certo livello, l'impalcatura può essere tolta, lasciando così solo parole comprensibili. Inoltre, sebbene il principale obiettivo del libro sia analitico, vi sono contenute molte descrizioni di eventi. In parte perché seguire una storia dall'inizio alla fine spesso garantisce che la teoria di cui si sta discutendo abbia senso. (Per esempio, la visione «fondamentalista» delle crisi economiche – secondo la quale le economie hanno soltanto la punizione che si meritano – deve fare i conti con la strana coincidenza che un gran numero di sistemi economici apparentemente così diversi siano crollati nel giro di pochi mesi.) Ritengo inoltre che riportare l'intera sequenza degli eventi fornisca un quadro di riferimento necessario a ogni tentativo di spiegazione, e che la maggior parte delle persone non abbia passato gli ultimi 18 mesi a seguire in maniera ossessiva le varie fasi del dramma. Non tutti ricordano cosa ha detto il primo ministro Mohamad Mahathir a Kuala Lumpur nell'agosto del 1997, e non tutti riescono a mettere in relazione questa dichiarazione con quanto ha finito per fare Donald Tsang a Hong Kong un anno dopo. Bene, questo libro servirà a rinfrescarvi la memoria. | << | < | > | >> |Pagina 13Nel 2003 Robert Lucas, docente presso la University of Chicago e vincitore nel 1995 del premio Nobel per l'economia, ha tenuto il discorso presidenziale all'assemblea annuale dell'American Economic Association. Dopo aver spiegato che la macroeconomia era nata in risposta alla Grande Depressione, ha dichiarato che era ora di fare un passo avanti in questo campo: «Il problema principale di prevenire la depressione», ha osservato, «è stato risolto, in tutte le sue implicazioni pratiche». Lucas non ha detto che il ciclo economico, l'alternanza irregolare di recessioni ed espansioni che ci accompagna da almeno un secolo e mezzo, era finito. Ma ha detto che era stato addomesticato, al punto che i benefici di nuovi interventi finalizzati a metterlo ulteriormente sotto controllo si potevano considerare marginali: l'appiattimento delle irregolarità che si riscontrano nel processo di crescita, ha affermato, avrebbe prodotto solo dei benefici trascurabili a livello di benessere nazionale. Era venuto perciò il momento di concentrarsi su aspetti come la crescita economica di lungo termine. Lucas non era l'unico a sostenere che la prevenzione della depressione fosse ormai un problema risolto. Un anno dopo Ben Bernanke, un ex professore di Princeton che era entrato a far parte del board della Federal Reserve – e di lì a poco ne sarebbe diventato il presidente – ha tenuto un discorso straordinariamente ottimista intitolato The Great Moderation, in cui affermava, proprio come Lucas, che la moderna politica macroeconomica aveva risolto il problema del ciclo economico – o, per essere più precisi, l'aveva ridotto a un banale fastidio. A pochi anni di distanza, mentre gran parte del mondo è alle prese con una crisi finanziaria ed economica che ricorda sin troppo da vicino gli anni Trenta, questi pronunciamenti ottimistici appaiono quasi incredibili. La cosa più singolare di quell'ottimismo era il fatto che negli anni Novanta, problemi economici molto simili ai sintomi della Grande Depressione erano emersi in diversi paesi – incluso il Giappone, la seconda economia del mondo.
Ma nei primi anni di questo decennio, i problemi tipici
della depressione non avevano ancora colpito gli Stati Uniti, mentre
l'inflazione – il flagello degli anni Settanta – appariva finalmente sotto
controllo. E questa notizia relativamente tranquillizzante si inquadrava in un
contesto politico che incoraggiava l'ottimismo: il mondo sembrava più favorevole
alle economie di mercato di quanto non fosse stato da quasi novant'anni.
Il trionfo del capitalismo Questo è un libro di economia, ma inevitabilmente l'economia prende forma in un contesto politico e non si può comprendere il mondo così come appariva in quell'estate dorata senza considerare l'evento politico fondamentale degli anni Novanta: il collasso del socialismo, considerato non soltanto come ideologia dominante, ma come ideale in grado di far muovere la mente degli uomini. Il collasso ebbe inizio, abbastanza stranamente, in Cina. Fa ancora impressione ricordare che nel 1978 Deng Xiao-ping aveva spinto il suo paese su quella che poi sarebbe stata conosciuta come la via al capitalismo, solo tre anni dopo la vittoria dei comunisti in Vietnam e solo due anni dopo la sconfitta interna dei maoisti radicali che volevano ricominciare la Rivoluzione culturale. Probabilmente Deng non comprese del tutto quanto lontano avrebbe portato la strada da lui indicata; certamente il resto del mondo ci mise un bel po' per capire che un miliardo di persone si era tranquillamente lasciato alle spalle il marxismo. Infatti, al più tardi nei primi anni Novanta, la trasformazione della Cina non era assolutamente stata recepita dall'opinione pubblica; nei bestseller del tempo l'economia mondiale era vista come un'arena per un combattimento «testa a testa» tra Europa, America e Giappone – la Cina veniva ritenuta al massimo un attore di secondo piano, eventualmente parte di un gruppo di paesi emergenti sotto l'egida dello yen. Ciò nonostante tutti avevano intuito che qualcosa era cambiato – e che quel «qualcosa» era la caduta dell'Unione Sovietica. Nessuno capisce veramente che cosa sia accaduto al regime sovietico. Col senno di poi noi ora consideriamo quella struttura come qualcosa il cui sviluppo era stato a lungo ostacolato, e che dunque era destinata al fallimento. In realtà quello sovietico era un regime che aveva conservato il potere passando attraverso una guerra civile e una carestia, che nonostante tutto era stato capace di sconfiggere il precedente Nuovo Ordine tedesco, che era in grado di mobilitare risorse scientifiche e industriali per competere con la superiorità nucleare degli Stati Uniti. La ragione per cui l'Unione Sovietica sia finita così all'improvviso, senza esplosioni, ma con solo un leggero brontolio, va considerata uno dei grandi misteri dell'economia politica. Probabilmente era solo questione di tempo – alcuni dicono che il fervore rivoluzionario, al di là di quel gran desiderio di uccidere i nemici in nome di un bene superiore, non può durare per più di un paio di generazioni. Oppure il regime potrebbe essere stato progressivamente indebolito dal fatto che il capitalismo si rifiutava ostinatamente di mostrarsi vicino alla fine. Io ho una mia personale teoria in proposito, che tuttavia non si basa su alcuna prova specifica: secondo me, la crescita dell'Asia ha demoralizzato in maniera sottile ma profonda il regime sovietico, rendendo ancora meno plausibile la pretesa di quest'ultimo di avere la storia dalla sua parte. L'orribile guerra dell'Afghanistan, destinata a essere persa sin dall'inizio, ha certamente facilitato questo processo, assieme all'evidente incapacità dell'industria sovietica di confrontarsi con la crescita militare statunitense all'epoca di Ronald Reagan. Ma poco importa: qualunque sia stata la ragione, nel 1989 l'impero sovietico si sfaldò improvvisamente nell'Europa dell'Est e nel 1991 la medesima sorte toccò alla stessa Unione Sovietica. Gli effetti di questo sfaldamento furono avvertiti in tutto il mondo, in modo evidente e sottile. E le sue conseguenze facilitarono il successo politico e ideologico del capitalismo. Innanzitutto diverse centinaia di milioni di persone che vivevano sotto i regimi marxisti divennero improvvisamente cittadini di stati disposti a tentare la strada dell'economia di mercato. Al contrario di quanto la maggior parte delle persone si aspettava, le «economie di transizione» dell'Europa dell'Est non diventarono rapidamente protagoniste di primo piano nell'economia mondiale, o meta privilegiata per gli investimenti stranieri. Caso mai accadde il contrario, poiché la maggior parte di questi paesi dovette fare molta fatica per portare a termine la transizione: la Germania dell'Est, per esempio, è diventata per la Germania l'equivalente di quello che il Mezzogiorno è per l'Italia: una zona sempre depressa che continua a essere fonte di problemi sociali e fiscali. Solo oggi, una decina d'anni dopo la caduta del comunismo, alcuni paesi – la Polonia, l'Estonia e la Repubblica Ceca – possono essere annoverati tra le storie di successo. La stessa Russia non è riuscita a effettuare una convincente transizione all'economia di mercato; anzi, dopo aver preso a prestito ingenti quantitativi di denaro, offrendo in realtà come garanzia il suo decadente arsenale nucleare, ha rischiato di diventare fonte d'instabilità finanziaria per il resto del mondo. | << | < | > | >> |Pagina 30I frutti della globalizzazioneLa definizione «Terzo Mondo» era stata originariamente coniata per esprimere un certo orgoglio: Jawaharlal Nehru la utilizzò per primo per descrivere i paesi che avevano difeso la loro indipendenza, non alleandosi né con l'Occidente né con l'Unione Sovietica. Ma in breve l'originaria intenzione politica fu sopraffatta dalla realtà economica: il «Terzo Mondo» cominciò a voler dire arretrato, povero, sottosviluppato. E questo termine perse la connotazione di legittima ambizione, per acquistarne una priva di speranza. Questo cambiamento era dovuto alla globalizzazione: il trasferimento di tecnologia e di capitale dai paesi con alto costo del lavoro a quelli con manodopera più a buon mercato, e la conseguente crescita di esportazioni ad alta intensità di lavoro dal Terzo Mondo. È assai difficile ricordare a cosa somigliava il mondo prima della globalizzazione; quindi proviamo a far girare all'indietro le lancette dell'orologio, fino al Terzo Mondo di meno di una generazione fa (è ancora così, in molti paesi). A quel tempo, sebbene la rapida crescita economica di alcuni piccoli paesi del vicino Oriente avesse già iniziato ad attirare l'attenzione, paesi in via di sviluppo come le Filippine, l'Indonesia o il Bangladesh restavano in gran parte quello che erano sempre stati: esportatori di materie prime, importatori di prodotti finiti. Piccoli, inefficienti settori produttivi rifornivano i mercati interni, protetti da quote d'importazione, ma questi settori generavano pochi posti di lavoro. Allo stesso tempo l'aumento della popolazione costrinse i poveri contadini a coltivare territori sempre più marginali, o a cercare in tutti i modi di sopravvivere – per esempio facendosi dare in concessione una delle tante montagne di rifiuti che si trovano alla periferia di molte città del Terzo Mondo. In mancanza di altre opportunità, a Giacarta o a Manila era possibile assumere operai per un tozzo di pane. Ma, alla fine degli anni Settanta, la disponibilità di lavoro a buon mercato non bastava a rendere competitivo un paese in via di sviluppo sui mercati mondiali. I vantaggi dei paesi industrializzati – il know-how tecnico e logistico, le dimensioni molto più vaste dei mercati e la vicinanza ai fornitori, la stabilità politica e i sottili ma cruciali adattamenti sociali necessari a operare in un'economia efficiente – sembravano compensare differenze pari anche a dieci o venti volte il costo della mano d'opera. Anche gli estremisti sembravano aver perso ogni speranza di poter capovolgere questa situazione: negli anni Settanta la richiesta di un Nuovo Ordine Economico Internazionale si concentrava sul tentativo di aumentare il prezzo delle materie prime, piuttosto che di far entrare i paesi del Terzo Mondo nel moderno sistema industriale. E poi, improvvisamente, successe qualcosa. Un misterioso insieme di eventi che ancora non abbiamo ben compreso – meno barriere all'ingresso, migliori telecomunicazioni, tariffe aeree più convenienti – ridussero gli svantaggi per chi produceva nei paesi in via di sviluppo. A pari condizioni è ancora meglio produrre nei paesi industrializzati – sono numerosi i casi di aziende che, dopo aver spostato la produzione in Messico o nel vicino Oriente, hanno deciso di tornare sui loro passi dopo aver toccato con mano gli svantaggi del Terzo Mondo – ma a quell'epoca in alcuni settori il basso costo del lavoro rappresentò per i paesi in via di sviluppo un vantaggio competitivo sufficiente per poter entrare nei mercati mondiali. E così i paesi che prima sopravvivevano vendendo juta o caffè, cominciarono invece a produrre magliette e scarpe di tela. Gli operai impiegati nella produzione di scarpe e magliette vengono inevitabilmente pagati molto poco e devono essere disposti a sopportare condizioni di lavoro terribili. Ho detto «inevitabilmente» perché i loro datori di lavoro non hanno deciso di avviare un'attività economica per prendersi cura della propria salute (o di quella dei propri operai); cercheranno quindi di pagare il meno possibile, e questo minimo dipende dalle altre opportunità che i lavoratori hanno a disposizione. E in molti casi si tratta ancora di paesi molto poveri. Tuttavia nei paesi dove i nuovi settori dediti all'export hanno trovato terreno fertile, c'è stato un miglioramento innegabile nella vita della gente comune. In parte perché i nuovi settori economici devono poter offrire ai lavoratori uno stipendio in qualche modo più alto di quello reperibile altrove, così da incentivare il cambiamento. Ancora più importante, tuttavia, è che la crescita dell'industria – e di tutto l'indotto che ha creato l'export – abbia avuto un effetto benefico su tutta l'economia. La spinta a occupare nuove terre divenne meno intensa e di conseguenza gli stipendi dei contadini crebbero; si ridusse il numero di disoccupati che nelle grandi città erano sempre in cerca di lavoro e, così facendo, le industrie cominciarono a disputarsi l'un l'altra i lavoratori, e gli stipendi cominciarono a crescere anche nelle città. Nei paesi dove questo processo era durato abbastanza a lungo – per esempio nella Corea del Sud o a Taiwan – gli stipendi hanno raggiunto livelli da paesi avanzati. (Nel 1975 lo stipendio medio orario nella Corea del Sud era solo il 5% di quello degli Stati Uniti; nel 2006 era salito al 62%.) I benefici per la popolazione dei paesi da poco industrializzati, causati dalla crescita delle esportazioni, erano evidenti. Un paese come l'Indonesia è ancora così povero che il progresso può essere misurato con la quantità di cibo che in media ogni abitante può mangiare; tra il 1968 e il 1990 la razione di cibo giornaliera pro capite aumentò da 2000 a 2700 calorie e l'aspettativa di vita passò dai 46 ai 63 anni. Si possono osservare miglioramenti simili lungo tutta la costa del Pacifico e anche in stati come il Bangladesh. Questi miglioramenti ebbero luogo senza che nessun occidentale avesse fatto niente per aiutare le popolazioni – gli aiuti provenienti dall'estero, mai troppi, negli anni Novanta si ridussero praticamente a zero. I miglioramenti non erano neanche la conseguenza di particolari politiche attuate dai governi nazionali, che – come presto ci saremmo resi conto – erano corrotti e senza cuore. Erano invece il risultato indiretto e non intenzionale della condotta di multinazionali senz'anima e di imprenditori locali senza scrupoli, il cui unico scopo era quello di approfittare delle interessanti opportunità offerte dalla disponibilità di lavoro a buon mercato. Non era uno spettacolo particolarmente edificante; ma poco importa quanto fossero spregevoli le motivazioni di coloro che vi erano coinvolti: il risultato fu quello di riuscire a tirare fuori dalla povertà più miserabile centinaia di milioni di persone e a creare condizioni di vita che in molti casi erano ancora orribili ma, nonostante tutto, erano assai migliori di prima.
Una volta di più il capitalismo poteva, a ragione, vantarsi
dei risultati raggiunti. I socialisti avevano a lungo promesso
lo sviluppo; una volta il Terzo Mondo considerava i Piani
quinquennali di Stalin il solo modo con cui una nazione
sottosviluppata poteva entrare nel XX secolo. Anche dopo
che l'Unione Sovietica aveva perso la sua fama progressista,
molti intellettuali credevano che solo non entrando in competizione con i
sistemi economici più avanzati le nazioni
povere potevano sperare di uscire dalle loro trappole. Negli
anni Novanta, tuttavia, alcuni paesi testimoniarono che un
rapido sviluppo dopo tutto era possibile – e lo si poteva ottenere non con
l'orgoglioso isolazionismo socialista, ma integrandosi invece il più possibile
al capitalismo globale.
Gli scettici e i critici Non tutti erano soddisfatti dello stato dell'economia mondiale dopo la caduta del comunismo. Mentre gli Stati Uniti vivevano un momento di grande ricchezza, altre economie industrializzate avevano qualche problema. Il Giappone non si era ancora ripreso dalla crisi che la sua economia aveva vissuto all'inizio degli anni Novanta e l'Europa stava ancora soffrendo della «Eurosclerosi», vale a dire del continuo presentarsi di alti tassi di disoccupazione – specialmente tra i giovani – anche durante i momenti di ripresa economica. Anche negli Stati Uniti non tutti condividevano la medesima sensazione di prosperità. I benefici della crescita erano ripartiti in modo ineguale: la disuguaglianza sia della ricchezza sia del reddito aveva raggiunto livelli che non si vedevano dall'epoca del Grande Gatsby e le statistiche ufficiali affermavano che per molti lavoratori i salari reali erano diminuiti. Anche interpretando i numeri con un minimo di logica era piuttosto evidente che i progressi dell'economia americana avevano lasciato almeno 20 o 30 milioni di persone nei gradini più bassi della scala sociale, dopo averli ricacciati all'indietro. Alcune persone si sentivano offese da altre cose ancora. I bassi salari e le misere condizioni di lavoro in industrie che esportavano dai paesi del Terzo Mondo costituivano un frequente pretesto per discorsi d'ordine morale – dopo tutto, secondo gli standard dei paesi industrializzati, quei lavoratori erano certamente dei poveracci, e questi critici non si lasciavano convincere dall'argomento che un cattivo lavoro con un basso stipendio era pur sempre meglio di nessun lavoro. Le persone più sensibili facevano inoltre notare che vaste parti del mondo non erano ancora state toccate dai benefici della globalizzazione: in particolare l'Africa era ancora un continente contraddistinto da livelli di povertà sempre maggiori, da un malessere diffuso e da guerre brutali. E, come sempre, c'era chi vedeva nero. Ma fin dagli anni Trenta c'è sempre stata gente che prediceva una nuova depressione; gli osservatori più razionali hanno imparato a non prendere sul serio questi moniti. Ecco perché gli inquietanti sviluppi determinatisi in America Latina nella prima metà degli anni Novanta – sviluppi che segnalavano effettivamente, adesso lo sappiamo, la possibilità del ritorno a un'economia della depressione - sono stati generalmente ignorati. | << | < | > | >> |Pagina 193La FED perde efficaciaQuando è scoppiata la crisi finanziaria, Alan Greenspan non era più a capo della Federal Reserve. Al suo posto – costretto a far fronte al caos che si era lasciato dietro – c'era Ben Bernanke, un ex professore di economia di Princeton. (Bernanke era il direttore del dipartimento di economia di Princeton prima di trasferirsi alla FED, e mi aveva assunto quando ero passato a Princeton dal MIT.) Dovendo scegliere una persona da mettere a capo della FED durante questa crisi, non c'era candidato migliore di Bernanke. È uno studioso della Grande Depressione. Le sue ricerche sul modo in cui la crisi bancaria intensificò la Depressione lo hanno portato a dare un importante contributo teoretico all'economia monetaria, focalizzato sul ruolo della disponibilità del credito e dei problemi di bilancio alla restrizione degli investimenti (mormorate le parole magiche «Bernanke-Gertler» a un gruppo di economisti che discutono preoccupatamene della crisi, e assentiranno in segno di apprezzamento). Inoltre, Bernanke ha fatto ampie ricerche sui problemi finanziari del Giappone negli anni Novanta. Nessuno era più preparato di lui, dal punto di vista intellettuale, a fronteggiare la drammatica situazione in cui ci troviamo. Ma con l'evolversi della crisi, la FED di Bernanke ha fatto un'enorme fatica a mettere sotto controllo i mercati finanziari o l'economia nel suo complesso. La FED deve fare due cose principali: gestire i tassi di interesse, e quando è necessario, fornire liquidità alle banche. Gestisce i tassi di interesse acquistando buoni del Tesoro dalle banche, e quindi incrementandone le riserve, o vendendo buoni del Tesoro alle banche, e quindi riducendone le riserve. Fornisce liquidità a determinate banche nei momenti di bisogno, prestando loro direttamente dei soldi. E fin dall'inizio della crisi ha usato aggressivamente questi strumenti. La FED ha tagliato il tasso di sconto federale – il tasso overnight a cui le banche si prestano vicendevolmente i fondi, che è il normale strumento della politica monetaria – dal 5,25% alla vigilia della crisi all'1% nel momento in cui scrivo. «Il totale dei prestiti ricevuti dalle istituzioni di deposito da parte della Federai Reserve», un indicatore dei finanziamenti diretti, è passato da poco più di zero prima della crisi, a oltre quattrocento miliardi di dollari. In tempi normali, queste mosse avrebbero portato a una ben maggiore agevolazione del credito. La diminuzione del tasso di sconto si traduce normalmente in una riduzione generalizzata dei tassì di interesse – tassi di interesse più bassi sul credito commerciale, tassi di interesse più bassi sui finanziamenti alle imprese, tassi di interesse più bassi sui mutui immobiliari. E i prestiti alle banche sono stati sempre sufficienti a coprire qualunque carenza di liquidità che si determinasse nel sistema finanziario. Ma questi non sono tempi normali, e i precedenti storici non hanno trovato applicazione. La perdita di efficacia della FED è particolarmente evidente per quanto riguarda i mutuatari più a rischio. Come abbiamo visto, oggi non si fanno più mutui subprime, tagliando fuori dal mercato immobiliare un'intera categoria di potenziali acquirenti. Le aziende che non hanno il rating più elevato in termini di affidabilità pagano tassi di interesse sul credito a breve termine più elevati di quelli che pagavano prima della crisi, anche se i tassi di interesse controllati dalla FED sono diminuiti di oltre quattro punti percentuali. Nel momento in cui scrivo, il tasso di interesse sulle obbligazioni aziendali classificate BAA è superiore al 9%, contro il 6,5% ante-crisi. Di conseguenza, i tassi di interesse che rilevano per le decisioni di spesa e di investimento sono saliti, o perlomeno non sono scesi, nonostante il tentativo della FED di spingerli verso il basso. Ne hanno risentito anche i mutuatari «prime» (quelli che godono di tassi più favorevoli per la loro affidabilità, n.d.t.): il tasso di interesse sui mutui trentennali è ancora più o meno lo stesso dell'estate 2007. Questo perché la crisi del sistema finanziario ha praticamente espulso dal mercato i finanziatori privati, lasciandovi solo Fannie Mae e Freddie Mac, le agenzie sponsorizzate dal governo. E anche Fannie e Freddie si sono trovate in pessime acque: non avevano concesso tanti prestiti insoluti quanto le banche private, ma ne avevano concessi alcuni, e avevano un capitale molto limitato. Nel settembre 2008 il governo federale ha assunto il controllo di Fannie e Freddie, un intervento che avrebbe dovuto ridurre le preoccupazioni per il loro indebitamento e fatto diminuire i tassi di interesse sui mutui. Ma l'amministrazione Bush ha negato recisamente che l'indebitamento di Fannie e Freddie fosse sorretto dalla piena fiducia del governo americano, per cui anche dopo la nazionalizzazione le due agenzie hanno avuto problemi nella raccolta di fondi. Che cosa dire dei prestiti erogati alle banche dalla Federal Reserve? Probabilmente hanno dato una mano, ma non nella misura attesa, perché le banche tradizionali non sono al centro della crisi. Ecco un esempio: se auction-rate securities avessero fatto parte del sistema bancario tradizionale, gli emittenti avrebbero potuto farsi prestare soldi dalla FED quando alle aste si presentavano troppo pochi investitori privati; di conseguenza, le aste non sarebbero fallite e il settore non sarebbe crollato. Ma siccome non facevano parte delle banche convenzionali, le aste sono fallite e il settore è crollato, e non c'erano prestiti della FED alla Citibank o alla Bank of America che potessero mettere fine al processo. La FED sì è trovata così a fronteggiare una crisi di liquidità di tipo giapponese, in cui la politica monetaria convenzionale aveva perso ogni efficacia sull'economia reale. Certo, tasso di sconto non è stato ridotto a zero, ma non c'erano ragioni di pensare che il taglio di un altro punto percentuale avrebbe avuto un impatto significativo. Che cos'altro poteva fare la FED? In uno studio accademico del 2004, Bernanke aveva affermato che la politica monetaria poteva essere efficace, anche in una crisi di liquidità se c'era la volontà di «modificare la composizione dello stato patrimoniale della banca centrale». Invece di limitarsi a tenere in portafoglio buoni del Tesoro e a prestare soldi alle banche tradizionali, la FED poteva concedere prestiti ad altri operatori: banche di investimenti, fondi, e forse anche imprese non finanziarie. E nel 2008 la FED ha istituito una serie di agenzie speciali preposte a questo compito: la TSLF, la PDCF, e così via. Nell'ottobre 2008 la FED ha annunciato la decisione di cominciare ad acquistare anche commercial paper, mettendosi praticamente in condizione di erogare i prestiti che il sistema finanziario privato non voleva o non poteva effettuare. Nel momento in cui scrivo è ancora possibile che questi schemi diano dei frutti. C'è da dire, peraltro, che finora i loro effetti sono stati deludenti. Perché? Io dico che è un problema di sostituzione e di scala. Quando la FED si attiva per incrementare il volume delle riserve bancarie, fa una cosa che nessun'altra istituzione può fare: solo la FED può creare base monetaria, che si può usare come liquidità corrente o tenere di riserva presso le banche. Inoltre, le sue azioni tendono a essere di vasta portata quanto alla dimensione delle categorie di asset coinvolte, perché la base monetaria è di «soli» ottocento miliardi di dollari. Per contro, quando la FED tenta di sostenere più ampiamente il mercato del credito, fa una cosa che fanno anche gli operatori privati – per cui il credito che inietta nel sistema potrebbe essere parzialmente compensato dai ritiri dei privati – e tenta anche di smuovere un mercato molto più vasto: quel mercato del credito che vale circa cinquanta trilioni di dollari. La FED di Bernanke ha avuto anche il problema di trovarsi costantemente a rincorrere gli eventi. La crisi finanziaria continua a sviluppare nuove dimensioni, che pochissimi – inclusi i superesperti della FED – vedono emergere. Il che mi porta ad analizzare la dimensione internazionale della crisi. | << | < | > | >> |Pagina 200Una crisi globaleLa maggior parte di questo capitolo è stata dedicata agli aspetti finanziari della crisi. Che cosa fa presagire tutto questo per la «economia reale», l'economia dei posti di lavoro, dei salari e della produzione? Non fa presagire niente di buono. Gli Stati Uniti, la Gran Bretagna, la Spagna e diversi altri paesi avrebbero probabilmente avuto delle recessioni con l'esplosione della bolla immobiliare anche se il sistema finanziario non fosse andato in crisi. La caduta dei prezzi delle abitazioni ha un effetto negativo diretto sull'occupazione attraverso il rallentamento dell'edilizia, e tende a ridurre i consumi perché i consumatori si sentono più poveri e non possono più accedere ai prestiti ipotecari; questi aspetti negativi hanno un effetto moltiplicatore perché il calo dell'occupazione fa diminuire ulteriormente i consumi. Ciò detto, l'economia americana ha retto abbastanza bene alla crisi immobiliare, soprattutto perché la debolezza del dollaro ha favorito le esportazioni, il che ha contribuito a compensare il rallentamento dell'edilizia. Ma il tracollo finanziario trasformerà certamente quella che poteva essere una recessione «normale» – il tasso di occupazione degli Stati Uniti ha cominciato a diminuire alla fine del 2007, ma fino a settembre del 2008 il declino è stato piuttosto modesto – in qualcosa di molto, molto peggio. L'intensificazione della crisi del credito dopo il fallimento della Lehman Brothers, l'improvvisa crisi che ha colpito i mercati emergenti, il crollo intervenuto nella fiducia dei consumatori quando la dimensione della crisi finanziaria è arrivata sulle prime pagine dei giornali, sembrano indicare tutte quante la peggior recessione mai vista negli Stati Uniti, e in tutto il mondo, dai primi anni Ottanta. E molti economisti si sentirebbero sollevati se restasse entro quei limiti. La cosa che preoccupa di più è l'inefficacia della politica monetaria. La recessione del 1981-1982, che ha spinto il tasso di disoccupazione sopra il 10%, è stata pesantissima; ma era più o meno frutto di una scelta deliberata: la FED perseguiva una politica monetaria molto rigida per disinnescare l'inflazione, e nel momento in cui ha stabilito che l'economia aveva sofferto abbastanza, il suo presidente, Paul Volcker, ha allentato la stretta e l'economia è tornata a correre. La devastazione economica si è trasformata in una «nuova alba» per l'America con una rapidità impressionante. Questa volta, per contro, l'economia ristagna nonostante i ripetuti sforzi messi in atto dalle autorità monetarie per farla ripartire. Questa impotenza della politica monetaria ricorda da vicino ciò che è avvenuto in Giappone negli anni Novanta. Ma ricorda anche le vicende degli anni Trenta. In questo momento non siamo ancora in depressione, e nonostante tutto io non credo che andremo incontro a una depressione (anche se non ne sono del tutto sicuro). Siamo però in presenza di una tipica economia della depressione. | << | < | > | >> |Pagina 203L'economia mondiale non sta vivendo un momento di depressione; e, probabilmente, non è destinata a viverlo nell'immediato futuro. Ma, se la depressione non è tornata, l'economia della depressione – quel particolare tipo di fenomeni che hanno caratterizzato gran parte dell'economia mondiale negli anni Trenta, e che da allora non si erano più fatti vedere – è ricomparsa sulla scena. Cinque anni fa quasi nessuno pensava che le nazioni moderne avrebbero potuto essere costrette a sopportare terribili recessioni per difendersi dalle speculazioni valutarie; che un grande paese industrializzato non sarebbe riuscito a investire abbastanza per mantenere occupati lavoratori e industrie; che anche la Federal Reserve avrebbe messo in discussione la propria abilità di fronte al panico dei mercati finanziari. Abbiamo scoperto che l'economia mondiale è molto meno rassicurante di quanto potessimo immaginare.
Come ha fatto il mondo a diventare un posto così poco
sicuro? Meglio ancora, cosa possiamo fare per renderlo più
sicuro? In questo libro vi ho raccontato molte cose; è arrivato ora il momento
di trarre una conclusione.
Che cosa è l'economia della depressione? Che cosa vuol dire che è ritornata l'economia della depressione? Essenzialmente vuol dire che, per la prima volta da due generazioni, la scarsità della domanda – una spesa privata non sufficiente a sfruttare la capacità produttiva che abbiamo a disposizione – è ormai diventata un chiaro ostacolo al benessere di gran parte del mondo. Noi – e con questo mi riferisco agli economisti, ma anche ai politici e in generale a tutti quelli che hanno un buon livello d'istruzione – non ce l'aspettavamo. Quell'insieme di nozioni che prende il nome di «economia dell'offerta» costituisce una teoria che funziona male, e che avrebbe avuto poco successo se non avesse fatto presa sui preconcetti della gente; ciò nonostante, negli ultimi anni, il pensiero economico si è sempre più spinto a enfatizzare il ruolo dell'offerta, piuttosto che quello della domanda.
Questo fenomeno è in gran parte frutto di dispute teoriche tra gli
economisti, che – come succede spesso – filtrano
gradualmente all'esterno, in forma confusa, ed entrano a
far parte dei discorsi di tutti i giorni. In breve, la radice delle dispute
teoriche è questa: tutte le riduzioni della domanda potrebbero andare a posto da
sole, se solo i salari e i prezzi fossero in grado di adeguarsi all'aumento
della disoccupazione.
|