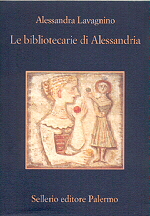
|
|
|
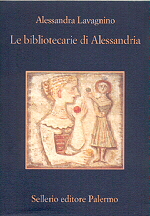
|
|
|
| << | < | > | >> |IndicePremessa 11 Introduzione 13 Prima parte. Concerto italiano I Canterno 19 I Mucciarelli 102 I Fieschi 128 Nozze 160 Amori 202 Seconda parte. La figlia Lontananze 243 La guerra 357 |
| << | < | > | >> |Pagina 11Sono tornata ad Alessandria d'Egitto. È stato un ritorno, pure se era la prima volta. Di Alessandria avevo i ricordi, le immagini, i profumi dei racconti di mia madre, di mia nonna, di mia zia. Di mio nonno no, ché lui non raccontava. Lui leggeva, studiava e conosceva, alla fine, cinquantasei lingue. Diceva: le prime dieci bisogna studiarle, le altre verranno da sé. Stava dietro una scrivania invisibile perché coperta di libri, con alle spalle una muraglia di libri. Sui libri che erano sul tavolo stava, come la Sfinge, il gatto Sinesio. Ho visto il cantiere della nuova grande Biblioteca. La Biblioteca di Alessandria! Voluta dall'Unesco, è nata su progetto di architetti norvegesi. Conterrà, dice la guida, tutti i cinquecentomila titoli di quella antica famosa. Mi chiedo come, e lì non ho trovato alcuno cui domandare. Saranno volumi di carta, o microfilm, dischetti e CD? E le lingue? Ci saranno testi nelle lingue antiche? Come sarebbe possibile, ciò? Chi leggerà l'Aramaico, il Greco antico, le lingue di Persia, il Latino? Oggi nella città del grande Macedone le scritte sono tutte in Arabo, pure se nella parte vecchia alcuni nomi di strade sono rimasti. Così la «Rue des Soeurs» dove erano tanti conventi e collegi per ragazzine; chi passasse lì sotto all'inizio del secolo, sentiva giungere, attraverso le musciarrabyie, voci di cori angelici. Oggi pochi parlano l'inglese, pochissimi il francese o l'italiano, e quanto ai greci - di Grecia o delle isole dell'Egeo - se ci sono non si rivelano. La lingua di tutti è l'Arabo. Né Alessandria è città per turisti e le vestigia dei suoi tempi gloriosi sono scomparse quasi tutte. Ma il Museo Greco-Romano - sorto all'inizio del secolo - lo visitano le scolaresche: ragazzine in gonna o blue jeans, tuttavia col capo fasciato. Allora, quando vivevano lì i miei nonni, gli abitanti della città erano duecentomila. Oggi sono forse otto milioni. Dormono entro palazzi di quindici, venti piani i quali occupano fittamente quaranta chilometri di costa. Ma sulla spiaggia che corre ininterrotta e tranquilla, un pescatore lancia come allora la rete a ventaglio stando lui in acqua fino alla cintola. E prende i pesci: un paio di chili ad ogni lancio. È ancora pescoso, il mare di Alessandria.
Il mio nome è Adriana. Zia Margherita ha adesso più
di novant'anni e sopravvive ai ricordi. Me li regala a
tratti. Loro amica e vicina di casa era allora Stelianì,
greca di Cipro.
Stelianì ciavéa 'na gatta
che si chiamava Flora...
canterellava nonna Antonia.
| << | < | > | >> |Pagina 13«Mi sarebbe piaciuto chiamarmi Margherita. Mamma voleva così; invece papà: non è un nome di famiglia», disse. «Allora, quando scriveremo la tua storia ti chiameremo Margherita, ma nessuno potrà riconoscerti». «Nessuno potrà!... - fa eco. - Sì, questo mi piacerebbe», dice con un grande sorriso sdentato. «Ma io non ho una storia. La mia vita è stata stupida. Proprio stupida. Sarà per questo - ride - che non finisce mai...». Devono essere i betabloccanti, penso. Da quando è dalle monache sta molto meglio. Le danno le medicine e i pasti con regolarità. Sì, sta meglio di quando stava ancora a casa sua, sola. Non fosse stato quell'incidente - mai chiarito - per cui dovetti andare a riprendermela dall'Ospedale di Santo Spirito... Meglio così. Lei qui sopravvive ai ricordi, e alcuni forse li ha cancellati. Non sarò certo io a riproporglieli. Dice: «Io ero la scema di casa, e qualche volta, in fondo, mi faceva pure comodo. Mi dicevano: "È presto, per certe cose". E io ci credetti, che era presto. Proprio scema. Il fatto è che mamma non aveva molta simpatia per me... e neanche per mio fratello. Mi diceva: "se ti facevi monaca era meglio". A tua madre invece papà disse: "tu sarai una gran donna!" e lei ci credette!». Poi: «Però: com'era bella, Alessandria! Peccato!». «Perché non ci sei tornata?». «Nooo!», come un'idea pazza, sconveniente. «E come? Allora mi dissero che saremmo tornati, ma era una bugia. Poi non fu più possibile». Lei stessa non sa perché. Sta nella sua poltroncina e guarda fuori. Non usa più le mani da quando un ictus le menomò l'uso della destra. Adesso stanno meglio, le sue belle mani ancora morbide e bianche, ma non fanno nulla. A lei, pensano le monache. Così Margherita sopravvive alla propria vita. Una vita senza storia, lei dice. Senza figli: questo sì. Una vita che nessun uomo ricorda. Forse un arabo potrebbe ricordare lei, ma dovrebbe avere più di cent'anni... Lei me la racconta, la sua stupida vita, ma penso che davvero molte cose le abbia dimenticate. Né mi parla o mi chiede mai della vita mia, quella che ebbi dopo essermi allontanata da lei. La mia vita «vera». Di questo non parlerò. Così, ogni giorno lo stare anche poco con lei mi trattiene - mi costringe, e ciò mi piace - in un tempo falso, solo di lei e mio nell'oggi; ma anche nel fantasma della mia infanzia: che fu quasi solamente nostra. Stavo sempre con lei, ed eravamo felici.
Solo una volta, anni fa, mi disse: io avevo sempre te
per mano, così credevano che tu fossi mia figlia e non
mi guardava nessuno. Nessuno... Qui si ferma, forse
per non offendere - e che non sia più su questa terra
non ha importanza - colei che invece era guardata, e
come! Ed era bellissima. Sua sorella: mia madre. Perché lei pensa ancora che li
si trovi per la strada, i mariti. Ricorda e ripercorre a mente tutte le strade
di Roma. E quelle di Alessandria.
«... e quando passavo davanti al grande cancello di Villa Torlonia, con il violino sotto braccio perché andavo a lezione, se a quell'ora - e accadeva spesso - ne usciva Mussolini dentro la sua grande automobile nera e lucente, mi salutava con la mano. Perché lui pure era violinista. Ma se non avevo con me il violino, allora non mi salutava. Forse non mi riconosceva. Avrà avuto altro da pensare!». Oppure: «Ecco, casa nostra aveva un balcone come questo, ma un po' più basso sulla strada. Quando passavano i cammelli, guardavano dentro. Io avevo paura di quegli occhi grandi, così seri, e chiudevo la finestra. Hanno certi dentoni, i cammelli! Mettono paura! E mordono, come se mordono! Ne passavano tanti perché in fondo alla strada c'era uno che affittava cammelli,- e si mette a ridere. - Ma gli dava poco da mangiare, povere bestie. Pure loro, soffrono». «E come si chiamava, la vostra strada?».
«Ah, questo non lo so. So dov'è, ci saprei andare, ma il
nome... Forse non aveva nome, o io non lo ricordo. Tanto,
a che sarebbe servito? La posta dall'Italia, la andava a prendere papà alla
stazione. La Stazione del Cairo, che era lì vicino, infossata, e i treni tu li
vedevi da sopra. Abitavamo sotto Moharan Bay e la nostra casa stava, in fila con
le altre, sul Canale Mahmuhdyia. Ma non nella parte elegante, più
alta, del canale, lì dove erano i Giardini Antoniadis... ».
Margherita sa leggere il carattere cirillico e, ad avere l'occasione di parlarlo o leggerlo, ricorderebbe ancora un po' di russo. E il bulgaro. Mi racconta: «La mia maestra, all'Istituto di via Lucrezio Caro, era una bella donna, ma non si adattò mai alla vita italiana. Gli allievi eravamo due: io e un colonnello. Era tanto una brava persona, il colonnello, ma quello pure me l'hanno soffiato... Quando facemmo l'esame per il diploma, la maestra ci mise lontani fra noi, perché non potessimo copiare. Portava sempre un fiocco in testa, fiocchi colorati, che allora non si usava... Così per la strada si voltavano tutti...». Margherita parlava bene l'arabo, e il greco: le lingue della sua infanzia. Oltre, naturalmente, l'italiano di casa ed il francese dei frati francescani della grande chiesa di Santa Caterina. Il frate confessore si chiamava Père Quilici - pron.: chilisì - e lei confessava a lui, tutti i sabati, i peccati di una bambina. Poi, quando avevo quattordici anni, tornammo in Italia. La guerra era finita e mio fratello era tornato. Con mezzo cranio rifatto, ma vivo. E tua madre doveva andare all'università. Era il 1920. Per prima cosa andammo a rivedere i parenti di Alatri e di Fumone. Ma tu te lo ricordi, Fumone? | << | < | > | >> |Pagina 19Ciociaria, Italia, 1870 Arroccato in cima a un monte, Fumone era - ed è - il più piccolo paese di Ciociaria. Fra le case abbracciate fra loro e fitte come gli acini d'un grappolo d'autunno, le stradine fanno gradino di ogni rilievo di roccia. Sopra sta inaccessibile la Rocca, e lì dentro, avendo con sé due libri solamente, morì prigioniero e santo Pietro da Morone, colui ch'era stato il papa angelico Celestino V. Ma seicento anni dopo chi ci pensava più? Delle antiche mura di Fumone la porta medievale è tanto stretta che a malapena ne passa un somaro con sopra l'uomo e qualche fascina: quei begli asini marrone di muso e pancia bianchi, di grandi orecchi e fianchi generosi. In groppa a un animale così era giunta da Alatri la levatrice e dentro il grovigliato paese s'era lasciata guidare dai gridi della partoriente. Quando fu alla casa lavorò pochi minuti poi, nel silenzio dopo l'urlo più alto e lungo della donna, con voce che suonò di conferma disse: «maschio!». Il padre Canterno Giacomo e nonna Erminia - questa un attimo appena - mandarono occhi e mani al cielo ringraziando; né in quei momenti pensarono altro. La mammana finì il suo lavoro, poi si lavò le mani. Mezz'ora più tardi la piccola Erminia, guardato che ebbe con serietà il fratellino - gli occhi neri nascosti fra boccoli rossi - ruppe in gran pianto e corse via. I suoi piedini scalzi suonarono umidi sui mattoni appena lavati ma già macchiati di sole vaporante: erano le dieci di una mattina calda, pure se si era già al venti di settembre. In quei momenti stessi veniva fatto un buco, da fuori, nel muro della città del papa. Al vedere la bimba scappare via a quel modo, «e mò che tiene 'sta uttra?» disse la nonna, però in domanda subito smemorata, ché a quel tempo il pianto di una bambina non dava pensiero. Entrati a Roma i bersaglieri, nonna Erminia a Fumone prese a battere con la forchetta dentro una terrina acqua e olio per darne l'emulsione al neonato, poiché così va fatto onde liberare le tenere viscere da «tutta quella robaccia nera che c'è dentro». Nella mamma che intanto s'era addormita, la febbre puerperale saliva. Il piccolo fu battezzato Tommaso come il nonno compianto e crebbe bene, pure senza la mamma. Nei giochi seguiva la sorella, ma non aveva i suoi capelli rossi. Lei gli diceva: «vie', lassali perde quelli, vie' co' me!». E Tommaso li lasciò perdere, suo padre e nonna Erminia, quando vollero obbedienza e vederlo occuparsi di vigne e foraggi, di ben vendere il vino e scegliere nuove terre a comperare: poiché i quattrini c'erano ed era dovere suo, dopo che l'unico cugino maschio, Michele, s'era fatto prete. Ma a tredici anni pure Tommaso stava sempre ad Alatri «appresso ai preti», leggeva libri e studiava. Così ancora a diciotto: però non per farsi avvocato - di questo suo padre si sarebbe contentato - e manco prete (la nonna ne sarebbe stata orgogliosa) ma solo perché studiare gli piaceva. Volevano di ciò si vergognasse; Tommaso si fece più timido e silenzioso. La sorella si faceva più bella. E venne il giorno di primavera - si era al 1888 - che sei muli scesero in fila da Fumone per la strada di Alatri dondolando sui fianchi le casse del corredo. Dietro, su un asinello bianco, maestosa seguiva Erminia, bellissima sposa di un ricco possidente. L'anno appresso Tommaso si innamorò: però di una signora, e allora volle uccidersi. Maldestramente si ferì, poi si trovò guarito, anche se «non di testa» dissero i suoi, e quando poté di nuovo reggersi in piedi, volle mettersi davanti a padre, nonna e sorella, poi fece un lungo e incomprensibile discorso che conteneva un'idea nuova a Fumone, e pazza: l'essere latrocinio o poco meno il possedere terre, pascoli e vigne. E concluse: «non voglio niente, solo che mi lasciate in pace. Quanto mi spetta lo regalo ad Erminia e Giovanni. Ne facciano ciò che vogliono. Voglio solo quanto mi serve per studiare». Giovanni era il cognato. Tommaso compiva allora ventun anni. Si fece dare un poco di bajocchi e su un carretto, assieme a poche cose andò giù per la Casilina fino a Roma. Conosceva Fumone grumoso e stretto nella nebbia, conosceva Alatri orgogliosa dentro le nere mura di venticinque secoli: Roma gli apparve grande, alluciata, polverosa e dispersa. Ma dentro la mente sua c'era uno scopo solo: trovatala, si iscrisse all'Università, che si chiamava allora La Sapienza. | << | < | > | >> |Pagina 50La «nota salata». Alessandria, 1911Quando Marta ebbe dieci anni e Margherita ne aveva cinque, ritornò Giacomo. Compiuto ad Alatri il ginnasio, il liceo lo avrebbe seguito ad Alessandria: così voleva il padre. Giacomo aveva sedici anni, era un uomo. Portò in casa la gioia, la musica, una nuova inimmaginata aura di idealità. Lui solo sapeva fabbricare i cervi volanti che rimanevano alti sopra Alessandria fino al rosso tramonto ed oltre, retti dal filo di una intera matassa di cotone! L'archetto del violino di Giacomo strideva a volte, ma quasi sempre traeva melodie e lunghi accordi arpeggiati! Con il volto colorito e pienotto poggiato sulle mani, Martina ascoltava estasiata. «Sembri un angioletto di Raffaello» Giacomo le diceva, e lei era felice pure se non capiva, e proprio anche per questo. Adorava il fratello, lo avrebbe seguito ovunque egli avesse permesso.
E Giacomo la condusse all'opera, all'Aida, «l'Aida
al posto giusto» dicendo, e lei neppure poteva capire,
poiché era digiuna di ogni cognizione, ma quello per
lei fu «lo spettacolo più bello della vita». Giacomo suonava Bach e Beethoven, e
le diceva: «ascolta, ascoltali, i Profeti. Sono questi, i Profeti, più grandi
assai di quelli della Bibbia».
E quando Giacomo le porse un foglio di musica, vedendo quei segni neri con la coda e riconoscendovi una sequenza che lui intanto accennava sulle corde, Marta cantò la melodia.
«Lo vedi? lo vedi che sai leggere la musica, lo vedi?».
E scostandosi i morbidi riccioli dagli occhi, Giacomo
parlò al padre di Marta che compiuti dieci anni pareva di tredici. Gli disse:
«Perché non la mandi a scuola? Perché la fate crescere come una bestiolina? Non
è giusto, non è giusto per lei».
Quel «come una bestiolina» era un modo di esprimersi da preti - preti italiani - ma era pur efficace e calzante. Il padre tacque ed uscì, solo, per via. Tornato a casa, senza preambolo disse alla moglie: «Domani Marta andrà a scuola». «Elhandulillàh!» esclamò Antonia, e stirò a Marta la camicetta nuova. Fu una grande emozione. A scuola con le compagne e il compagno - uno soltanto - i professori, la lavagna grandissima e «finalmente poter imparare!». Alta fra le altre ragazzine lei si sentì allora, e per sempre, non Martina ma Marta. Era in prima ginnasiale non essendo mai stata in un'aula scolastica, pure se sapeva leggere e scrivere il greco e l'italiano.
L'indomani il padre la chiamò, e le consegnò un librone. Era il Georges, il
grande vocabolario Latino. E le disse: «Questo è il più prezioso e sacro di
tutti i libri. È tuo. Abbine cura. Ti insegnerò io ad usarlo; ma poi, ricordalo,
non mi chiederai più nulla: perché nel vocabolario c'è tutto».
Marta era felice. Andare a scuola! Solo, le dispiaceva perdere ore della compagnia di Giacomo. Ed imparò la competizione con le compagne mentre l'unico ragazzo, che si chiamava «nientemeno» Leone, «faceva pena». Ebbe nuove amiche, le quali avevano casa e genitori in luoghi altri della città, in vie che lei non conosceva. Pensava che le compagne vivessero una vita diversa dalla sua, diversa da quella delle figlie di Stelianì e di Settemunìra. Ed era vero. Marta fu brava a scuola - non subito - ma non perché il padre la favorisse in classe o la aiutasse in casa, ché «c'è il vocabolario», rispondeva ad ogni sua domanda. Né lo studiare in casa era per lei proibito e furtivo meno di prima. «Non ti devi stancare. Va' a giocare». Ma la sera Marta vedeva ora con occhio diverso suo padre lavorare per la scuola, preparare le lezioni, e poi scrivere, sopra singoli fogli, i testi delle versioni che avrebbe assegnato l'indomani: uno per ogni allievo delle sue cinque classi; e se commetteva nella sua minuta scrittura un errore, il professor Canterno senza esitare appallottolava quel foglio e lo gettava via: unico spreco di carta che le figlie gli avrebbero mai veduto fare.
Aveva compiuto quarant'anni, e più maestosa s'era
fatta la sua figura e quella lunga molleggiata andatura
con le mani dietro la schiena che reggevano un libro.
Ora che a scuola andavano assieme, in quelle lunghe
passeggiate nacque fra padre e figlia un rapporto nuovo, ma neppur esso agevole.
Lei avrebbe voluto dirgli:
«leggi se vuoi», ma non ardiva, mentre quei silenzi la
riportavano al pensiero dei pur rari e pacati ma quasi
sempre inattesi, terrificanti rimproveri spesso incomprensibili e talora
immeritati, che egli le aveva sempre
fatti solamente per via. Le grandi furie di lui esplodevano invece in casa,
specie di notte e nella stanza nuziale. Terribili, lasciavano sbattuta e
silenziosa Antonia per tutto l'indomani, ché di certo non aveva dormito tutta
notte ed avea pianto. Ma il giorno appresso - le figlie lo notarono - tutto
tornava sereno, e più di prima.
Durante una di quelle camminate con la figlia, Tommaso Canterno vide sulle mura del Forte di Napoleone una grande scritta: MARTINA VUOLE UN PIANOFORTE. La vide e non allentò la sua andatura da cammello. Soltanto: «dove lo hai preso il gesso?» disse. «L'hai forse rubato a scuola?» né altre parole. Marta, che il gesso a casa lo aveva sempre avuto perché senza saperlo era proprio il padre a «rubarlo» per lei, dapprima disse no, poi «sì», perché si andasse spediti verso il rimprovero; che però stavolta non venne. Quella scritta sul muro risaliva ad alcuni mesi prima, e lei da tempo aveva allentato l'attesa angosciosa della reazione di lui. Ne passarono altri due, di mesi, prima che il padre le dicesse di nuovo «vèstiti ché usciamo». Andarono insieme senza parlare per il grande Suk El Attarìn, fino al negozio degli strumenti musicali, e lì Marta vide suo padre comperare un libro, un grande libro dalla copertina verde pallido, ed erano le «Sonaten für Pianoforte solo» di Beethoven, Edizione Peters: tutte. Il libro era nuovo: cosa rara per un acquisto di lui. Marta si fece scarlatta, e non parlò. Sulla via del ritorno il padre disse: «Così fece quell'uomo che comperò prima la frusta e poi il cavallo. Il pianoforte lo avrai più in là». Allora Marta gli buttò le braccia al collo e lo baciò, vicino quegli occhi che egli aveva ridenti e dolcissimi. | << | < | > | >> |Pagina 102Ascoli Piceno, 1870 «Quando Peppina compie quindici anni do una festa da ballo» diceva nonna Caterina, e la promessa pareva una minaccia. La Marchesa Mucciarelli «ma nata Malaspina» andava avanti e indietro pel salotto verdone del suo palazzo in Ascoli Piceno. Ad ogni tornata l'ampia gonna di taffetas frusciava due volte: per il colpo imperioso della sinistra inanellata e perché toccava - poi ondeggiando - le alte e rigide poltrone. Nella destra, nonna Caterina teneva il toscano. «Mi aiuta a digerire e a pensare», diceva, «e fra digerire e pensare non c'è gran differenza». La Marchesa Malaspina le sue sentenze le pronunciava tutti i giorni senza preoccupazione di ripetersi, che un uditorio la ascoltasse o no. Passeggiava per il salotto ogni dopopranzo; ma le giornate belle di primavera e quelle estive, pel grande loggiato che copre l'intera lunghezza del Palazzo Malaspina che tre secoli prima era stato un fortino entro la città: ché sanguinari e guerrieri erano i tempi quando fu costruito, guerriera la famiglia Malaspina. Ma se l'architetto suo, Cola dell'Amatrice, cui dobbiamo i maggiori edifici dell'Ascoli cinquecentesca, aveva dato al palazzo aspetto inospitale - tale doveva essere ai nemici -, per coloro che lo avrebbero abitato aveva voluto un luogo arieggiato ed alto da cui poter spaziare la vista sopra tutta Ascoli, la città dalle Cento Torri, e la campagna. Un luogo che offrisse quasi un cielo di bosco: ed i pilastri degli archi li aveva fatti in forma e sagoma di tronchi ramosi. Fra essi, d'estate la servitù tendeva cortinaggi a schermo del troppo sole, e la lunga terrazza diventava come un altro salone mosso d'ombre ed un giardino di piante fiorite. «Poi, quando sarò vecchia mi metterete in poltrona» diceva l'ottantenne marchesa Caterina. Ma una poltrona, una poltrona comoda in cui la si sarebbe potuta porre quel giorno di certo lontano, nel suo palazzo l'ultima Malaspina non l'aveva. Dalla parte interna, nel giardino ombreggiato dal bel sicomoro, nelle loggette allietate da rampicanti fioriti, dai giochi delle bambine e il correre dei cani, il palazzo aveva un'aria gentile. Né la vita delle due sorelle orfane di madre era triste. Peppina e Matilde giocavano a rincorrersi, a nascondersi e cercarsi, loro due con i cani. I cani di nonna Caterina erano quattro e mangiavano in sala da pranzo con lei, ciascuno avendo a terra la tovaglietta ed il piattino suo. «Meglio i cani che i figli, - diceva la Marchesa - i cani almeno mi tèrticano la coda!». Così quegli anni che Peppina, nata nelle Marche ancora Stato Pontificio, era un'adolescente magra e Matildina una bambina ancora. Esse non capivano nè cercavano il significato delle parole della gran signora loro nonna. I figli di lei? Uno era il loro papà, il marchese Alessandro, l'altro uno zio Gustavo mai conosciuto che «stava a Parigi», e quel nome altro non era per loro che una parola pronunciata con sprezzo; come se la nonna marchesa dicesse «sta a mollo». «Perché non c'è più il papa!» era la spiegazione d'ogni stortura: quelle fatte dai figli, o che un cavallo morisse, che un mattone del pavimento si staccasse, che la gelata bruciasse il raccolto. «Il Papa non c'è più...» spiegava, e pareva lo avesse avuto sempre accanto e a sua disposizione, prima. Serena, nonna Caterina forse non lo era stata mai per suo temperamento. Di certo non lo era da quando un intruso di nome Garibaldi era venuto, già nel 1849, «a sommuovere le teste vuote dei miei concittadini»: e questo dopo duecent'anni e più di comodo e tranquillo governo papale e di prosperità dei Malaspina. Che quella prosperità fosse seguita al perdono - papale appunto - di non lievi colpe dei suoi antenati, quella discendente non conservava nella memoria. Quanto al marchese Alessandro, stava di rado in Ascoli con le figliole e il più del tempo lo trascorreva «a sistemar Ferrara», ossia la casa e le faccende sue dopo la morte della moglie. Poiché la marchesa Eleonora «pover'anima» era volata in cielo di appena trent'anni: che Peppina ne compiva otto, Matilde cinque e Carlo tre soltanto. «Eh, povero papà vostro!» sospirava la nonna marchesa quando pensasse alla vedovanza del figlio; o ad altro, forse.
E poi: «vedremo Carlo», diceva, sperando in quell'unico marchesino che
cresceva a Ferrara, con la mite già canuta nonna materna Emilia, contessa
Agnelli. Sui vasti pavimenti del Palazzo Agnelli Carlino scorrazzava ancora in
sottanella lunga. «Carlo sta bene con Emilia. Emilia è buona», spiegava nonna
Caterina, incapace di dimenticare o tacere un giudizio. E poiché amava
raccontare «i fatti di famiglia», le due ragazze appresero dalla voce della
vecchia Marchesa ascolana le storie dei primi Malaspina, quelli toscani, i
quali - di Spino Secco o di Spino Fiorito - avevano posseduto per secoli terre e
castelli, «ma gratta gratta, in fondo eran tutti predoni».
|