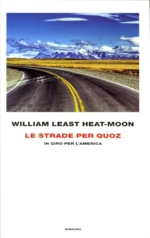
|
|
|
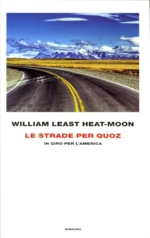
|
|
|
| << | < | > | >> |Indice
3 A mo' di spiegazione
Parte prima Lungo un'antica valle
7 Prima che tutto l'incanto finisca
9 I. La lettera Q incarnata
17 II. La storia di Mrs Weatherford
25 III. Fiumi e tessere del domino
31 IV. Il piede vagabondo
35 V. Un'asse da bucato planetaria
40 VI. Incidere la terra
50 VII. La spedizione dimenticata
60 VIII. Separé con alte paratie
65 IX. Gli occhiali di Dunbar
71 X. Una femme fatale di quindici metri
77 XI. Architetto di fantasmagorie
85 XII. La Donna Capra di Smackover Creek
93 XIII. L'uccello fantasma
102 XIV. Quando le pupille mettono papille
107 XV. Fotografare ogni chilometro
115 XVI. Il ronzio sotto il nido del calabrone
124 XVII. Connessioni e continuità
131 XVIII. Storia di una tomba
141 XIX. Estrarre raggi di sole dai cetrioli
146 XX. Una palla di cannone dritta in salotto
Parte seconda Inoltrandoci nel Sudest
153 Facendo quello che non avrebbero dovuto fare
155 I. Un quoz di convivia
16o II. La Laguna Nera
167 III. Frecce che volano di giorno
173 IV. Il torrente dell'Uomo Morto
18o V. Strada verso il nulla
184 VI. Balle di muggini quadrati
188 VII. Un assaggio di lamantino
193 VIII. Parco giochi dei ricchi e famosi
196 IX. Nel proprio sudore
202 X. La verità su Bobbie Cheryl
Parte terza Nel Sudovest
205 Su un anello di luce
207 I. Apologia del compagno lettore
212 II. Quel branco giú, là dietro Otis
219 III. Alla luce degli spettri
225 IV. Una storia poetica di Satana
236 V. Gladiatore senza spada
244 VI. Dio aiuti la giuria
251 VII. Un triangolo diventa un poligono
256 VIII. Anche da morto, parla
264 IX. La danza dei fornelli
272 X. Come i girini divennero serpenti
278 XI. Ultimo treno dalla fine del mondo
285 XII. Alla ricerca del querque
291 XIII. Dieci metri quadri
301 XIV. Quando esplode la miccia
Parte quarta Nel Nordest
311 Sull'automobilismo
313 I. Nella speranza che il lettore eterno non se la svigni
318 II. Issando Jack
327 III. Bop spontaneo
334 IV. Dieci M a B
340 V. Costruire una macchina del tempo
348 VI. Alla ricerca della Kaiser Billy Road
357 VII. Un trasgressore rifiuta di fare una vittima
367 VIII. Quaranta pagine contro una palla da demolizione
375 IX. Non piú di un paio di scheletri
385 X. Quello che sussurrò il corvo
Parte quinta Nel Nordovest
399 «Che nessuno possa a vostra vergogna affermare
che tutto era bello qui prima del vostro arrivare»
401 I. Laggiú oltre Last Chance
409 II. L'uomo della vedova
418 III. Come Max oliò i cardini
428 IV. Querencia
436 V. Quel che gracchiò la gazza ladra
441 VI. Una bicicletta intelligente
453 VII. Ferrovia sui trampoli
465 VIII. La torta del tipografo
Parte sesta Lungo un antico corso d'acqua
477 Sulla spiaggia
479 I. Seguendo la linea magenta
483 II. Al margine temporaneo dell'America
487 III. Dove non vola l'avvoltoio collorosso
495 IV. Lui è noi
502 V. Il dono di visioni diverse
507 VI. Hardtails e alberi motore
510 VII. Autentica povertà in vendita
516 VIII. Ob De Goole-Bug
521 IX. Le ostriche di Folly Creek
524 X. Appuntamento con la signorina Flossie
529 XI. Fanny Kemble parla
533 XII. Girate a sinistra alla cinghia della ventola
Addii
539 Un'infinità di forme diverse
541 Dal Nuovo quozinario della lingua italiana
542 Un quarto di migliaio di quozo-neologismi
544 Ringraziamenti
545 Nota bibliografica
547 Indice dei luoghi
|
| << | < | > | >> |Pagina 7Prima che tutto l'incanto finiscaAlexandria, Louisiana, 21 aprile 1835 Caro signore, certo ricorderete che la scorsa estate a Philadelphia mi faceste promettere di andare a vedere la Maison Rouge Grant sull'Ouachita. Come noterete, adotto la sana vecchia ortografia francese di quel fiume. Non so se il vostro proposito fosse quello di farmi piacere oppure di infliggermi un salutare castigo. Nel caso si trattasse di quest'ultima possibilità, se vorrete prendervi il disturbo di leggere quanto ho scritto, avrò la mia rivalsa. In ogni caso, non posso non credere che, a suscitare il vostro gesto, sia stato un generoso desiderio di concedermi in qualche modo un privilegio. E ora sono qui a scrivervi per fornirvi un abbozzo del mio modo di realizzare tale promessa. La prendo per le lunghe e lo faccio in tutta tranquillità, perché son ben consapevole che non potrà che interessarvi leggere compendi, per quanto inadeguati, di una regione cosí vasta, cosí fertile, che si identifica cosí completamente con il vostro nome in quanto suo proprietario, e nelle cui paludi alluvionali, ai vostri tempi, anche voi vi siete tuffato. L'Ouachita è un bel fiume, dal carattere e dalle potenzialità interessanti; e, sebbene ignoto alle canzoni, è un classico nei racconti popolari e nella tradizione boschiva per essere stato l'ambientazione degli esperimenti pastorali del marchese Maison Rouge e del barone De Bastrop, come pure di molti altri avventurieri, spagnoli, francesi e americani, per non parlare del suo legame con la storia americana in quanto luogo in cui Aaron Burr mimetizzò i suoi estremi progetti di ambizione e di conquista. Desidero afferrare la sua attuale freschezza e le sue principali attrattive boschive, prima che tutto l'incanto finisca quando verrà trasformato in un ufficio contabilità, in terreno per la floricoltura o in una piantagione di cotone. Spero addirittura che questo abbozzo risveglierà piacevoli reminiscenze dei vostri stessi esaurienti viaggi e degli incidenti emozionanti avvenuti in queste remote foreste centrali. Potrete, dunque, battezzare questo preludio al mio viaggio sull'Ouachita come una prefazione o un'apologia, a vostra scelta. Diario del rev. Timothy Flint, Dal Red River all'Ouachita o Washita, in Louisiana, 1835 | << | < | > | >> |Pagina 9Capitolo primo
La lettera Q incarnata
Un viaggiatore, invecchiando, accumula sulle spalle sempre piú viaggi, specialmente quando attraversa il terreno del ricordo in cui si diventa pellegrini del tempo oltre che dello spazio, un luogo dove i paesaggi fisici si fondono con quelli temporali. Percorriamo una strada, entriamo in una città, passiamo davanti a un caffè o a un hotel, e magari sentiamo storie e ricordi che si risvegliano. Allora si fa avanti il nostro passato, cui sono spuntati i piedi: Là, l'ho conosciuta là. Oppure, Ecco dov'è, è qui che lui mi ha raccontato dell'incidente. Dal momento che ogni giornata vissuta viene sottratta al totale che ci è stato assegnato, le reminiscenze possono costituire la nostra piú alta ricompensa: vivere un solo istante un gran numero di volte. Quanto a me, che sono ormai diventato un veterano della strada, questo risvegliarsi dei ricordi grazie a una topografia specifica mi porta vicino a credere che tutti i chilometri precedenti siano stati macinati allo scopo di creare un unico istante, e da li a capire che il significato ha origine e fondamento nella memoria. I bambini che sanno solo annoiarsi sul sedile posteriore della macchina, dietro ai finestrini - se pure stanno guardando fuori - gettano comunque le basi per la nascita di un senso, un giorno, quando avranno bisogno di significato molto piú che di esperienza. I miei occasionali racconti a Q, evocati talvolta da qualche paesaggio particolare, servono a due cose: riempire un tratto dei chilometri che scorrono lenti e, allo stesso tempo, puntellare la mia memoria. Credo che di tanto in tanto non le dispiacciano le mie digressioni, forse perché in una «precedente amministrazione» (un primo matrimonio) una volta attraversò il Kansas in tutta la sua lunghezza senza spiccicare una parola... a meno che non si consideri conversazione quell'intercalare dell'ex marito: «Dobbiamo fermarci a fare benzina». Q è mia moglie Jo Ann, un nome nei confronti del quale non ha mai sentito alcuna affinità. In realtà, con i nomi non ha avuto fortuna, neanche nella sua chiesa. Quando arrivò il momento di scegliere un nome per la cresima, la sorella maggiore convinse Jo Ann, che allora aveva sei anni, che tutti i nomi delle sante erano già stati presi tranne uno: Dorothy. Il nome, legato al coraggio dell'eroina del Mago di Oz che tanto ammirava, può aver contribuito a farle credere di poter volare sempre che la sua fede fosse abbastanza salda: si mise a cavalcioni di una scopa da cucina, con il suo gatto di pezza assicurato alle setole, e si buttò dall'alto delle scale del seminterrato. Non si ruppe neanche un osso, e se cadere lungo una traiettoria solo vagamente orizzontale può essere considerato volare, allora volò. Ma non fece piú alcun affidamento su una fede non troppo convinta. Mentre Jo Ann cresceva, diventando Jan (il suo atteggiamento da maschiaccio avrebbe potuto anche giustificare il nome di Joe), imparò lo spagnolo, fece un viaggio in Messico e sviluppò una fascinazione per un posto nello Yucatan che prendeva il nome da un eroe messicano rivoluzionario, e tanto meglio se era maschio: Quintana Roo. Quintana Roo - lo stato, non l'uomo - è la terra del quetzal, il serpente piumato sacro agli indigeni Maya (soprattutto ai Quiché), e forse l'uccello piú incredibile di tutto l'emisfero occidentale a nord dell'equatore: per lei è una creatura dal richiamo irresistibile. Non molto tempo dopo il nostro incontro, mi disse che adorava le cose che cominciano con la lettera Q: una rivelazione che una sera a cena in un ristorante fece suonare un campanello dentro di me, che avevo sempre amato la diciassettesima lettera per la sua rarità (solo sette pagine nel mio dizionario da tavolo, mentre la vicina P ne ha centoventi). Mi piace pensare che la sinuosa Q (solo la O vanta una maggiore purezza geometrica) compensi l'esiguità di voci con le particolarità di significati, con la forma pittografica della lettera maiuscola (un serpente arrotolato che spunta dalla tana, una mongolfiera impastoiata sospesa nell'aria, un pulcino con una zampetta fuori dall'uovo) e con il suo legame inossidabile con l'adorata U. Ancor piú importanti, sono quelle parole bizzarre che non esisterebbero se non ci fosse la Q: quark, quacchero, quadrilione, quantistico, quiddità, quad, qualunquista, quintessenza, quilt, quadrumviro, quaglia, quinconce, e la non-parola piú universale del pianeta: QWERTY. E come non citare quel recondito giorno di festa cristiano, la Quinquagesima, la domenica che precede la Pasqua di cinquanta giorni? Esiste un'altra lettera con la stessa percentuale di parole gioconde e curiose, che cosí numerose hanno a che fare con questue, questioni e quintessenze? Non è una lettera particolarmente q-riosa? Come può un seguace del quadrivio non amare la lettera Q? Come può un difensore dei diseredati non amare una lettera che è la meno usata sulla tastiera, quella che non diventa mai lucida per l'uso? Eppure la Q, alfabeticamente superflua, ha i suoi tranelli: quanto alla lingua, c'è quaglia e quegli; quanto al significato, c'è quiescenza e quietanza; e c'è quadrare (ridurre in forma quadrata) e quadrare (soddisfare), quagliare (far cagliare) e quagliare (ottenere un risultato). E per infittirne il mistero, la Q ha il suo lato oscuro, ovvero parole che turbano la quiete: quartana, quassazione, quarantena, querela, questura, querulo, quartigliere, quatto, querimonia, quarantottesco, quaqquaraquà, quattrocchi. » una lettera che ha subito una privazione, impoverendo il linguaggio mentre noi eravamo tutti presi a mettere i puntini sulle i trascurando le q; se Shakespeare le aveva, quelle parole perdute, perché noi non le abbiamo piú? Ecco un quorum di esempi di quśstio (vexata o meno) maturi per un revival, pronti per soddisfare voi querenti: qualmente (come), qualsia (qualsiasi), quartierare (stabilirsi), quassare (scuotere), quattrinaio (avido), quereloso (lamentoso), quiescente (dormiente), quitare (saldare). E poi c'è il comodo quisquiglia: nel suo senso piú arcaico (ed etimologico) significa impurità, nell'altro indica le minuzie, le cose di poco conto di una vita o di un libro.
Già vedo la lettera che uno di voi mi scriverà:
Caro Signor Autore Stravagante,
vorrei quassare le sue quiescenze su qualsiasi peculiarità
della lettera Q perché esse non quagliano e mi lasciano qualmente
insoddisfatto e pieno di querimonia. Quiti le pendenze e continui
a quartierarsi sulla sua strada per le quisquiglie di Quoz.
Il suo quereloso,
Acuto de' Lettoris
Perciò questo ci porta a quoz: un sostantivo, sia singolare che plurale, che si riferisce a una qualsiasi cosa strana, assurda, o particolare; contiene in sé l'incognito, il mistero. Fa rima con Oz. Per un viaggiatore, è spesso il quesito piú alto. Per me, tutto - che sia oggetto, persona, o evento - se visto chiaramente nelle profondità della sua esistenza, nella sua quiddità, è quoz. Ogni strada, ogni vicolo, l'ingresso del vostro salotto, il corso di un torrente, la traiettoria di una cometa, costituiscono tutti un itinerario diretto al quoz per ogni viaggiatore, per ogni questuante intenzionato a questionare, a fare la questua, ad affrontare la questione cosmica delle sacre rappresentazioni della Chiesa medioevale: Quem quśritis? Chi cercate, o pellegrini? Perdonami, lettore dal pronto ingegno, se questo quodlibet verso la Q ti ha reso querulo; lascerò stare la lettera e tornerò a Q, la donna, dopo averti gravato con un'ultima nozione. Il vocabolario della nostra lingua è un'abbondante - e spesso inutilizzata - miniera di concetti racchiusi ordinatamente in pochi scarabocchi di inchiostro o in una colonna d'aria fatta vibrare dalle corde vocali. Non riuscire a coprire e di conseguenza a onorare un ricco vocabolario è un sacrilegio perorato da coloro che vorrebbero ridurre l'estensione del nostro lessico a misura del loro limitato modo di esprimersi; si tratta spesso di novizi e uomini di fatica e di certi recensori di libri che dovrebbero essere confinati alla stesura delle istruzioni per l'installazione di uno scaldabagno. Un autentico road-book dovrebbe aprire mondi sconosciuti tramite le sue parole quanto nei chilometri che percorre. Se alla fine di un viaggio sei esattamente la stessa persona che eri prima della partenza, il viaggio è stato perfettamente inutile, anche se sei andato solo al supermercato. | << | < | > | >> |Pagina 40Capitolo sesto
Incidere la terra
Per i toponimi dell'Arkansas c'è un certo apprezzamento nazionale - prevalentemente Hope (Speranza), Flippin (Dannato), Yellville (Città degli strilli) e Smackover (Schiaffone) ó ma i profani non hanno fatto particolarmente attenzione ad altri nomi ancora piú degni di eccentrica distinzione: Greasy Corner (Angolo unto), Chanticleer (Gallo), Figure Five (Figura cinque), Number Nine (Numero nove), Whisp (Ciocca), Twist (Svolta), Wild Cherry (Ciliegia selvatica), Possum Grape (Uva dell'opossum), Oil Trough (Tinozza d'olio), Seaton Dump (Discarica di Seaton, ma suona anche come «siediti su una cacata»). In uno stato dove abbondano le contee alcolicamente «asciutte», c'è Beverage Town (Città delle bevande) e Gin City (Città del gin), e nessuno dei due nomi si riferisce a bevande alcoliche. Dato che la mascotte dell'università dello stato è un cinghiale, non vi stupirà trovarci Hogeye (Occhio di porco) e Hog Jaw (Ganascia di porco), comunità che (come suggerisce il nome) a quanto pare sono prive di una camera di commercio. Altrove, come potete immaginare, la burla proverrà da una certa concatenazione di città lungo un versante settentrionale degli Ouachita, tra Needmore (Dammidipiú) e Blue Ball (Palla blu), vicino a Nella e Nola, con Harvey sdraiato tra di loro (tutti a sud di Kingdoodle Knob, Punta del pisellino del re). Sulla sua carta stradale ufficiale, la Società Autostrade dell'Arkansas mostra quasi mille e cinquecento «città, cittadine, e comunità», e su quella lista, Ouachita spicca perché è uno dei pochi nomi indiani in un posto con una presenza umana che risale a migliaia di anni prima dell'arrivo dei McDougal, dei Delaney, e dei Ludwig. L'indice di un dizionario geografico dell'Arkansas non rivela città chiamate Quapaw (da cui probabilmente discende il nome Arkansas) o Tula o Tunica. Per i fondatori dello stato, sembra che quelle popolazioni non siano mai esistite. Il fiume Ouachita contribuí a tale oblio, quando i battelli a vapore carichi di centinaia di nativi di varie tribú americane risalirono il fiume fin dove una nave era in grado di giungere e li sbarcarono perché seguissero le valli in direzione ovest all'interno del «Territorio indiano permanente». Questa è una storia non di piedi vagabondi ma del trasferimento forzato proposto da Andrew Jackson (anche Jefferson e Monroe lo avevano preso in considerazione) e approvato dal Congresso con l'Indian Removal Act del 1830. I Quapaw non si spinsero piú a ovest di quanto richiesto e si sistemarono sul confine dell'Arkansas, nell'angolo nordorientale del Territorio Indiano, su una terra dotata di risorse minerarie sconosciute che alla fine fruttarono loro una notevole ricchezza. Mentre Q e io seguivamo la discesa dello Ouachita allontanandoci dalla montagna dalla quale sgorga, entrammo in una valle abbastanza aperta da spingere i propri crinali verso l'orizzonte. In certi punti gli alberi che crescevano vicino all'autostrada impedivano del tutto la vista delle colline: lí la corrente del fiume perdeva forza, ampliandosi fino a trasformarsi da torrente in un intreccio di secche, un centinaio di metri piú avanti. A nord sorgevano montagne dalle schiene possenti, ma a sud erano dentellature che sembravano far presagire un territorio diverso. La State Route 88 era una strada sulla quale da anni avrei voluto viaggiare, non per via del fiume ma perché lungo il fiume, con una spaziatura ordinata come le parole sulla pagina, ci sono gli insediamenti di Ink (Inchiostro), Pencil Bluff (Promontorio a matita), e Story (Storia); a nord sugli Ouachita c'è Magazine (Rivista), e in direzione sud nella valle del fiume c'è Reader (Lettore). Considerando il mio metodo di scrittura, attraversare in macchina quel territorio dava un nuovo significato al termine autobiografia: io scrivo una prima versione a matita, la seconda a inchiostro con una penna stilografica, e soltanto in seguito entro nel regno delle cifre binarie (anche se sei versioni ó tremila pagine ó del mio primo libro sono venute fuori tic-tic-ticchettando dalla macchina da scrivere). Con un simile arcaico processo, questo partigiano della matita, questo sbavatore d'inchiostro, spera di lasciarti, lettore, una storia o due. Per me, la Ouachita Valley era la quintessenza del corso di un fiume cosí come può immaginarlo uno scrittore: ti blandisce con un quoz qui e uno là che si trasformano in annotazioni di un taccuino di appunti che cresceranno fino a diventare testi veri e propri da far arrivare a te sulla tua comoda poltrona cosí che poi uno di voi da qualche parte un giorno possa scrivermi e farmi notare che mi sono fatto sfuggire qualcosa come Scribblers Corner (Angolo degli scribacchini), Oghamville (Città dell'alfabeto celtico di Ogham), o Wordmonger City (Città degli spacciatori di parole). Il fiume cambiò da trasparente ruscello di montagna ad ampio corso d'acqua del color grigio-oliva sbiadito tipico delle uniformi da fatica dell'esercito, ma vedemmo altri affluenti che passavano sotto la Route 88 oltre allo Ouachita contornato d'alberi: ci poteva bastare, dato che non eravamo alla ricerca del fiume, ma della sua valle. A Ink, dove ci fermammo perché potessi fare una foto all'insegna della «città», addirittura prima che riuscissi a premere il pulsante dell'otturatore, un uomo accostò per offrirmi un passaggio, gesto che mi fece tornare in mente una frase che con indiscutibile logica avevo sentito sulla montagna a proposito della valle sottostante: «Laggiú la gente è gente». Nel 1887, i cittadini si riunirono al crocevia di Ink per domandare con una petizione un ufficio postale, richiedendo che il loro insediamento venisse ufficialmente chiamato Melon. Il nome però venne scartato, per ragioni a me ignote, anche se suggerisco la possibilità che qualcuno possa semplicemente averlo trovato troppo sciocco; in fin dei conti, non bastava Tomato (Pomodoro), Arkansas? Una storia che mi piace, ma sulla quale sono scettico, sostiene che il secondo voto a scrutinio segreto per scegliere il nome dell'insediamento contenesse l'indicazione di scrivere a inchiostro (WRITE IN INK) ma interpretabile anche come «Scrivi "Ink"»: cosí fecero i residenti e ottennero il loro ufficio postale, che chiuse ottant'anni dopo. Il tizio che mi offri il passaggio disse: - Devono averlo scritto con l'inchiostro simpatico. Il pomeriggio che Q e io la visitammo, Ink era un gruppo sparuto di case sparse intorno a un incrocio e al cimitero di una chiesa: lí c'era una piramide solida e tarchiata di pietra locale che sembrava indicare piú la presenza di Ink che la tomba di qualche defunto cittadino in particolare. A differenza del loro ufficio postale, la piramide, inestirpabile come da progetto, doveva durare per secoli. La burocrazia dell'Arkansas chiama simili insediamenti «comunità», ma i pochi residenti di Ink, in modo ancor piú approssimativo, useranno la parola cittadina, cosa che di sicuro non è, non piú di quanto «Y» City - una quindicina di chilometri scarsi a nord - sia una città. (Esiste un altro piccolo villaggio americano o un'altra cittadina con una sola lettera e le virgolette nel nome? A proposito, considerate le sei o sette case sparse vicino all'incrocio a tre vie, T «City» sarebbe stato un nome piú preciso. Già che ci siamo, esiste un'altra cittadina americana con due trattini oltre a Ho-Ho-Kus, nel New Jersey?) Tranne gli abitanti del New England, gli americani si sono allontanati in massa dalle parole esatte e piacevoli come paese e villaggio e sono oggi piú propensi a chiamare queste comunità non registrate in alcuna contea tane di bifolchi o zoticopoli o buchi dimenticati da Dio o, piú gentilmente, whistle-stops cioè stazioncine (c'è, infatti, una Whistleville, nell'Arkansas), tutte descrizioni che probabilmente non renderanno simpatico un estraneo agli autoctoni. Il termine che uso io per questi insediamenti, quando non hanno né fascino né attrattiva, è unincorptons, ovvero «città senza contea», un termine al quale manca, come a loro, qualsiasi incanto. Non molto tempo fa a Opolis, nel Kansas, dove era evidentemente assente qualunque parvenza urbana, Q suggerí che proprio da quel nome avrei potuto ricavare un utile termine generico per quel tipo di insediamenti: «opoli» che a lei piaceva soprattutto al plurale - perché le ricordava Termopili - come in «Le opoli dell'Arkansas sono molte, ma poche sono caratteristiche». Adesso piace anche a me. Superammo un'insegna su un palo recuperata, a quanto pareva, da una pompa di benzina abbandonata e riverniciata con una freccia puntata in direzione del fiume: LITTLE HOPE BAPTIST CHURCH, Chiesa Battista di Poca Speranza. (Q: «Nostra Signora della Santa Negatività»). Un anno prima nell'Arkansas orientale, mentre fotografavo un'insegna della HOLY GHOST DISTURBED CHURCH, Chiesa Disturbata dallo Spirito Santo, era uscito il pastore, disturbato dal mio scattare fotografie, e mi aveva fatto capire che aveva poco interesse a spiegare se qualche altro disturbo locale risiedesse nello Spirito, nella Chiesa, o nel suo cervello. In una visita recente alla città della mia infanzia, Kansas City, Missouri, Q si fissò con il nome Country Club Christian Church. Le accennai ciò che mi aveva detto Gus Kubitzki (che ormai conoscerete anche voi, un uomo noto piú per le professioni di sarcasmo che di fede) che la gente del CCCC, nel loro quartiere di lusso, aveva avuto un'intuizione: perché non organizzare congregazioni a seconda degli hobby? La Prima Chiesa dei Cacciatori di Anatre dell'Ultimo Giorno? L'Assemblea Riformata dei Numismatici Uniti? La Confraternita della Guida Assoluta del Vangelo al Pettegolezzo? Condividere la divinità con gente che ha interessi affini sarebbe sicuramente piú comunitario che avere il golfista che prega vicino allo sciatore, l'astemio accanto all'enofilo. Gus sosteneva che gente che prega spalla a spalla concentrata su desideri simili sarebbe stata piú fervida e - quindi - efficace: dacci oggi la nostra anatra quotidiana. | << | < | > | >> |Pagina 60Capitolo ottavo
Separé con alte paratie
Che il mooning - la pratica delle «chiappe di luna», ovvero la presentazione pubblica di un deretano umano senza veli - fosse comune tra gli indiani d'America del XVIII secolo, credo non sia un fatto noto a molte persone. Io, perlomeno, ignoravo la lunga storia dell'antico mooning fino a quando, una mattina a Hot Springs, mi imbattei in un brano del diario di George Hunter a proposito del suo viaggio del 1796 in cui discese il fiume Ohio fino al Kentucky, spedizione che ripeté otto anni dopo dirigendosi a sud per raggiungere Dunbar e dare inizio alla loro spedizione sull'Ouachita. Giunsi a quel quoz libresco mentre Q e io ci trovavamo in una vecchia stazione termale privata, intenti a bere acqua di quattromila anni fa che risaliva da una profondità di quasi duemilaquattrocento metri. Era caduta sotto forma di pioggia quando l'umanità, usando cannucce e argilla umida, stava insegnando a se stessa a scrivere. Bere quell'acqua fu come tracannare fresche sorsate di tempo. (Nell'antica purezza della Valle dei Vapori, anni or sono, gli scienziati conservavano pezzi di rocce della luna affinché fosse possibile studiarli per accertare la presenza di organismi alieni. Ma adesso sto parlando di «lune» di tutt'altro tipo). Tra una sorsata e l'altra, lessi a Q questo brano tratto da Hunter: Ieri ci siamo imbattuti in una chiatta larga e lunga, con un equipaggio di indiani e un uomo bianco del territorio dell'Illinois carico di pelli. Avanzavano controcorrente lungo la riva con grande rapidità, manovrandola abilmente con le pertiche; io li ho esaminati col cannocchiale e ho visto che erano quasi tutti nudi tranne per un fazzoletto annodato intorno al capo e un perizoma intorno al bacino; mentre ci avvicinavamo alla loro barca si sono accorti della mia lente e due di loro hanno immediatamente alzato il perizoma sporgendo il posteriore nudo. Se ricordate quello che aveva detto in precedenza sui soldati che lo insultavano sull'Ouachita, potrete concludere che il buon farmacista scozzese riscuoteva scarso rispetto sui fiumi americani. Andando a zonzo per il Sud, ho trovato che le ostentazioni di affabilità verso il viaggiatore - perfino se era uno yankee - erano notevolmente diffuse. Un paio di anni fa, ne ho capito uno dei motivi. Mi trovavo in un caffè del Tennessee, un vecchio locale con i séparé divisi da alte paratie di legno - ormai se ne vedono raramente - che fornivano una notevole privacy visiva sia a prua che a poppa. Mentre aspettavo una fetta di chess pie, una testa pallida e rotonda comparve lentamente sopra la cima del separé adiacente, sorgendo come una luna piena sull'orizzonte. Una volta emersa completamente, la faccia, non ancora in età scolare, mi esaminò attentamente finché non le rivolsi una strizzatina d'occhio. Svaní rapidamente solo per spuntare pian piano qualche istante dopo per un ulteriore esame, rituffandosi di nuovo quando le feci gli occhi storti. Ancora, dopo una pausa adeguata, si alzò al di sopra del separé, stavolta per trovare un'espressione da mostro famosa per aver spedito svariati cocchi di mamma a correre verso i grembiuli delle suddette. La faccia scomparve in un lampo. Qualche attimo dopo, si erse un'altra volta con ferma determinazione. Il ragazzino si accorse che adesso mi ero stancato del gioco. Progettando un'altra linea di condotta, il piccoletto annunciò, tutto orgoglioso di informarmene: - Ho due palle e una cannonata di uccello. Prima che potessi rispondere, la piccola luna della sua testa venne tirata giú, e sentii una donna dire: - Grazie per avercelo comunicato, Clevenger. La donna, che venni presto a sapere era la madre di Clevenger, non aveva rimproverato il figlio perché era stato troppo diretto o perché si era rivolto a uno sconosciuto. - Suo papà e io cerchiamo di insegnare ai nostri ragazzi a interpretare invece che giudicare, - disse. Spingevano Clevenger a imparare a valutare le persone invece che a ignorare o evitare qualcuno che non si conosceva, certi che avrebbe imparato da solo a smussare il suo modo di attaccare discorso. Insomma, non l'incoraggiavano a essere reticente o eccessivamente cauto davanti a una faccia nuova in città. Cosí il bambino, pensai, impara da solo qualcosa delle parole e del senso di comunità che la gente del Sud sa manifestare cosí bene. I viaggiatori che non riescono a intrattenere conversazioni estemporanee con praticamente qualunque essere vivente a sud del trentottesimo parallelo farebbero bene ad abbandonare immediatamente la strada e rivolgersi a un consulente qualificato. Devo aggiungere qui che le prime parole che ci si scambia nel Sud raramente sono gli insipidi ed educati convenevoli atti a coprire silenzi altrimenti imbarazzanti come può capitare, tanto per dire, a Hennepin County, nel Minnesota. L'approccio negli stati del Sud è imbastito su dettagli personali, anche se non sui soliti sproloqui egocentrici ma su particolari narrativi: la storia del mocassino acquatico, l'arresto per guida in stato di ebbrezza del cugino Otho, le ragioni del divorzio, il motivo preciso per cui il pane di mais di Flobelle è cosí buono. Una cameriera di campagna del Sud è presumibilmente, se non proprio per definizione, una buona conversatrice. Questione di un attimo, e l'ospite conoscerà il suo stato civile, il nome dei suoi figli, l'umore del cuoco, la qualità dell'ultimo sermone del predicatore. Quando sono in un ristorante del Sud, se vengo a sapere meno di tutto questo prima che arrivi l' hoppin John - il tipico piatto di riso, fagioli e cipolle - vuol dire che ho rimuginato troppo sulle malefatte delle multinazionali, o forse sono state solo la torta di rape o le noccioline con la RC Cola ad andarmi un po' di traverso. | << | < | > | >> |Pagina 85Capitolo dodicesimo
La Donna Capra di Smackover Creek
Non tutte le persone che un viaggiatore incontra lungo la strada sono davvero lí. A meno di comprimerla o distorcerla, l'esistenza non è cosí scontata. Giorno dopo giorno, che le si percepisca o no, passiamo continuamente attraverso ombre umane, presenze spettrali che non dipendono affatto dal soprannaturale ma dalla nostra disponibilità ad addentrarci nelle profondità del tempo. I nostri predecessori spesso lasciano dietro di sé un quoz o due come dono postumo che ci guidi mentre cerchiamo i mezzi per fare di loro quello che vogliamo, usandoli magari per espandere i nostri giorni limitati o per riannodarci a fili distanti, o forse solo ripensamenti che ci vincolano anche quando non ne vediamo il nesso. In questo modo, capita che un viaggiatore possa conoscere occasionalmente una persona morta e sepolta meglio di una che ha appena incontrato al tavolo accanto; quella signora che parlava di quanto piovesse poco, di quanto piovesse troppo, di quanto piovesse il giusto per un buon raccolto di cipolle, le cipolle migliori per il gumbo, il tortino di cipolla fatto con la ricetta di sua madre, quella volta che si arrabbiò con suo marito e gli fece un opossum al forno farcito con cipolle verdi e kudzu, quella stessa signora che altrimenti si teneva nascosta. La Donna Capra di Smackover Creek io non l'ho mai incontrata. Morí sedici anni prima che Q e io attraversassimo il torrente una ventina di chilometri a sud di Camden e circa altrettanti dalla sua confluenza con l'Ouachita. Dunbar conosceva il piccolo corso d'acqua, o forse uno vicino, con il nome di Chemin Couvert, una «via coperta dagli alberi». La descrizione francese, corrotta dagli americani, è forse la fonte del nome Smackover, per quanto i locali vi offriranno molte altre interpretazioni che spaziano dal possibile al nient'affatto plausibile. Il quoz che mi condusse alla Donna Capra si trova nell'Arkansas Museum of Natural Resources, un nome incolore, quasi a espiare la sua prossimità a un luogo chiamato Smackover (Schiaffone), o forse un'ipercorrezione del suo nome precedente - l'Arkansas Oil and Brine Museum - che vi avrebbe potuto portare alla conclusione che in mostra vi fossero macchinari storici per mettere i cetrioli in conserva. Il bromo, che ha lo stesso nome della salamoia (brine) viene estratto dalle acque salmastre sotterranee della zona. Il quoz in sé era un camion Ford Modello T del 1926, probabilmente nato come kit di fabbrica da assemblare: un motore montato su una struttura con le ruote che diventava una piattaforma semovente per alloggi grezzi e ingombranti, per quanto costruiti in modo solido, formati da pareti di lamiera ondulata e finestre a colonnine, il tutto nero impermeabilizzato tranne il vetro. Quell'affare aveva piú l'aspetto di una gabbia che di una casa su ruote. Sul retro, c'era una minuscola «veranda» che un tempo fungeva da quello che doveva essere il palcoscenico teatrale piú lillipuziano d'America. Il personale del museo chiamava l'impianto «carro» o «carrozzone del circo», termini entrambi fuorvianti; piú recente e preciso era «carrozzone da medico ciarlatano ambulante». Era, riteneva il personale, «probabilmente il piú raro manufatto che il museo avesse mai conservato». Tra i grossi fari anteriori e i minuscoli fanalini di coda, c'era la scatola di legno e metallo, sei metri per due, che fece per piú di mezzo secolo da casa alla Donna Capra, in pratica per tutti gli anni successivi all'abbandono della strada da parte del camion. Un tale mi disse: «Venne portata nella contea, ma non piú riportata indietro». Stava parlando della vettura, ma poteva anche essersi riferito all'inquilina che l'aveva abitata tanto a lungo. Come accadde che quel carrozzone da ciarlatani ambulanti venisse rimorchiato e tirato fuori dal fango dello Smackover Creek dopo anni di abbandono e vandalismo costituisce la storia di Rhene Salomè Miller Meyer. Il suo secondo nome sembra bizzarro a meno che non si consideri che sua madre aveva studiato canto lirico, e Rhene (si pronuncia Ré-na) nacque nel 1905, l'anno in cui venne rappresentata per la prima volta la Salomè di Richard Strauss. Eppure, mi domando, mamma Miller scelse di ignorare la patologica attrazione di Salomè per la testa di Giovanni Battista, o aveva in mente Salòme, la madre degli apostoli Giacomo e Giovanni? Se mi permettete poche frasi a proposito della biografia di Rhene, condurrò tutti noi nella parte della sua storia che credo vada ben oltre i limiti della vita di una donna. Molto di quanto so viene da Don Lambert che teneva una rubrica settimanale sullo «Smackover Journal» e piú tardi venne eletto sindaco, un uomo la cui modestia lo portò a sminuire il suo ruolo nella conservazione di quel quel carrozzone da fiera. Una generazione piú giovane di Rhene, la conobbe da ragazzo mentre andava a bruciare la spazzatura dietro il grande magazzino di sua madre sulla Broadway: lí Lambert poté parlare con Rhene attraverso lo steccato. Qualche anno dopo, quando lei si trasferí al ruscello, lui le consegnava i pacchi di Natale del Lions Club. Lambert scrisse una volta che «la sua storia sarà sempre rinchiusa in un dedalo impenetrabile e arcano». Aggiungerei, comunque, indipendentemente dalle possibili risposte all'enigma costituito dalla sua vita, che le domande stesse che solleva rivelano una via per entrare nel labirinto della Donna Capra. Se tutto ciò che esiste è un quoz potenziale per qualcuno, bisogna abbracciare il mistero perché ci si apra sua sponte. Proveniente da una famiglia di sei figli, Rhene era nata in Pennsylvania, in una fattoria nella Dutch Country, dove suo padre di tanto in tanto teneva presentazioni ambulanti per la vendita di una panacea, il Miracoloso Tonico per Capelli delle Sette Sorelle che «vi farà crescere i capelli fino a terra! » (Chi possa desiderare capelli che gli strusciano per terra, io ancora non l'ho capito). Sul palco, papà Miller faceva uscire trotterellando Rhene, che allora aveva tre anni, e indicava le sue lunghe trecce folte come prova dell'efficacia del tonico. Fin da quando aveva cominciato a muovere i primi passi, Rhene si era abituata a esibirsi in pubblico ed era arrivata a considerare il mondo come il suo palcoscenico. Quando Rhene non mostrava le trecce, il suo compito domestico, che le piaceva altrettanto, era mungere le capre di famiglia. Questi due incarichi gettarono le fondamenta di tutta la sua vita. A metà dell'adolescenza andò a Philadelphia a studiare arte; poi si trasferí a New York City per dedicarsi alla musica, alla Juilliard School. Qui forse si esibí alla Carnegie Hall, e il tutto la portò a studiare con una diva dell'opera. Ma tanta preparazione non procurò a Rhene nient'altro che un lavoro presso il circo Barnum & Bailey come one-girl band: suonava sette strumenti contemporaneamente (fisarmonica, armonica, tamburi, piatti, altre percussioni, tamburello, nacchere), o sei se si staccava dall'armonica che aveva montata intorno alla testa e cantava. Sapeva anche suonare il pianoforte, il violino, l'arpa e la grancassa. Negli anni Venti, Rhene viaggiò in tutta Europa con un altro circo finché quest'ultimo non falli, costringendola a tornare a New York a fare la modella per shampoo e cosmetici. Don Lambert disse: «I capelli di Mrs Meyer erano il suo vanto». In effetti, nelle due foto che ho visto, la capigliatura ispida piú che crescere esplodeva in un nembo scuro sopra un volto dagli zigomi alti e arrotondati e dagli occhi socchiusi con fare seducente. Quelle fotografie, il suo nome d'arte e il suo viaggio europeo mi indussero a ipotizzare che i suoi studi artistici l'avessero portata a scoprire le famose illustrazioni di Aubrey Beardsley per la Salomè di Oscar Wilde, come pure i ben noti dipinti di Gustav Klimt raffiguranti le due cacciatrici di teste, Salomè e Giuditta, ciascun ritratto basato sulla stessa modella i cui capelli e colori Rhene avrebbe potuto ritrovare in se medesima. Piú o meno nel 1927, o l'anno seguente, si uní a un piccolo luna park quasi in bancarotta, che faceva tappa per una sera soltanto nei paesini piú sperduti del Midwest e del Sud, posti in cui la gente sarebbe accorsa ad assistere a qualsiasi cosa se avesse promesso il benché minimo diversivo dalla quiete della vita locale: il sermone di un predicatore con poteri di guarigione andava bene quanto la dimostrazione di un medico ciarlatano (ed entrambi davano gli stessi risultati). Per una compagnia in difficoltà, alle soglie della Grande Depressione, una one-girl band era un'attrazione allettante e al tempo stesso economica. Nel 1929, il vacillante luna park arrivò a Camden, per non ripartire piú se non in pezzi, rovinato dalla crisi economica. Quando lo spettacolo sbaraccò i tendoni per l'ultima volta, Rhene poteva essere sull'orlo dell'indigenza. Aveva ventiquattro anni, era istruita, aveva un grande talento, era una bella donna, con tutto il mondo davanti a sé eppure, per ragioni sconosciute, decise di sposare Charley Meyer, piú vecchio di un quarto di secolo; si presume che fosse il direttore del luna park, uomo dal volto infelice, di poca istruzione o talento, ed eccentrico. La congettura piú semplice, per un'unione con tanta differenza di età, suggerisce un matrimonio di convenienza: ma il legame durò finché Charley mori ottuagenario e raggrinzito trentadue anni dopo. Forse per il fatto che il vecchio l'aveva fisicamente e mentalmente sottoposta a maltrattamenti, Rhene non si risposò, né a quanto pare ebbe alcun legame successivo. Appena sposati, portarono il carrozzone da ciarlatani da Camden fino in Poplar Street a Smackover dove Charley trovò un «ottimo residuo» - non gravato da affitto - dell'epoca in cui la città aveva conosciuto il boom del petrolio e vi apri una rivendita di pneumatici usati che garantiva un introito limitato. Di colpo, la vita di lei passò da un'esistenza il piú pubblica possibile, ricca di relazioni sociali, a un inspiegabile isolamento, una segregazione che la nascondeva al mondo. Nel retro del negozio di pneumatici c'era il carrozzone dello spettacolo, intorno al quale Charley costruí una palizzata di assi che Don Lambert disse «presentava l'aspetto di una prigione», per lo piú coperta da un pergolato per creare una zona recintata. Lí dentro Rhene scomparve di fatto per le successive due decadi, in compagnia di una tribú di capre che adorava e che quasi non sembrava distinguere dalle persone. Era la situazione perfetta per un moderno racconto chauceriano: un marito geloso che sta invecchiando e teme le corna rinchiude la sua ammaliante sposina mentre lui compra e vende pneumatici di scarto e vulcanizza copertoni bucati. » il classico tema della fanciulla nella torre, e la torre di Rhene era una palizzata di legno: Raperonzolo, Raperonzolo, getta la treccia (fatta crescere fino a toccare terra dal Miracoloso Tonico per Capelli delle Sette Sorelle). Il ritiro di Rhene in un camion Modello T rinchiuso in un recinto per le capre fu cosí improvviso e totale che la gente del villaggio cominciò a chiedersi se la sua reclusione non fosse quella di una prigioniera. Lo sceriffo passò due volte dalla piccola zona recintata di Charley a fare domande e a dare un'occhiata all'interno, e in una delle due occasioni chiese di vedere il certificato di matrimonio. No, disse lo sceriffo alla gente, la Donna Capra non era obbligata; per quanto aveva potuto determinare, l'isolamento era avvenuto di sua volontà. Sebbene nessuno usasse questi termini, la donna senza figli sembrava un'anacoreta il cui santuario era un angusto recinto per le capre e le cui divinità erano bestie con gli zoccoli. | << | < | > | >> |Pagina 126Questa è la terra in cui l'Ouachita termina, o forse dovrei dire svanisce.Per un paio di righe, paziente lettore, consentimi di antropomorfizzare il fiume che per tantissimi giorni ci ha trasportati non sulla sua corrente ma alla sua ampia presenza. L'Ouachita non deve essere affatto contento di vedere la sua lunga e serpentina discesa - una caduta che, se fosse portata a termine tutta in una volta, supererebbe una dozzina di cascate del Niagara una in cima all'altra - usurpata da un paio di simulatori conniventi, che al confronto non si possono nemmeno definire «lunghi», proprio nel luogo in cui dovrebbe essere incoronato re (viaggiare sopra un fiume è come osservare una donna in tutti i suoi cambiamenti d'umore e le sue fasi). Immagina di essere avanzato a passo lento in un corteo regale lungo novecento chilometri; poi, quando sei finalmente in vista del trono, la destinazione che ti è stata promessa, un intruso munito di un permesso ufficiale si fa strada a spintoni davanti a te e afferra la corona per passarla a un minore senza alcuna esperienza di governo. Questo è quello che accade all'Ouachita a Jonesville dove il fiume Tensas (lungo 375 chilometri) e il Little River (trentacinque chilometri), nel giro di un paio di centinaia di metri, l'uno dopo l'altro confluiscono nel grande fiume che è piú del doppio della loro lunghezza sommata. Il corso d'acqua cosí ricostituito - con un nome lugubre che ne riflette l'ingiustizia - è il Black River. (Ogni volta che qui leggerete «Black River», convertite nella vostra mente quel nome tenebroso e impreciso in uno eufonico e storicamente corretto: Ouachita. Quanto al Little River, lo chiamerò con il suo piú antico ed evocativo nome indiano, Catahoula, tradotto da uno storico come «Fiume del Grande Spirito»). Per modificare la mia metafora antropomorfa, l'Ouachita è il corridore in testa in una maratona in cui un impostore si intrufola nella corsa a un centinaio di metri dal traguardo e compie lo sprint finale fresco come una rosa. Non c'è un giudice di gara che sanzioni l'irregolarità? Qualcuno dirà, e a ragione, che per duecento milioni di anni il fiume è stato una cosa senza cervello, spinta soltanto dalle leggi della gravità a raggiungere il suo progenitore, il mare, perciò un nome di duecento anni attaccato alla coda non ha alcuna importanza. » il fatto che non abbia alcuna importanza che mi riporta all'argomento da cui sono partito: gli indiani del 400 d.C. e lo Huey Long Bridge del 1935 d.C. Per tutto il percorso, fin dal tavolo da domino nel bazar di Rich Mountain alle sorgenti dello Ouachita, non vedevo l'ora che la mia curiosità venisse ricompensata dalla scoperta di un qualunque quoz si trovasse al termine del fiume. Se è vero che ero già passato per Jonesville anni prima, allora ero troppo inesperto e ignorante per riconoscere l'aspetto esteriore di quello che c'era, per non parlare delle sue ramificazioni, perciò non feci nulla se non rallentare l'andatura fino al limite di velocità stabilito, senza neppure una sosta per gustare una MoonPie. Anni dopo, ma prima che venissi a sapere che l'Ouachita sfocia a Trinity - un gruppo di case al di là del Catahoula rispetto a Jonesville - venni a sapere dei Tumuli di Troyville. Un po' di tempo dopo scoprii che Troyville adesso corrispondeva a Jonesville, la prima di molte decisioni sconsiderate nella zona, soprattutto se si pensa che il nuovo nome comparve soltanto nel 1870 in seguito a una contesa che, scrisse uno storico locale, «in definitiva costò la vita di almeno cinque importanti cittadini della contea e, in un certo senso, pose fine a due delle piú colte e importanti famiglie di quella parte dello stato». (Altre voci dicono che la donna che insistette per cambiare il nome in Jonesville fosse molto nota per la sua crudeltà nei confronti degli schiavi). Se mi venisse concessa una settimana di vacanza ovunque nel passato americano, andrei in uno dei grandiosi terrapieni aborigeni all'apice della sua esistenza: Cahokia, Poverty Point, Etowah, Spiro, Serpent Mound, il Newark Octagon nell'Ohio; forse anche uno dei tumuli ornati da effigi dell'alta valle del Mississippi. I tumuli nella parte terminale della Mississippi Valley risalgono almeno a settemila anni fa, un arco di tempo di cui alcuni americani hanno una concezione non piú precisa della durata del Carbonifero superiore. Ma considerare il nostro posto in questo nostro posto - perfino una percezione della superficialità della storia umana - può migliorare il proprio comportamento planetario in modo meraviglioso. Se un visitatore potesse tornare con una serie di fotografie digitali da una di quelle grandi civiltà del terrapieno all'epoca del loro pieno uso da parte degli indigeni, la nostra comprensione dell'America sarebbe arricchita oltre ogni immaginazione, e i libri di storia potrebbero iniziare con qualcosa di piú del fuorviante accenno frettoloso a un passato indistinto precedente l'incursione europea. Io e Q viviamo a circa un chilometro dalla valle del corso inferiore del Missouri, dove alte scogliere di calcare sono cosparse di piccoli tumuli risalenti a mille e cinquecento anni fa: vale a dire, strutture dell'epoca in cui i Visigoti saccheggiavano Roma e i Sassoni facevano piú o meno lo stesso nella Britannia celtica. In un punto, prima che fosse inglobato dall'area di caccia di proprietà di uno venuto da fuori, c'era un tumulo che andavo a visitare per sedermi li vicino a guardare la piana lunga tre chilometri, soggetta alle esondazioni periodiche del Missouri. Quando venne costruito il tumulo, probabilmente per una sepoltura, il fiume scorreva ai piedi del dirupo. Questi tumuli sono dove sono - parlo di nuovo da probabilista - perché la gente che li costruí pensava che un fiume potesse trasportare il grande mistero racchiuso in un essere umano in un altro posto con un viaggio che si presumeva riflettesse quello terrestre. Ci sono luoghi specifici nel cuore di ogni cosmologia indiana che conosco perché la genesi dell'uomo deriva dalla terra: da un luogo. Per la popolazione indigena che giace all'interno di quei tumuli di terra e pietra lungo il Missouri, il senso del sacro cominciava e finiva con un quoz terreno che spingeva alla venerazione, quella venerazione che segue al riconoscimento del mistero. I probabilisti non possono fare altro che limitarsi a postulare la possibilità di un viaggio post-corporeo lungo un fiume. Però c'è una cosa autentica e verificabile che possono fare: compierne uno, di viaggio intendo, in quella che alcuni «credenti» considerano la nostra pre-vita ultraterrena. Negli anni, in quel tumulo sopra il fiume, ho immaginato viaggi che partivano di li per rive lontane, e ne ho anche intrapresi alcuni nella realtà. Di li potevo partire con la mia canoa lungo il Missouri e - fino agli ultimi pochi chilometri - senza usare energia che non fosse quella dei fiumi stessi, raggiungere l'Ouachita: un viaggio di millesettecento chilometri. Ovunque stiate leggendo queste parole - a Sydney nel Nebraska o a Sydney in Australia; a Florence nell'Oregon o a Firenze in Italia - il piú vicino corso navigabile potrebbe far intraprendere anche a voi un viaggio verso l'Ouachita. Una volta ancora, sveglio lettore (tu che cosí spesso sei avanti a me), hai colto il senso. Noi apparteniamo alla terra; i territori sono uno solo perché le acque sono una sola, e niente rivela cosí tanto quella unicità quanto i corsi dei fiumi. Conoscete la vecchia analogia: arterie e vene in un solo corpo. Credo che anche gli inteletti antichi dell'America l'avessero capito, ed è questo il motivo per cui sorgenti e confluenze d'acqua erano importanti per loro, perché sono, forse piú di tutto il resto, sorgenti e confluenze a creare non solo il quoz ma il sacro in ogni cosmologia. Credo che quegli intelletti, come i nostri, comprendessero l'esistenza, nei limiti in cui un essere umano la può in qualche modo comprendere, attraverso la scoperta e la venerazione di connessioni e continuità. | << | < | > | >> |Pagina 205Su un anello di luceIl giorno dopo l'indiano mi rivelò come loro chiamavano questa luce - Artoosoqu' - e alle mie domande riguardanti i fuochi fatui e fenomeni affini, disse che la sua «gente» a volte vedeva fuochi che si muovevano a varie altezze, anche alti come gli alberi, e che facevano rumore. Ero preparato a questo punto ad ascoltare il fenomeno piú stupefacente e inimmaginabile cui «la sua gente» aveva assistito; loro stanno all'aperto a tutte le ore e in tutte le stagioni in ambienti assolutamente poco battuti dai bianchi. La natura deve aver fatto loro mille rivelazioni che per noi sono ancora segrete. Non rimpiango di non aver visto prima la cosa, dato che ora l'ho vista in circostanze cosí favorevoli. Ero nella disposizione di spirito adatta per vedere qualcosa di meraviglioso [quella notte], e questo era un fenomeno all'altezza della mia situazione e delle mie aspettative, e mi mise nella condizione d'attenzione necessaria a vederne altri. Lasciai la scienza da parte, e mi gustai quella luce come se fosse anch'essa una creatura. Vidi che era perfetta, e fui felicissimo di sapere che era cosí a buon mercato. Una spiegazione scientifica, come si dice, lí sarebbe stata completamente fuori luogo. Quella va bene per la pallida luce del giorno. La scienza con il suo rimbeccare mi avrebbe messo a tacere; fu l'opportunità dell'ignoranza quello di cui approfittai. Mi suggerí che, se si avevano occhi, qualcosa da vedere c'era. Mi rese credente piú di prima. Credetti che i boschi non erano privi di abitanti, ma sempre colmi di spiriti integri buoni quanto me - non una camera vuota in cui la chimica veniva lasciata a lavorare da sola, ma una casa abitata e per qualche istante godetti della loro compagnia. Il cosiddetto uomo saggio di cui tanto si parla cerca di convincersi che non c'è nessuna entità lí se non lui stesso e le sue trappole, ma è molto piú facile credere alla verità. Tutto ciò mi suggerí anche che la stessa esperienza fa sempre nascere lo stesso tipo di credo o religione. Una rivelazione è stata fatta all'indiano, un'altra all'uomo bianco. Io ho tanto da imparare dall'indiano, e niente dal missionario. Non ne sono sicuro, ma l'unica cosa che mi farebbe venire la tentazione di insegnare all'indiano la mia religione sarebbe che mi promettesse di insegnarmi la sua. » troppo tempo che ascolto cose irrilevanti; adesso finalmente sono felice di aver fatto conoscenza con la luce che dimora nei boschi in decomposizione. Dove è finita tutta la vostra conoscenza? Evapora completamente, perché non ha profondità. HENRY DAVID THOREAU, Le foreste del Maine, 1864 | << | < | > | >> |Pagina 207Capitolo primo
Apologia del compagno lettore
Mai, giovani autori, aprire una storia con le parole di un altro scrittore. Io, che sono giovane solo se paragonato con il fango o con una tartaruga delle Galàpagos, mi sono guadagnato - almeno nella mia testa - la libertà di violare questo assioma. L'eccezione conferma la regola, cosí si dice. Ecco la mia trasgressione, appartenente al XVIII secolo, da La vita e le opinioni di Tristram Shandy, gentiluomo di Laurence Sterne: Tra le infinite maniere di dar principio a un libro, che oggigiorno sono in uso in tutto il mondo conosciuto, ho fiducia che la mia sia la migliore; e sono certo che è la piú pia, perché comincio con lo scrivere il primo periodo, e mi affido a Dio Onnipotente per il successivo. E cosí possa essere anche dei viaggi, in cui il viaggiatore fa il primo passo, percorre il primo chilometro, intraprende la prima giornata, e da quel momento in poi piú o meno segue quello che ordinano degli dèi della Via Onnipotente. La frase iniziale della prossima tappa della ricerca dei quoz in compagnia di Q - il nostro primo passo, come presto vedrete - è «Q era già a conoscenza delle quattro gemelle e della partita planetaria a Pachisi molto prima che ci mettessimo in viaggio: quindi questi argomenti non entrarono nella nostra conversazione lungo la strada verso la Luce Fantasma di Quapaw». Ma prima di arrivare a quelle parole, devo dire alcune cose preparatorie. (Se vi è mai passato per la testa di scendere da un qualsiasi mezzo di trasporto in una città isolata e ritrovarvi senza bagaglio coperti solo con il pigiama, allora sapete cosa vuol dire arrivare impreparati). Entrambi volevamo da tempo verificare o sfatare la storia della Luce Fantasma di Quapaw e, fortunatamente, era piú o meno di strada mentre viaggiavamo verso il Sud del New Mexico. Ovviamente, per un viaggiatore che fa il giro lungo qualsiasi posto è di strada. Il Potente Qualcosa - non la smetterò con le divinità - mi ha fornito davvero la seconda frase (quella che di fatto apre questo capitolo), anche se, a quanto ne potevo capire all'inizio, non sembrava avere il minimo collegamento logico con le originarie prime parole del capitolo. Gli onnipotenti spesso agiscono cosí: le logiche misteriose (quando non mistiche) giungono a noi cosí piene di lacune e pagine vuote che siamo costretti a procedere da soli, a tentoni. Ma almeno, in questo procedere a tentoni, scopriamo la nostra strada, troviamo noi stessi: bene o male, viviamo. In questo modo scriviamo la nostra autobiografia con piedi vagabondi e con le orme che si lasciano dietro... per quanto molte di quelle tracce vengano portate via dai venti prima che qualcun altro possa coglierle. Gus Kubitzki sosteneva che la vita è un cosmico gioco da tavolo contro un avversario invisibile e invincibile che passa la maggior parte del suo tempo a dire: «Tocca a te», forzandoti cosí la mano prima che tu sia pronto. Il gioco, evidentemente, non serve a vedere se vinci o perdi - la sconfitta è prestabilita - ma piuttosto si tratta di cogliere il disegno composto dalle tracce che ti lasci alle spalle e vedere dove conducono le mosse che ti restano. La prima volta che Gus mi parlò di questa idea - sebbene non ne sia lui l'autore originario - si scusò dell'apparente cripto-cristianesimo della sua analogia prima di citare la Lettera di san Giacomo: «Insensato, vuoi capire che la fede senza le opere non ha valore?» Poi Gus mi offri la variazione di un altro passo dell'epistola: «Un uomo è giustificato dalle sue orme». Questa visione è considerevolmente meno deterministica di quella di Mastro Tristram ed esige uno sforzo maggiore del semplice prestare orecchio alle direttive cosmiche. Vuol dire, affermò Gus, imprimere orme che conferiscono il travaglio - il senso - al travel, viaggio. (Anticamente, gli americani scrivevano traveller, viaggiatore, come travailleur, colui che compie grandi fatiche). In realtà, le orme sono la ragione per cui alcune persone sono convinte che un pellegrinaggio - seguire i passi di un altro - sia una forma piú elevata di viaggio. Siamo tutti, direbbe Gus - consapevoli o meno - sempre sulle tracce di altri. Con pellegrinaggi e Pachisi planetari in mente (il Pachisi, nel caso te lo stessi chiedendo, è un gioco da tavolo di origine indiana che si gioca su una scacchiera a forma di croce greca), capace lettore, ecco che ci inoltriamo nel Sudovest passando per la Luce Fantasma di Quapaw, con una rapida deviazione a Galatia, nel Kansas, intorno al 1920, e un'altra in Missouri, nella Joplin del 1901, ma solo dopo averti sottoposto la terza frase che qualche Onnipotente mi ha appena fornito, apparentemente perché quella Potenza vuole che tu la legga a questo punto piuttosto che all'inizio del capitolo. Le dimensioni dell'America sfidano i piani dei viaggiatori quanto la loro comprensione, e per gli scribacchini on the road è utile rispondere a un principio organizzatore prima di mettersi in viaggio in cerca di conforto morale, anche se procedere semplicemente alla cieca è in sé un principio organizzatore, un principio comune che spesso si traduce in un tragitto ad ampio raggio oppure, di quando in quando, solo in una piccola circumnavigazione all'interno di una regione. Ho usato entrambi i metodi nei miei giorni sulle strade secondarie (e alcune volte ne ho anche descritto i risultati), ma per queste strade verso i quoz che sono ora nelle vostre mani, voglio qualcosa di piú informale, piú aperto alla felicità di un incontro casuale, piú propenso alle stravaganze, piú pronto ad abbracciare il vagabondaggio perché è cosí che funziona la vita. Un approccio ideale potrebbe essere quello di levarsi in volo a bordo di una mongolfiera - arte che, quanto a direzione, dipende dal capriccio dei venti -, a un certo momento non prestabilito venire espulsi dal cesto e paracadutati nel territorio sottostante, qualunque sia e, mentre ci si toglie le cinghie, dire: «Be', guarda dove diavolo sono atterrato stavolta». Se appena nati potessimo già parlare, molti di noi pronuncerebbero proprio questa frase al posto del loro primo vagito. Viste le difficoltà di un simile modo di procedere, sono ricorso alla selezione di alcuni punti di partenza e alcuni di arrivo, considerando le strade che li collegano (dato che ne ho, già percorse la maggioranza) soltanto di saltuaria importanza, un'importanza, cioè, che di solito nasce da eventi casuali. Nei viaggi in treno, il piú grosso svantaggio è proprio l'abituale mancanza di eventi casuali significativi lungo il tragitto, credo, soprattutto data la limitata estensione delle ferrovie in America, per cui uno fin dall'inizio conosce esattamente il percorso e anche gli orari previsti di arrivo e di partenza. (Per quanto riguarda le linee aeree commerciali, non mi degnerò di chiamarli viaggi, dal momento che non offrono altro che movimento: il passeggero-vittima, come un pezzetto di patata infilato in bocca, ha la sventura di venire spostato dal punto d'ingresso a quello d'uscita). Non voglio, perspicaci lettori, che crediate che le ambientazioni vi vengano messe davanti per amore o per forza, alla rinfusa, in fretta e furia. Non ho nessuna voglia di tracciare un'escursione scombiccherata, indipendentemente dal fatto che la vita su questo pianeta spesso appaia disorganizzata esattamente nello stesso modo. Sono alla ricerca di una struttura aperta piuttosto che di una metaforica. | << | < | > | >> |Pagina 225Capitolo quarto
Una storia poetica di Satana
William Grayston, nato nel 1862, poco dopo la guerra di Secessione arrivò con la sua famiglia nei pressi di Sparta, nella contea di Christian, in Missouri, sul margine degli Ozark settentrionali, circa centoventi chilometri a est di Joplin. La contea si chiamava così non per questioni religiose, ma perché prendeva il nome da un distretto del Kentucky che, a sua volta, portava il cognome di un soldato della guerra d'Indipendenza ucciso dagli indiani. Quella zona del Missouri, perfino con i suoi ferventi battisti e le loro lavande di piedi, era un covo di vigilantes: durante un'impiccagione pubblica, a pregare per uno di loro sul patibolo, c'era il padre di William, David, uno scalpellino inglese immigrato che si era spinto a ovest e aveva trovato lavoro sull'Erie Canal. Una volta arrivato nel Sud del Missouri, David scopri che sapeva predicare, scrivere, e discutere meglio di qualsiasi metodista, presbiteriano o libero pensatore che avesse il coraggio di sfidarlo. Scrisse Una storia poetica di Satana, Divagazioni poetiche in cerca della Chiesa, Millenarismo e la Bibbia poetica dove (se riuscite a immaginarlo) traspose tutte le sacre scritture, dalla Genesi all'Apocalisse, in distici, le rime piú insopportabili. Lui e suo cognato, B. J. Wrightsman, su commissione di qualcuno, composero Missouri e la presentarono come inno ufficiale dello stato; dopo un'esecuzione del brano al Campidoglio conclusasi con un'ovazione, la loro composizione cadde nell'oblio, a parte la mia copia dello spartito dentro il panchetto del pianoforte di Q. Di tanto in tanto, lei lo tira fuori per divertirmi con la sua melodia che non ha assolutamente niente della solennità dell'inno, anche se è un pezzo allegro capace di far dimenare il sedere. Quanto alla Bibbia poetica di David Grayston e alla sua storia del vecchio Messer Satanasso, non sono mai riuscito a trovarle. William era cresciuto in una casa infarcita dei sermoni di un padre brillante ma distaccato, un uomo che era (scrisse il «Joplin Daily Globe» nel 1901) «una forza in grado di plasmare il destino sia religioso che politico del Sudest del Missouri». Il giovane Willie, un bel ragazzo dall'intelletto acuto, si dedicò alla religione piú con l'intento di dimostrare la falsità dei ragionamenti delle altre sette che di propugnare la sua base teosofica dell'interpretazione dell'esistenza. Il compito terreno dell'umanità, cosí aveva sentito ripetere a piú riprese, era essere acquiescenti e limitarsi a credere; in fin dei conti, le cose sarebbero state spiegate in seguito, nell'aldilà. Ma la presunta superiorità dell'inconsapevolezza volontaria sulla libertà di indagine per lui non aveva alcun senso. Se un Creatore ci aveva fornito l'intelligenza e la capacità di investigare e scoprire le verità, perché avrebbe poi insistito su credenze che esigevano una fede cieca? Il ragazzo si chiedeva se si potesse ottenere la vita eterna con nient'altro che l'irragionevole e perfino ottusa confessione dei peccati che precedeva la professione del «Credo». Una simile irragionevolezza non era forse una facile scappatoia dalle proprie scelleratezze che minimizzava - se non negava apertamente - il significato delle opere buone? Uno stragista poteva confessarsi fare professione di fede e ottenere in quel modo la redenzione eterna, mentre un medico libero pensatore che aveva curato migliaia di persone sarebbe stato dannato per sempre? Come poteva una simile concezione far progredire l'umanità? Che razza di dio avrebbe incoraggiato una fede cieca che aveva la meglio sulla pietà e sulla generosità? La ricerca della «salvezza personale» non era forse l'espressione estrema dell'egoismo puro?
Allontanatosi gradualmente da una religiosità che poneva l'accento piú
sull'iniquità che sull'indagine, piú sulla pietà che sulla
perspicacia, William imparò a fare arringhe piuttosto che prediche,
e una volta diventato adulto scoprí che i suoi principÓ di morale e
di etica, di giustizia sociale e di responsabilità pubblica, risiedevano molto
piú nell'umanità stessa che nella divinità. Se una cosa
come la redenzione celeste esisteva, non sarebbe giunta grazie a
una dichiarazione di fede passibile di evaporare in un istante, ma
tramite opere generose che potevano restare a lungo come indicatori della
propria vita. Cominciò a comprendere la maggior portata
della sfida - e dei rischi - connaturata al cercare di portare la gente a
ragionare piuttosto che semplicemente a credere. Per lui, la
via per una vita migliore per tutti si doveva scoprire attraverso
la luce dell'indagine invece che attraverso la fede assoluta. I suoi
strumenti erano il pensiero induttivo e il metodo scientifico. Come, con
tristezza, scrisse di lui in seguito suo padre:
Il giovane Grayston non temeva lo sforzo impegnativo della ricerca di una spiritualità basata non sulla supposizione, sulle restrizioni, sulla credulità, e sull'opinione elevata a dogma, ma su un ragionamento serrato che conduceva, come inevitabile conseguenza, al mettersi al servizio degli altri. I suoi testi sacri divennero gli scritti di Thomas Huxley, Charles Darwin e soprattutto Herbert Spencer («lotta per l'esistenza», «la sopravvivenza del piú forte»). Nel 1901 il «Globe» avrebbe scritto di William: «Conosceva il contenuto di L'origine delle specie e L'origine dell'uomo meglio forse di chiunque altro in tutto il Missouri... Nessun aspetto né della scienza applicata né del pensiero speculativo sfuggiva alla sua attenzione». Grayston era un uomo sempre alla ricerca di prove, ovunque esse si trovassero: questo lo condusse verso la giurisprudenza, dopo aver scoperto un esempio da seguire nell'avvocato e oratore Robert Ingersoll di New York. Anch'egli figlio di un predicatore, i suoi discorsi da libero pensatore razionalista - «Perché sono un agnostico», «Alcuni errori di Mosè», «Superstizione» - forse gli impedirono di candidarsi alla Presidenza degli Stati Uniti. (O forse a bloccargli quella strada furono motti di spirito come: «Con il sapone, il battesimo è una buona cosa»). I rapporti tra il figlio e suo padre, dogmatico in tutto ciò che concerneva la Bibbia, si fecero tesi, soprattutto quando Will andò a Ovest nella nuova colonia di liberi pensatori di Liberal, nel Missouri, quarantacinque chilometri a nord di Joplin. Per un breve periodo di tempo, all'età di ventitre anni, divenne il preside della scuola che presto sarebbe diventata l'Università del Libero Pensiero in (si lagnavano gli avversari) «una città senza dio» dove non c'erano chiese né saloon, dove i liberi pensatori residenti dicevano di tenere «un piede sul collo del clericalismo e l'altro sulla roccia della verità». Nella Universal Mental Liberty Hall, Will ascoltò o fece conferenze e discusse con tutti quelli che venivano: scienziati, battisti, atei, ebrei, deisti, cattolici, e chiunque altro capace d'intendere e di volere, e disposto a osservare l'unica regola di mantenere un «rispettabile decoro». Un luogo simile, naturalmente, suscitò l'ira - se non la paura - di certi cristiani intolleranti che potevano vederlo solo come un «esperimento pratico di miscredenza» e che condannarono e scomunicarono chiunque vi fosse associato. | << | < | > | >> |Pagina 313Capitolo primo
Nella speranza che il lettore eterno non se la svigni
Ora che i nostri viaggi hanno superato il segno della metà del cammino, lettore eterno, mi viene in mente che non ho ancora detto nulla del sottotitolo di questo libro e della sua parola chiave, mosey, andare in giro. Forse hai sentito questo termine per la prima volta dalla bocca di un mandriano imbroglione con i basettoni in qualche film western di serie B: «Penso che continuerò ad andare in giro». Ma noterai che l'ho trasformato in un sostantivo che significa «procedere lentamente in senso letterale e figurato, con destinazione posti piccoli nella nostra nazione o in una nozione». » un vagabondaggio perché ovunque sulle strade per quoz c'è un cartello che dice «di qui in poi limitare la velocità». Affrettarsi, nello spazio o nelle idee, significa perdersi indicatori stradali poco visibili, vie laterali nascoste, o un'uscita per Sublimity City (Kentucky) o Surprise Valley (California) o addirittura Dull Center (Wyoming). Viaggiare con tutta calma oggi è quasi considerato antiamericano, quindi mettere mosey, un puro americanismo, nel titolo di un libro sull'America sconfina nell'illogico e invita alla derisione da parte di qualunque cittadino abbia una licenza di correre rilasciata dal Dipartimento della Velocità di una nazione diabolicamente incline alla destinazione, se non al destino, di quest'Era Postfrettolosa: [DA LEGGERSI PRESTISSIMO] Sportello veloce per automobilisti, chiamata veloce, lettura veloce, speedball di cocaina ed eroina, fatto di speed, corse speedway, Speedy Gonzales Ńndale ándale, accesso immediato, senza attesa, chiamate immediatamente... non aspettate, adesso è il momento, non ho tempo, decisioni affrettate, zuppa istantanea, ordinazioni veloci allo sportello di un fast food, pranzo veloce e datti una mossa, fermate rapide, tempo rapido, conteggio rapido, artista del trasformismo rapido, affrettato e superficiale, una sveltina, in un baleno, alla svelta, sei li in un batter d'occhio, fotocopie laser, caffè istantaneo, contante immediato, vincitori immediati, instant replay, notorietà istantanea, successo immediato, espresso notturno, fuoco di paglia, quindici minuti di gloria, manager in dieci minuti, riso che cuoce in cinque minuti, bistecca in un minuto, ho solo un minuto, frutti di mare in frittura lampo, patate liofilizzate cotte all'istante, flash drive, in un lampo, in un battibaleno, veloce come il fulmine, corsia preferenziale, corsia veloce, corsia di sorpasso nella corsa al successo, imbroglione dalla parlantina a raffica, gelata veloce, reattore autofertilizzante veloce, non riesco a colpire i lanci veloci, piú veloce di un proiettile, zip, zoom, whoom, a tutta birra, in un nonnulla, in meno di un niente, chi non si ferma non mette radici, chi ha tempo non aspetti tempo, tagliare la corda, sbrigati, spicciati, datti una svegliata, vattene di gran carriera, filatela alla svelta, prendili e mollali, entra ed esci, alza il culo, forza un po', fallo girare al massimo, vai a tavoletta, vai a manetta, vai a palla, vai sparato, procedi a tutta velocità, a tutto vapore, a tutta birra, a tutto spiano, muovi il culo, a precipizio, andare a mille, mangia la mia polvere, ora mi vedi ora non mi vedi, Road Runner Beep-beep, andare come un matto, andare come una saetta, maniaco della velocità, demone della velocità, all'impazzata, alla velocità della luce, solo semafori verdi sulle autostrade di Dio, mai guardarsi indietro, qualcosa potrebbe raggiungerti e oggi ci sei ó domani non ci sei. [DA LEGGERSI ADAGIO MOLTO] Nella corsa mortale fino a raggiungere il traguardo dove i sei portatori della bara ti condurranno a passo di funerale sottoterra per trascorrere l'eternità a Dead Slow. Queste peregrinazioni nei quoz sono un vagabondaggio perché ci sono voluti tre anni e quattro stagioni per compiere i ventiquattromila chilometri di viaggi in posti che buona parte della popolazione americana chiamerebbe «da nessuna parte». Ma io credo semplicemente che svignarsela e partire per il territorio, per saccheggiare le parole di Huck Finn, ha la sua buona giustificazione in sé; per plagiare un'altra frase, stavolta dell'alpinista George Mallory potreste vederlo come un'esplorazione di un qualcosa solo «perché è li». In centinaia di modi, l'America è arrivata dov'è perché la sua gente può essere attratta da una destinazione in maniera maniacale; e per la stessa ragione l'America non è dove non è. Alcuni di noi la considerano una circostanza piacevole. Aggiungerò qui, anche in un certo senso in ritardo, che a qualsiasi recensore tenti di trovare una tesi in queste pagine verrà sommariamente vietato l'accesso alla sua macchina da scrivere finché non sarà in grado di dichiarare in termini chiari e concisi la tesi della propria vita. I significati, naturalmente, sono un altro discorso. C'è piú vita sulla strada per il foro che nel foro, ed esiste una parola significativa per quel fenomeno: circumforaneo, l'andarsene a zonzo di foro in foro. Che ci piaccia o no, nel bene e nel male, viviamo tutti delle vite circumforanee, ed è il motivo per cui questo è un libro circumforaneo. | << | < | > | >> |Pagina 373Anni fa ci fu una causa civile per demolire il ponte di Brooklyn perché costituiva un pericolo per la navigazione dell'East River. Se un'icona cosí amata può essere minacciata, allora quali futuri rischi attendono un viadotto isolato, nonostante la sua bellezza e il suo significato storico? » possibile che un giorno la cosa piú resistente che si frapporrà tra quei giganteschi archi di arenaria bluestone e la palla di un demolitore saranno le quaranta pagine del pamphlet di Young. In fin dei conti, l'America non è l'Italia dove al grande Acquedotto Claudio è stato permesso di restare in piedi duemila anni per ispirare generazioni di architetti, ingegneri e artisti. Per due millenni ha collegato non solo i due versanti della valle ma i due versanti del tempo, uno dei quali è il futuro. La nicchia di William Young nella storia americana potrà anche essere piccola, ma è profonda.| << | < | > | >> |Pagina 432A casa, P. C. riceveva molti insegnamenti da sua nonna, la quale aveva pensato che qualche giorno in un posto lontano con suo «zio» nel Missouri gli avrebbe giovato. Il mio piano era di portarlo sulla strada, aprirgli territori nuovi, farlo camminare nei miei boschi, mostrargli il cupo pozzo nero e raccontargli la storia dell'uomo che ci era rimasto intrappolato dentro; gli avrei aperto sotto gli occhi la mia cartina del 1950, disegnata a mano, dei due isolati di Kansas City concentrati intorno alla 74th e Flora Avenue, illustrato ogni albero da frutta e pergolato di vite piantato da una precedente generazione e ignorato dai vicini nel dopoguerra, che facevano la spesa al supermarket. Avrei cercato di dimostrare che le ciliegie o una pera colte e mangiate mentre erano appollaiate come un uccello sull'albero erano molto piú dolci di qualunque frutto preso al negozio di alimentari. Avrei ricontato gli Hellcat e i Messerschmitt e gli Zero costruiti in legno di balsa e carta che, prima o poi, sarebbero stati portati su una finestra della soffitta e, con l'aiuto di un fiammifero, sarebbero stati fatti partire in un volo planare e infuocato verso terra. Seconda guerra mondiale rivisitata. Io, uno Svengali, avrei aperto per il piccolo P. C. mondi che non aveva trovato su nessuno schermo e che quindi non poteva immaginare.Durante il nostro viaggio in macchina, mentre gli indicavo i quoz del territorio, alzava coscienziosamente la testa dal suo gioco elettronico portatile per guardare fuori del finestrino e dire «Ah», e poi tornare al suo schermo per far evaporare in un etere digitale svariate creature feroci, alcune pelose, altre muscolosissime, e altre ancora macchine impazzite, ma tutte dedite a creare caos. Per viaggiare nel suo mondo, non aveva bisogno di due gambe, gli bastavano un paio di agili pollici. Quindi abbandonammo la strada per tentare un altro approccio: la costruzione manuale. Acquistai un meccano da 176 pezzi con le istruzioni per otto possibili modelli di «Super Flyers». P. C. scelse l'ultraleggero, un aeromobile piccolo e strambo a un solo pilota che un ragazzino di nove anni (o di sessanta) potrebbe meravigliosamente far volare nel sonno. Un'alata macchina dei sogni. Sistemai P. C. a un tavolo. Un'ora dopo tornai per vedere due soli pezzi uniti fra loro e P. C. che lavorava di pollici sul suo schermo video. Le istruzioni per l'ultraleggero erano completamente visive e richiedevano un esame ravvicinato per essere comprese, quindi mi sedetti accanto a lui per una consulenza. In fin dei conti, era il suo primo aeroplano. Tre o quattro bulloni dopo, se la filò in bagno. Quando vidi che non tornava, andai a controllarlo; da dietro la porta sentii un tamburellare di bip e blip dal suono molto acuto e la melodia di Polly Wolly Doodle suonata da quella che sembrava una minuscola giostra di latta. La soluzione (pensai) è fargli vedere un aereo finito per ispirarlo. Quindi presi bulloni e dadi di dimensioni che solo un ragazzino di nove anni riesce a vedere, e per il resto del pomeriggio, strizzando gli occhi, assemblai l'aereo, fino all'elica rotante e alla cabina di pilotaggio dove P. C. poteva immaginarsi a pilotare al sicuro sopra una perigliosa distesa di boschi oscuri o sopra cupi pozzi neri che si trovavano poco oltre il suo letto. Quando lo guardò senza espressione, io, conoscendo l'attrattiva che lo smontaggio esercita sul cervello di un maschio di nove anni (soprattutto uno dedito a divertimenti in cui le cose devono essere vaporizzate prima che ti conquistino), suggerii che smontasse l'ultraleggero per costruire un altro modello, forse il biplano o l'aereo per irrorare le colture. Rispose: - » un sacco di lavoro. Durante la sua visita, tutto quello che ottenni fu una regressione ai miei nove anni, e non alterai affatto il suo progresso verso i suoi studi finali di informatica che portavano a giochi migliori che sperava di progettare. Q chiosò: - Forse un viaggio su un gommone con un gps sarebbe stato una transizione meno radicale -. Il meccano, dissi, adesso è radicale? [...] Dovrei dire, in difesa delle mie affermazioni qui, di riconoscere eccome che i nuovi strumenti hanno smentito millenni di teorie intelligenti ma errate su tante cose, dalle stelle allo stafilococco, e ho un grande rispetto per le macchine (come il telescopio) che hanno portato alla luce le fesserie di tanta teosofia e filosofia. Riconosco anche la possibilità che un giorno i congegni potrebbero rivelare dimensioni dell'esistenza che ora possiamo solo ipotizzare. Ed è certo evidente che le nuove tecnologie hanno bisogno di tempo perché si impari a utilizzarle correttamente. Forse è questo il punto. Faccio un esempio a portata di mano: non sappiamo ancora far sí che la navigazione elettronica ci porti dentro un nuovo territorio piuttosto che semplicemente farci passare attraverso di esso, perché non siamo ancora in grado di distinguere il sapere dove siamo dal comprendere dove siamo. Ciononostante, per me, centosessanta centimetri quadri di pixel non potranno mai restituire lo stesso senso del luogo di quanto possa un metro quadro di cartina stradale, un documento capace di suggerire il luogo di un viaggiatore in un paesaggio piú grande, che abbraccia cuore e anima. Permettere ai whizz-bizzles di creare un analfabetismo geografico - cioè a dire, uno scollegamento tra mente e territorio, corpo e fonti, spirito e suoi desideri - non è forse un uso scorretto della tecnologia? C'è, naturalmente, la possibilità che l'intera infrastruttura vasta, instabile e alimentata a carbonio che sottosta alla costruzione di whizz-bizzles possa da sola mettere fine a queste preoccupazioni meccanicistiche. Se non avessi fallito cosí miseramente con P. C., avrei potuto aiutarlo a scoprire la differenza tra il viaggio virtuale e quello esperienziale, quest'ultimo grande ed eterna metafora del passaggio nel corridoio dei giorni a disposizione di ciascuno, il viaggio piú profondo che intraprendiamo. Per lui, la maggior parte dei luoghi topografici erano solo località da qualche parte là fuori. Non erano niente cui sentisse il bisogno di appartenere. Non riuscii a evocare in lui il minimo riconoscimento di querencia (dallo spagnolo querer, amare), un termine che i vaqueros del vecchio Texas usavano per riferirsi al luogo in cui era nata una vacca di razza Longhorn. Per i viaggiatori, indipendentemente dalla distanza percorsa, una querencia può essere un luogo di riconoscimento e di riacutizzazione. Non sono difficili da trovare: come i collegamenti, si trovano sulla terra come polvere di stelle. E, in un modo o nell'altro, in quei posti ci siamo già stati. | << | < | > | >> |Pagina 438Durante le tempeste invernali, i loro grandi nidi fatti a cupola - alti fino a due metri e mezzo, tra i piú imponenti costruiti dagli uccelli americani, e assolutamente sproporzionati agli uccellini implumi che ci sono dentro - forniscono riparo ad altre creature. E c'è anche un altro regalo che fa la gazza: becchetta via gli insetti dal corpo degli ungulati, e spazza via un ammasso di larve come se fossero, be', una torta.Se la questione è uomo contro gazza, potremmo anche voler considerare chi diavolo è stato ad arrivare per primo sul territorio. La conquista del West da parte degli euroamericani, come sappiamo, è stata un ingresso che non ha lasciato quasi niente com'era: fiumi, praterie, deserti, foreste, il bisonte, i residenti nativi. L'uomo bianco è un Noè che arriva cavalcando il diluvio dei suoi stessi numeri e tecnologie, e dentro la sua arca di specie distruttive e invadenti c'è anche una biblioteca di formulari e alleati per purgare, come un dio infuriato, tutta la carne che offende la sua economia in modo che possa essere ripopolata da specie selezionate per offrire un veloce guadagno monetario. La conseguenza (per continuare l'eloquio da Antico Testamento) è la paura dell'uomo e il terrore di lui in ogni bestia della terra, e in ogni uccello dell'aria, e in tutto quello che striscia sulla terra. Nei secoli dei secoli. Vecchio quasi quanto il racconto della Genesi è il folclore che racconta che le gazze furono gli unici animali a bordo sull'Arca di Noè a rifiutare riparo sotto il tetto durante quei quaranta giorni e notti di diluvio. L'intrepida coppia si appollaiò invece in cima al tetto per fare quark-quark sulla scelleratezza dell'uomo che aveva portato il diluvio e per rivolgere un bel giro di imprecazioni alle città malvagie, mentre il diluvio le sommergeva. Considerando la ragione dell'inondazione, sembrava che le gazze esprimessero l'opinione di Dio. (Nessun animale che mostri di non volere avere niente a che fare con l'umanità venga chiamato stupido). Se è vero che il cambiamento climatico globale produce un innalzamento delle acque costiere, un giorno potrebbero esserci pezzi grossi, magnati, grandi capi e Re Mida di Wall Street e Pennsylvania Avenue, che diranno: «Quelle maledette gazze avevano ragione». Qualche anno fa, mentre dormivo all'aperto tra le basse colline dello Utah settentrionale, venivo svegliato ogni mattina subito dopo l'alba da una decina di gazze o giú di li (una simile congregazione si chiama, appropriatamente, a tidings, che significa «stormo», ma anche «notizie, informazioni»). Il loro incessante chiacchiericcio mi costringeva a svegliarmi, quindi me ne restavo sdraiato ad ascoltare. Miagolando e facendo le fusa, sperimentavano su di me la lingua del gatto di casa; uggiolando e ringhiando, provavano la lingua del cane e del coyote, poi del parrocchetto canoro di qualcuno, poi per disperazione arrivò quello che posso solo descrivere come l'imitazione di un falciaerba acceso. Gridai loro: Accidenti! Sono un uomo! E credo fermamente che una rispose qualcosa che suonò non come un quark-quark ma come un quaqquaraquà! come se stessero ancora commentando dal tetto dell'Arca di Noè. A prova di quella possibilità, offro al lettore scettico l'antica autorità di Plinio il Vecchio, morto osservando l'eruzione del Vesuvio che seppellí Pompei. Nella sua Storia naturale, scrive che le gazze ripetevano le loro parole preferite e poi riflettevano sul loro significato; e, dice lui, se una gazza non riesce a capire una determinata parola, può morire per il disappunto. (Sosteneva anche che le poiane vengono ingravidate dal vento). Se il grande enciclopedico romano è troppo credulone o troppo bugiardo per la nostra visione della natura, resta vero che una gazza appena uscita dal nido - se portata nella nostra società del (per usare la definizione scherzosa di Platone) «genere implume di bipedi» - può eseguire quindici diversi vocalizzi, alcuni dei quali imitano cadenze umane. Una gazza non è un corvo taciturno che non gracchia nient'altro che «Mai piú». Nella nostra epoca, un ornitologo ha dimostrato l'intelligenza delle gazze (che va al di là della loro celebre curiosità e della loro saggia circospezione nei nostri confronti) grazie a un abile esperimento che ha fornito la prova che sanno riconoscersi allo specchio: quando lo scienziato faceva brillare un puntino di luce rossa su una gazza, l'uccello lo scopriva guardando nello specchio ma sapeva che doveva cercare di tirarsi via il puntino di dosso e non dall'immagine. Fate quell'esperimento con il micio piú scaltro che conoscete. Mentre risalivano il fiume Missouri attraversando quello che è oggi il Dakota, Lewis e Clark furono i primi a registrare formalmente l'esistenza della gazza nel Nordamerica. Affascinati dal «corvide multicolore», costruirono delle gabbie con dei bastoncini e spedirono un quartetto vivo di uccelli (insieme a qualche cane della prateria, un altro garrulo residente del West) a valle e poi a est, al Presidente. Una delle gazze - e un solo «scoiattolo abbaiante» sopravvissero ai tremila chilometri di viaggio e alla perdita della loro querencia per diventare le prime creature che portarono una voce vivente delle lontane pianure a Washington. Mi piace immaginare, giocando con la storia, che Clark in questo modo volesse portare al presidente delle notizie parlate dei progressi della grande spedizione: nel suo studio, Jefferson si sporge in avanti per esaminare la gazza che, come un registratore aviario, gracchia quello che le ha insegnato William: «Salve, Tom!» | << | < | > | >> |Pagina 466Ordinammo una sola ciotola di stufato al chili verde da dividerci in modo che piú tardi potessimo prendere qualche fettina di torta. Aspettai la cena gironzolando per il caffè. Ai miei occhi, l'edificio degli anni Sessanta non era né vecchio né pittoresco, ma mostrava una severa onestà. Sulla bacheca degli annunci c'era la solita schiera di biglietti da visita e di biglietti scritti a penna che offrivano perforazioni di pozzi, vendita di bestiame, contenimento dei parassiti, baby sitting (diverse persone), uno di un uomo che voleva comprare corna ramificate, e un altro che annunciava una maratona di tagli di capelli per beneficenza.In un separé, un paio di tosti personaggi di strada, quello piú grosso con un tatuaggio sul polso massiccio che diceva METTIMI ALLA PROVA, sembravano guardare in malo modo il fatto che stessi prendendo appunti, ma non mi dissero niente, e annuirono quando li salutai. (Quando quegli uomini se ne andarono, Q sussurrò: - Dimmi che non c'è un carico di qualche merce di contrabbando nascosto in quel furgone -). Avevano mangiato cheeseburger, e al suggerimento della giovane cameriera di provare qualche torta, avevano scosso la testa. Quando lei era andata via, uno aveva fatto un commento sconcio su un tipo di torta piú fisiologico. Fu quel riferimento, pur indecente, che mi fece pensare alle diverse specie di torte, e sfidai Q a nominarne una dozzina che non fosse sul menú: cosa che fece, anche se mi sentii obbligato a contestare la «torta di braunschweiger». Aggiunsi la torta di cipolle, la torta di anguille, la torta funebre e la torta del tipografo, e lei mi costrinse a descrivere quest'ultima: un miscuglio assortito di vari caratteri di diversa dimensione in cui un addetto alla composizione in difficoltà possa trovare le lettere per completare una storia. Fu lí che compresi la metafora: ci alziamo ogni mattina per cominciare a cercare qualche lettera fra i quadratoni, gli interlinea e i segni di richiamo delle nostre vite in modo da poter comporre un paio di parole o, in una giornata buona, una frase completa che entri nella storia piú lunga della nostra esistenza. La tua vita verrà composta in Bodoni o Times, Garamond o Palatino? Le dimensioni appartengono ai caratteri minuscoli in corpo 6 o a un'élite in corpo 12? Noi apprendisti tipografi nella Grande Tipografia Cosmica dovremmo pubblicare le nostre storie in tondo o in neretto, in caratteri normali o in caratteri gotici, in corsivo o in maiuscoletto? La tua storia è con o senza «grazie»? Se anche il carattere a disposizione è stato usato tante volte per comporre altre parole in altre vite, se è consumato e scheggiato, tuttavia è quello che abbiamo, e cosí, operai a giornata che siamo tutti, componiamo le nostre storie che potremmo pubblicare nella speranza che non finiscano troppo presto tra le mani del pescivendolo che ci avvolgerà il pesce. Nel costruire qualunque cosa - un libro, un abito, un viaggio - non tutti gli articoli possono essere usati in maniera proficua, perché alcuni pezzi non sembrano entrare prontamente nella forma a portata di mano. In un'epoca piú frugale, i caratteri trascurati e gli scarti non venivano gettati ma finivano nella, cosí chiamata, cassetta del diavolo, un'espressione usata dagli stampatori, dai sarti, e dai fabbricanti di quilt vecchio stile. Io discendo da una simile stirpe, e due li avete già incontrati: la prima moglie dell'assassinato William Grayston, che in seguito divenne una sarta da uomo sul confine del Territorio Indiano; e ricorderete anche la bisnonna che si deliziava nel fare quilt con il disegno dei piedi vagabondi. Forse qui un lettore attento dice: «Ma ci arrivi o no alla torta di sottaceti?» Molto bene: la sua crosta si sfaldava. E qui, un cronista che cerca la precisione si deve fermare, perché descrivere un sapore con esattezza non è possibile piú di quanto non si possa scrivere il decimale finale di un numero trascendente. Le sensazioni gustative semplicemente non possono trovare una facile traduzione in parole, ed è strano che due funzioni della lingua umana siano cosí inefficaci una per l'altra. Per parlare di un sapore, dobbiamo farlo in maniera obliqua, impressionistica, metaforica, comparativa. A qualcuno che non ha mai conosciuto il dono della vista, forse potrei comunicare l'aspetto di una mela, ma a una persona che non l'ha mai assaggiato, non potrei descrivere il sapore neanche di qualcosa di semplice come il sale. Struttura, consistenza, temperatura, e la reazione personale di ciascuno («Delizioso!», «Terribile!»), non comunicano il sapore. Descrivere l'aroma dei cibi è acrobazia verbale. Io posso, però, quando si tratta di torta ai sottaceti, darvi qualcosa di notevolmente accurato e utile: posso passarvi la ricetta di Cula Ekker, cosí come veniva servita al Sunglow Family Restaurant [...] | << | < | > | >> |Pagina 493Il vecchio marinaio, con il naso ustionato dal sole che dimostrava tutti i suoi sette decenni sull'acqua accecante, disse: - Non credo che ci sia niente come questa costa protetta quanto a estensione - per non parlare del paesaggio - nel resto del mondo. Voglio dire, tutto il percorso, Boston attraverso il canale di Cape Cod, per proseguire dietro Long Island, e fin giú al Texas meridionale. Viene usato a sufficienza, probabilmente, perché continuino a tenerlo aperto, ma non abbastanza perché finisca per intasarsi -. (Credo che avesse ragione: l'Inside Passage da Seattle all'Alaska è lungo solo mille e cinquecento chilometri, e l'interno del Great Barrier Reef in Australia lo supera solo di qualcosa come trecento chilometri). - C'è un po' di mare aperto sul Golfo in Florida, e quel percorso interno lungo la costa del New Jersey è adatto solo a barche di scarso pescaggio, - disse; - ma se il governo risistemasse il canale Delaware-Raritan che attraversa l'istmo del Jersey fino a Trenton, quei chilometri in mare aperto nell'Atlantico non servirebbero nemmeno.Mi guardò per valutare il mio atteggiamento, poi aggiunse: - Diamine, il Genio militare non può - o non vuole - tenere neanche questa parte inferiore dragata decentemente, quindi non credo che ne aggiusterà un altro tratto. Ma di certo potrebbero se non fossero impegnati all'Ovest, a tirar su dighe in tutti i ruscelli. Quindi, senza piú valutare me ma il suo cocktail, riprese: - E i soldi per la manutenzione ci sarebbero eccome se quel Bush non stesse cercando di disfare diecimila anni di storia del Medio Oriente per coprire i soldi che sta fregando ai contribuenti. La gente da queste parti sostiene Bush, ma non ha idea di quanto quella guerra gli costi a livello personale. I pescatori di professione si lagnano dell'insufficiente manutenzione del canale, e nel frattempo sul retro dei loro pickup attaccano magneti con scritto SOSTIENI IL COMANDANTE. Nel momento in cui riporto questa conversazione, la guerra di Bush stava costando agli americani tre miliardi di dollari alla settimana - circa quattrocento milioni di dollari al giorno. Questo significava che il denaro sufficiente a rimettere in sesto l'Intracoastal Waterway veniva speso tra le sabbie del deserto piú o meno nel tempo che ci si impiega a lavarsi i denti e fare i gargarismi. Lascio a te, sagace lettore, il compito di riflettere su altri pezzi di America lasciata andare in malora o a rischio che si potrebbero ripristinare con diciassette milioni di dollari l'ora. Inoltre, il tuo progetto, qualunque esso sia, probabilmente non comporterebbe quattromila - e il conteggio non è ancora finito - caduti americani e centomila o piú iracheni. | << | < | > | >> |Pagina 511Un tempo città di lavorazione del pesce, Beaufort si era riqualificata con il turismo e gli yacht. Il pesce era principalmente l' Atlantic menhaden, ossia il Brevoortia tyrannus, un'aringa lunga circa trenta centimetri pescata intensivamente per trasformarla in molti prodotti o usata come esca nelle trappole per i granchi. I menhaden vengono chiamati in altri modi, a seconda di dove li si peschi sulla costa atlantica: bugfish, hardhead, fatback, greasetail, yellowtail, alewife, mossbunker, pogy, shad. A Beaufort, negli anni passati, si sviluppò una stratificazione sociale intorno al menhaden, un sistema tutt'altro che sorprendente nel quale gli uomini afroamericani (perlopiú) portavano il pesce alle donne nere (perlophi), che lo lavoravano; i capi e i proprietari erano bianchi (interamente). Ma la riduzione del menhaden pescato - piú che altro perché se ne prendevano troppi -, l'irrigidimento delle normative ambientali, e lo spaventoso aumento delle imbarcazioni da diporto, serví, in una certa misura, a unire queste classi sociali e a ridefinire la divisione del lavoro tra loro e i nuovi venuti. Ma se gli elementi razziali erano cambiati, le questioni di libera impresa contro sostenibilità, proprietà contro lavoro, ricchezza contro welfare, rimanevano.[...] Dirigendoci al Bog Trotter, vidi un manifesto che pubblicizzava il Festival Barbanera, una commemorazione del pirata che aveva usato Beaufort come ancoraggio per la sua tristemente nota nave ammiraglia, la Queen Anne's Revenge. Nel mio stato natale si festeggia Jesse James, e altrove nel paese mi è capitato di imbattermi nella Festa di Dillinger, nella Festa di D. B. Cooper, in una tavola calda che onorava il cannibale Alfred Packer, e in una gara di estrazione e tiro rapido dedicata a Billy the Kid. Se una svendita perché gli affari fanno schifo non basta, cosa può fare una Main Street se non rendere gli onori alla malvagità e convertire i marosi della storia in qualche dollaro sonante? Mentre la barca scendeva lungo la costa e si inoltrava negli ex rifugi paludosi dei pirati dell'inizio del XVIII secolo - gli storici locali la chiamavano l'«Epoca d'Oro della Pirateria», che solleva la domanda se i nostri discendenti un giorno si riferiranno nostalgicamente all'«Epoca d'Oro del Terrorismo» - gli emblemi contemporanei del piratesco diventarono via via piú evidenti: magliette che ritraevano furfanti con l'occhio bendato o facevano sfoggio di qualche aforisma (CONSEGNA IL BOTTINO), ristoranti con nomi come Covo dei pirati, AARRHH inciso a lettere malferme su un molo, e bandiere col teschio e le ossa incrociate che svolazzavano su yacht di lusso. (Quest'ultima manifestazione può apparire assurda solo se uno non considera dove i recenti predatori di piani pensione, conti di risparmio per l'università e pensioni di reversibilità hanno speso un po' del loro bottino: e il tutto senza mai toccare né sciabola né moschetto). [...]
Ero al mio punto d'osservazione preferito sul
Bog Trotter,
una nicchia a poppa riparata dal vento, un trespolo sopraelevato spesso
frequentato da un bel gruppo di gabbiani ridanciani elegantemente
aviotrasportati e dolcemente graziosi finché sulla nostra scia
non spuntava qualche bocconcino; allora scoppiava un vero inferno aereo mentre
gli uccelli si tuffavano a cercare quello che credo
fossero dei pescetti storditi e portati in superficie dalla scia laterale
dell'elica. Può essere stato quello sciamare che ha associato i
gabbiani all'avidità. Una volta riempitisi, gli uccelli ridacchiavano
verso la costa,
Ah-ah-ah-ah-ah-ah,
una risata piú finta che gioiosa,
i gabbiani satolli ridevano per tutto il percorso fino alla riva, e là
si appoggiavano a un palo di attracco o all'albero di uno yacht e lo
spruzzavano abbondantemente di pesce digerito.
|