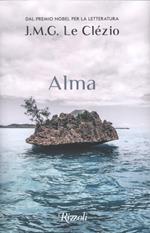
|
|
|
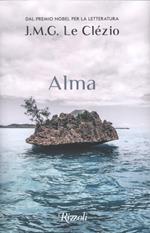
|
|
|
| << | < | > | >> |Pagina 9Chissà se formano una famiglia, un popolo. Chissà se sono reali. Sono dentro di me fin dall'infanzia, fluttuano e mi svolazzano intorno come farfalle impazzite, alcuni li conosco da quando comprendo il linguaggio, nomi infilati incidentalmente nelle conversazioni, da mio padre, dalle mie zie, da mia madre benché estranea a tutto ciò, altri incontrati nelle mie letture, sulle pagine interne del «Mauricien Cernéen» che mio padre riceveva ogni settimana e di cui impilava i numeri su uno scaffale, accanto ai suoi libri di economia e alla collezione dell' Encyclopaedia Britannica, altri ancora sbirciati sulle buste delle lettere, o sul retro delle foto. L'origine dei nomi è quel libricino rilegato in pelle marrone, contemporaneo di Axel Thomas Felsen, che si trovava sull'ultimo scaffale della biblioteca e che, da bambino, ho letto come se fosse una specie di guida telefonica del vecchio secolo: Oltre all'orario delle maree e all'elenco degli uragani, quel libro conteneva l'inventario degli abitanti dell'isola, abbastanza simili ai passeggeri di un'enorme zattera di pietra - è vero, tutti un giorno o l'altro venuti dal mare, su questa o quella nave - ancorata nel mezzo dell'oceano Indiano, in un mare dove si confondono le correnti antartiche, il flusso continuo dell'Atlantico meridionale al largo dell'Africa, le acque tiepide dell'Insulindia e le lunghe onde provenienti dalla costa occidentale dell'Australia. Qui, su quest'isola, si sono mescolati tempi, sangui, vite, leggende, le avventure più celebri e gli istanti più ignoti, marinai, soldati, rampolli di buona famiglia e, anche, contadini, operai, domestici, senza terra. Tutti questi nomi che nascono, vivono, muoiono, continuamente sostituiti, portati di generazione in generazione, una schiuma verde che ricopre uno scoglio semiemerso e scivola verso una fine tanto imprevedibile quanto inevitabile. | << | < | > | >> |Pagina 13Dodo. Such a dodo. Ahah, mi pare di sentirli! ╚ quello che dicono sempre. Mamma, Papà, perché non dite niente? Non dite mai niente. Ve ne infischiate. Non devi badarci, lascia correre. Sono cattivi, invidiosi. Se insulti sputi su te stesso. Lasciali perdere, ignorali. Cancellali. ╚ facile, basta che chiudi gli occhi, che chiudi la bocca e svaniscono nel buio. Sono macchie, non serve il sapone, non serve strofinare, se ne vanno, non serve l'acquà. Basta che chiudi le palpebre, chiudile strette, appoggiaci i pugni e premi, le palle sprofondano, fanno scintille. Mi piace. Artémisia, la vecchia nénéne, è quasi cieca, vede le scintille. Me l'ha detto lei. Che cosa vedi, nénéne? Che cosa vedi con quei tuoi occhi azzurri nella faccia nera? Delle scintille, pikni. Vedo delle scintille, nient'altro. Artémisia che mi ha dato il suo latte. I suoi seni adesso sono flosci, pendono sulla grossa pancia. Come una camicia grigia. La faccia però è nera e liscia, mi piace sempre passarle le dita sulle guance. Mo piti noi', mo pikni. Lo dice piano piano e io chiudo gli occhi per vedere quello che vede lei, nient'altro che nero, un po' di rosso ai bordi, le ombre delle foglie che si agitano al sole. Ha solo me. Sua figlia Honorine, le sue nipoti, i suoi nipoti non ci vengono, a trovarla. Si vergognano di lei, si vergognano perché è stata la nénéne dei Laros, dei Fe'sen, schiava, dicono, perché è en' godron, di catrame, nera nera, ma io le voglio bene, la pelle delle sue mani è morbidura, consumata, rosea, senza rughe, non ha mai avuto né linea della vita né linea del cuore, tutte quelle linee che le bambine hanno sulle mani. Mamma Laros è morta, ma lei, Artémisia, è ancora qui. Tu non morirai, vero, Artémisia? Chiunque pé mouri, Dodo. Ma tu no, Artémisia, tu mica muori. Mi piace quando ride, ha tutti i denti bianchissimi, perché mastica sempre un bastoncino di liquirizia, anche se fuma delle sigarette che puzzano. ╚ grassa, fa fatica a muoversi, ha le gambe gonfie, i piedi coperti di piccoli tagli che non guariscono, ci si appiccicano i moscerini. Mi piace toccare i suoi vecchi seni, mi danno il latte quando rischio di morire, perché Mamma non ha latte, le tocco i seni e dico: questo è mio, e anche questo. E la fa ridere. Mi dà una sberla sulle mani borbottando, ma si diverte. Artémisia conosce tutti gli indovinelli, soprattutto quelli un po' volgari, quelli che non si raccontano ai bambini, quello che fa: Vent' contre vent' ti bout' dans labouce, bébé tète sa maman, oppure quello che mi fa sempre ridere, ki li pli piti ki li ki li poupou, cosa c'è di più piccolo del culo di un pidocchio, e la risposta: dard so mÔle, il pungiglione del suo maschio. Perciò sua figlia Honorine non viene spesso a trovarla. Honorine è pentecostale. Odia tutti i Fe'sen, vorrebbe vederli sparire all'inferno. Adesso Mamma Laros, Papà e la vecchia Artémisia sono morti. Resto solo io. Ma io non sono un Fe'sen, un Coup de ros. Io sono Dodo, nient'altro. Per questo Honorine mi accoglie a casa sua e mi fa dormire su un materasso per terra, accanto alla porta, come un vagabondo senza casa. | << | < | > | >> |Pagina 34Prima di notte sono nei pressi della Mare aux Songes. Ho fatto fatica a trovarla, nonostante le mappe. Ho dovuto risalire una forra invasa dalla sterpaglia, superare un bosco di ebani e tamarindi. Lungo uno stretto sentiero di terra battuta, segnato dalle gomme di un trattore. Cercavo il colore dell'acqua. Quanto alla palude, c'è solo un'arena d'erba e canneti, circondati dalla foresta. ╚ qui che nel 1865 un certo Roy, caposquadra nella proprietà del signor Gaston de Bissy, scoprì casualmente le prime ossa, mentre faceva scavare la palude allo scopo di prelevarne blocchi di limo da utilizzare per la piantagione. Cubi di terra nerastra, argillosa, mescolata a vegetali in decomposizione. I lavoratori indiani avevano un foulard annodato sulla bocca per non respirare le esalazioni mefitiche. A quel tempo nella palude c'era ancora dell'acqua, gli operai avanzavano a piedi nudi, vestiti soltanto di un perizoma, con la pelle nera che grondava sudore. I primi resti apparvero subito, uno degli operai diede l'allerta: «Missié, ena les os ici, Missié Roy». Portò alcune zolle con le ossa che affioravano bianche dalla terra nera. Roy esaminò i resti, individuò lo scheletro di un uccello, ma enorme, incredibile, una carena, delle costole, le vertebre del dorso. Poi vennero le ossa delle zampe, talmente massicce e lunghe che non poteva essere il corpo di un uccello di mare, un albatros disperso lì in seguito alla tempesta. Dopo essere state sciacquate con l'acqua dolce di un bidone che i lavoratori avevano portato per bere, le ossa rivelarono un colore strano, un nero venato di blu che contrastava con il biancore delle costole, il colore di un animale molto antico, estinto da secoli. Steso sull'erba in riva alla palude, lo scheletro brillava di una luce misteriosa, quasi sinistra. Gli operai si assieparono e rimasero a guardare senza capire. Allertato da Roy, Clarke, il maestro di scuola che esplorava la costa di Mahébourg, arrivò in calesse neanche un'ora dopo la scoperta. Intorno alla palude, i blocchi di loess e di torba si erano essiccati e sembravano lapidi. Al riparo di un telo che sbatteva al vento sedevano Roy, Gaston de Bissy e alcuni degli operai. Gli uomini aspettavano l'ordine di rimettersi al lavoro per analizzare il limo, ma con ogni evidenza l'apparizione dello strano uccello uscito dagli abissi aveva interrotto le attività profane. «Mio caro» annunciò Clarke, «quello che hai riesumato è semplicemente Raphus cucullatus, l'antenato dell'isola, il famoso dronte, o dodo che dir si voglia.» Si era inginocchiato come davanti a un ossario, manipolava le lunghe ossa con cautela, le spostava e ridisponeva in un ordine diverso affinché comparisse lo scheletro dell'uccello gigante, steso a terra, come fosse appena scivolato nel sonno eterno. «Peccato che gli manchi una parte della testa e la mascella inferiore, il tuo esemplare non avrebbe niente da invidiare a quello di Amsterdam o di Oxford.»Informatosi sul luogo preciso in cui l'operaio aveva dissotterrato le ossa, Clarke, senza alcun riguardo per i pantaloni di cotone bianco, entrò nella palude e si mise a scandagliarne il fondo con una pala. Un attimo dopo, la pala riportava in superficie un pezzo di fango a forma di palla appiattita che, lavato, pulito, asciugato, si rivelò essere una calotta cranica culminante in un becco enorme, pesante, scintillante anch'esso di quella sfumatura nero-blu degli abissi. Clarke, visibilmente commosso, posò la testa in cima alla fila di vertebre e così, per la prima volta, alla luce cruda del sole di mezzogiorno, apparve il corpo perfettamente disegnato di un uccello mostruoso e familiare, accoccolato su due zampe culminanti in tre lunghe dita dotate di artigli, insieme morto e tornato alla vita, probabilmente da sempre in attesa di questo momento. «Se penso che per una vita l'ho cercato sulle montagne e lui era qui, a due passi dal mare.»
Nei giorni che seguirono, la Mare aux Songes fu teatro di
una vera e propria frenesia. Gli operai indiani, i padroni, i curiosi del
vicinato entravano in acqua, talvolta fino alla cintola,
a piedi nudi per sentire meglio le asperità delle ossa nascoste
nel fango del lago.
Sulla foresta è scesa la notte. Non ho saputo decidermi ad allontanarmi. Ho cercato un riparo lungo la strada sassosa che conduce alle rovine dello zuccherificio e al forno a calce. Ho riattraversato le canne verso un bosco di acacie. Adesso la riva è molto vicina, una costa scoscesa, il mare senza barriere, sento distintamente il fragore delle onde che si frangono sulle rocce nere. L'uccello gigante non dev'essersi avventurato fin qui, ogni gravina, ogni forra è una trappola. Nonostante il vento l'aria è soffocante, satura di umidità. Il Souffleur sputa a intermittenza un getto di vapore iridato, con un rumore d'inferno più che di lido esotico. Gli unici uccelli presenti sono degli albatros portati dal vento e diretti a fior d'acqua verso la baia di Mahébourg, stormi di cormorani. In un'insenatura guardo il mare scuro, chiazzato di schiuma. Un po' prima di notte un cargo transita al largo, lungo l'orizzonte, poi s'immobilizza, appena rischiarato da un fanale che lampeggia a prua, e mi ricordo di quanto raccontano, di questi portacontainer cinesi o indiani che scaricano i loro liquami al largo di Mauritius, senza temere rappresaglie. Penso ancora al dodo, forse gli accadeva di correre sulla riva, con le ridicole piume della coda sollevate dalla burrasca. ╚ qui, mi sembra, che la nave ammiraglia olandese si avvicinò alla costa, cercando il passaggio per accedere alla grande baia di Sudest, e per la prima volta l'uccello capì che la sua vita volgeva al termine, e che non ci sarebbe più stato niente da fare in un mondo in cui i diavoli armati di tromboni e randelli li avrebbero ammazzati a centinaia, finché di loro non fossero rimaste che le ossa. Un mondo in cui a breve le spiagge di sabbia bianca sarebbero state disseminate di piccole palle viscide e nere, in cui le onde venute dall'altro capo del mondo avrebbero portato con sé sacchetti di plastica e vecchie bottiglie in quantità. O forse non ha capito niente, non ha immaginato niente, e la natura impietosa ha fatto il resto. | << | < | > | >> |Pagina 45La primissima volta che ho visto Krystal è stato al campement di Dong Soo. La finestra del bagno della pensione la Roche aux Mouettes dava sul giardino del cinese e sul retro del campement, dove c'è la camera da letto. ╚ un appartamento che si affitta per periodi di un anno, così mi ha detto la proprietaria, la vedova PÔtisson. Pare che i piloti di linea preferiscano soggiornare qui anziché all'albergo dell'aeroporto, perché è più calmo, dicono. In realtà vengono dal cinese perché nessuno dice niente se ci portano le puttane. Negli alberghi, il portiere allunga sempre l'occhio. Se c'è modo di ricattarli non ci pensa due volte. Scatta foto di nascosto e informa la famiglia del pilota. Il cinese è più discreto, anche se la ragazza è minorenne. Li ho visti dalla finestra del bagno. C'era questo tizio, quarant'anni portati male, un po' calvo, nel suo abito da pilota blu marino. Fumava, in piedi sul tappeto verde spelacchiato, guardando vagamente il mare. A un certo punto sono arrivate due donne, due creole in jeans e maglietta, le infradito ai piedi. Una aveva già una certa età, era appesantita, ma guardando meglio ho capito che era un'adulta e l'altra, molto giovane, era quasi una bambina. Quella vecchia ha parlato un attimo con il pilota e la ragazza si è un po' allontanata. Mentre la donna parlava al pilota, ho notato che la ragazzina giocava a prendere a calci un pallone di plastica sgonfio, lo colpiva in modo meccanico e il pallone sbatteva contro il muro della casa con un flop! snervante, ma lei continuava senza guardare gli altri. A un certo punto la vecchia si è voltata verso di lei e le ha gridato qualcosa in creolo, per dirle di smetterla. Poi ha ripreso a discutere con il pilota, che l'ascoltava con aria annoiata. La ragazza era molto giovane, ma non più una bambina. Aveva un viso tondo, due occhi grandi, ma il corpo era già lungo, dinoccolato, le gambe magrissime e le braccia sproporzionate, e soprattutto si atteggiava, la punta del piede contro il pallone sgonfio, un fianco leggermente sbilanciato, guardando la vecchia e il pilota con la coda dell'occhio, l'aria sorniona. Era una situazione strana, un po' equivoca, non riuscivo a staccarmi dalla finestra, a distogliere lo sguardo da quella ragazza. A un certo punto credo che mi abbia visto, attraverso i listelli di vetro della finestra del bagno, o forse ha sentito la mia presenza perché mi ha voltato le spalle e se n'è andata verso sinistra, ma sporgendomi contro i listelli mi sono reso conto che si era appartata, che mi spiava anche lei! Ho sentito il sudore scorrermi sulla schiena, il cuore ha iniziato a battere più forte, forse mi sentivo colpevole di qualcosa, avvertivo addirittura una vaga rabbia per esserci cascato. La donna di una certa età se n'è andata, ho visto che infilava qualcosa nella borsetta, non ho fatto in tempo ad accertarmene, perché la mia attenzione era concentrata sulla ragazzina, ma in seguito ho pensato che avesse ricevuto delle banconote, che fosse quello che aveva nascosto nella borsetta. Il pilota ha spento la sigaretta, è andato verso la ragazzina che aspettava all'angolo della casa. L'ha raggiunta, l'ha baciata, era alto e robusto, contro di lui lei sembrava un fuscello scuro. L'ha tenuta stretta per un po', ho visto che le aveva affondato la faccia nei capelli, respirava il suo odore, forse le diceva parole dolci. La ragazza aveva molti capelli nerissimi, ricci, che le coprivano le spalle e il viso, e il pilota ci passava le mani, li aggrovigliava, le accarezzava la nuca e le spalle con movimenti circolari delle dita. Poi si sono staccati e hanno camminato insieme, lui davanti e lei al seguito, sono entrati in casa. Prima di entrare l'uomo si è tolto la giacca da pilota ed è rimasto con una camicia azzurra a maniche corte e una cravatta nera. La ragazzina allora si è girata verso la mia finestra, per dirmi che mi aveva visto, che sapeva che ero ancora lì. Il sole batteva da destra, non sono riuscito a distinguere la sua espressione, tanto più che le ciocche nere si agitavano al vento nascondendole parte del volto. Eppure sono sicuro che ha sorriso, anche se il suo sorriso non posso dire di averlo visto. ╚ un'impressione che ho avuto, giusto per una frazione di secondo, un raggio che balena e svanisce. Un sorriso beffardo, forse, o provocatorio, non so, qualcosa di penetrante e crudele, di triste, anche, di mortale. | << | < | > | >> |Pagina 51Vivo sempre la stessa giornata. Non so come sia possibile, ma è così. Lo dico a padre Labat, a Bonne Terre, ma lui non capisce. Scherza: «Siamo tutti nella stessa barca, Dodo. Il sole sorge, tramonta, e ogni giorno è lo stesso tran tran». Parla di radersi ogni mattina, poi si interrompe: «Tu evidentemente non ti rendi conto della fortuna che hai!». Perché a me, la malattia che mi mangia la faccia si mangia anche tutti i peli. Cerco di spiegargli: «Padre, non è questo. ╚ che la mia giornata non finisce mai, è una strada senza fine, non vedo arrivare la notte, non dormo, ed è già mattina». Lui mi guarda senza rispondere. Lascio Bonne Terre e cammino fino al cimitero Saint-Jean. ╚ il momento buono per andare al cimitero, perché il sole picchia e nei viali non c'è nessuno, non c'è neanche Missié Zan, quel gran bastardo che mi ruba i soldi e non fa uno straccio di manutenzione sulla tomba di Papà e Mamma. Sono andato a trovare i miei vecchi. Casa loro è in fondo al viale o, vicino al grande cipresso. ╚ un angolo tranquillo, la maggior parte delle tombe sono lasciate in abbandono. Le pietre sono rotte, in mezzo cresce l'erba, alle stanghe arrugginite si impigliano addirittura dei sacchetti di plastica nera portati dal vento. Leggo i nomi sulle tombe, quelli che sono ancora visibili. Rapha, Lhomme, Laville, Pernety, Astruc, Laventure, Meudhy, Chalandon, Hélène de Renéville, Rappoteau, Ferdous, Salaun, Barbot, Thion, Augier. Dove sono adesso? Chi si ricorda di loro? Chi viene a trovarli? A Palma, a Quinze Cantons, a Quatre Bornes, a Cailloux, a Rose Belle, tutto gira, tutto scorre senza sosta. E Yaya, la vecchia Yaya che mi ha portato in braccio quando sono nato, dov'è la sua lapide? Qualcuno ha scritto il suo nome da qualche parte? Non è a Saint-Jean. Non è da nessuna parte. Non esiste. Quando è morta io sono piccolo, mi ricordo di lei, scaviamo una buca nella terra nei pressi di Crève Coeur, accanto al mango, piantiamo una croce di legno senza nome, lei è figlia di una schiava, non ha diritto a una lapide, e la croce è caduta durante un ciclone, e sul mucchio di terra sono cresciuti gli sterpi. Non è più da nessuna parte tranne che nella mia testa, Yaya con il suo lungo vestito senza colori, con il suo foulard a fiori per nascondere la calvizie, con le sue collane di semi, i suoi cauri, i suoi amuleti, Yaya così robusta e pesante che ci vogliono quattro uomini per sollevarla dopo che è stramazzata a terra morta nel suo campo di cipolle. Yaya che conserva per me in un barattolo dei pezzi di zucchero rosso, dei biscotti di manioca di Rault, dei bastoncini di liquirizia. Yaya che fuma delle sigarette di gangia dolci e zuccherate, e che si addormenta per terra all'ombra del suo mango. Con due pietre e un pezzo di tela, tra le radici dell'albero, costruisce una casa per i suoi antenati africani, per la sua nonna ragno e il suo nonno soursouris. La sua grande bocca violacea si arrotonda e canticchia delle melodie per addormentarsi, per me, per sé, piano piano, mi sdraio per terra contro il suo fianco, di pomeriggio, e fa caldo e c'è afa, con quegli stridii di zanzare nell'orecchio, e la sua grossa mano agita un setaccio di paglia per rinfrescarmi. Racconta, Yaya, raconte zistoire Topsie, raconte zistoire Saklavou. La sua voce è bassa, rauca, perché fuma e beve come un uomo la sua bottiglia di arak. A me piace sentirla, la sua canzone è tutta per me, me la ricordo ancora, anche qui, così lontano dalla sua capanna, dal suo albero e dal suo campo di cipolle. Racconta di Topsie, il suo antenato, arrivato un giorno d'inverno dalla Grande Terra, sul veliero che veniva dall'altra parte del mare, lontano lontano. La sua grossa mano ruvida mi accarezza i capelli, ho ancora i capelli coton ma´ ricci, è prima che la malattia mi mangi la testa e bruci i capelli, lei racconta zistoire Topsie, lui è arrivato al pays Moris, e ha così paura che galoppa per il giardino di Alma, ha così paura che lo mangino, i bianchi cattivi mangiano i piccoli neri, che corre per il giardino e si arrampica in cima al baniano, e per tutto il giorno fino a notte rimane appollaiato lassù, hanno un bel dirgli vieni, vieni Topsie, nessuno ti mangia, lui non ne vuole sapere di scendere, allora vanno a prendere la grande scala e lo riportano a terra. Zistoire Topsie è anche la storia di Yaya, quando è bambina Topsie c'è ancora, vecchio vecchio e con i capelli bianchi, ogni tanto le parla della Grande Terra, degli alberi e dei fiumi, dei paesi e dei campi laggiù, e della terra che è rossa perché è mescolata al sangue. [...] Alma, Alma mater, dice il mio papà per ridere, dice spesso che gli zuccherifici a Mauritius sono come delle grosse scrofe che allattano molti maialini rosa, perché gli azionisti sono tutti dei bianchi con la pelle rosa rosa, e ogni maialino poppa avidamente dalle mammelle di mamma scrofa, bevono il suo latte fino a non poterne più, belli grassi e satolli, e si addormentano vicino alla madre e la madre dimagrisce e si sfinisce a sfamarli. E intanto agli operai arrivano solo le briciole, gocce di latte della scrofa, guardano lo spettacolo della porcilaia con la bocca asciutta e le mani contratte per la rabbia, tutti neri e affamati, guardano questi bei maialini rosa che dormono contro la madre, con la bocca semiaperta da cui cola un filo di latte. Alma non è mia madre, non ho mai bevuto il suo latte, ho bevuto il latte di Artémisia, e ho dormito contro la pancia di Yaya, ma non sono arrabbiato con Alma. Al contrario, amo la sua terra, amo i suoi ruscelli e i suoi alberi, amo quello che non appartiene a nessuno, anche mo che è tutto in rovina, con i sentieri invasi dalle erbacce e i recinti intorno alle paludi. Conosco tutte le strade che portano ad Alma. Cammino in mezzo a canne più alte di me, do la caccia alle tortore. La terra è rossa, il cielo è azzurro, ci sono palle di nuvole spinte dal vento, ogni tanto una nuvola nera scoppia e mi scarica addosso una manciata di gocce, pizzicano come sassolini. Mi ricordo che un tempo cammino, con le mani nelle tasche per non tagliarmi con le foglie. Ascolto gli operai che gridano, ahouha! ha!, con il lungo coltello in mano, ascolto il rumore delle lame che falciano le canne. Non abito vicino alle canne, casa nostra è vicino al villaggio degli operai, non ho il permesso di camminare sulla strada della fabbrica, perciò conosco tutti i piccoli sentieri, dalla grande palude fino alla ferrovia. Mi avvicino alla proprietà, supero il ruscello e la siepe di bambù, mi arrampico sul piccolo muro di pietra e lì è l'entrata del paradiso terrestre, la grande casa Fe'sen, le file di ašaí, i grandi alberi scuri, le vasche, le aiuole di fiori. La capanna di Yaya è in fondo al sentiero, vicino alle ex scuderie, buia e umida, c'è odore di fumo e dí escrementi, Yaya non ha neanche il gabinetto, fa la cacca in un buco in mezzo agli alberi, poi ci butta sopra delle foglie secche e della terra, io ho paura di andarci, un giorno trovo un grosso rospo in fondo al buco che mi guarda con i suoi occhi gialli e me ne scappo di corsa. Però il maledetto giorno in cui gli Armando rompono la casa di Artémisia io ci sono. Lei quel giorno è malata, è andata a Saint-Pierre per comprare delle medicine, e in sua assenza il bulldozer arriva e spiana la capanna con tutto quello che c'è dentro, il letto di Artémisia, i mobili di Artémisia, le sue stoviglie e i suoi vecchi vestiti. E io sono nascosto dietro i cespugli, nel sottobosco, guardo il bulldozer che avanza e spiana, sento le grida dei vetri rotti, fanno il rumore delle ossa che si spezzano, povera Artémisia, le sue ossa e i suoi denti, i suoi bicchieri e i suoi piatti, le bacheche dove fa vedere le foto dei suoi nipotini e anche la foto di lei che ha fatto Papà, io sono piccolo seduto sulle sue ginocchia, il bulldozer si ferma, gli corro incontro, grido, grido anch'io: «Cattivi! Cattivi!». Ma all'operaio fa solo ridere, quel piccolo bianco che corre e strilla con la sua voce di passero, mi lancia dei semi di zucca come se non fossi altro che uno zako, una scimmia della foresta di Macchabée, mi dice: «Ti rat blanc!». Dopodiché Artémisia non torna mai più, rimane a Saint-Paul, da sua figlia Honorine, ed è lì che abito perché non so dove andare a dormire. | << | < | > | >> |Pagina 67Ritrovare le tracce, pressoché impossibile. Oppure sognare. Tornare ai primordi, quando l'isola era ancora nuova, nuova all'umano, dopo milioni di anni di pioggia, di vento, di sole. Dopo i terremoti, le colate laviche, i maremoti, i diluvi, le glaciazioni. Cercare le grotte, un terreno acido non prevede ossa. La foresta, quel che ne rimane. La prima volta chg ho incontrato Aditi, all'ufficio del Mauritius Wildlife Fund, mi ha mostrato la carta dell'isola. Nel 1796, anno in cui Axel Felsen sbarca sull'isola di Francia con la famiglia, la foresta ne ricopre i nove decimi. Nel 1860, quando i Felsen partecipano all'era industriale, nelle piantagioni di tabacco (non tutti sono zuccherieri), restano ancora alcune sacche di foresta endemica, sulle alture, intorno alle gole della Rivière Noire, a Chamarel, forse a Deux Bras. Oggi, più niente. Qualche briciola, qualche lembo strappato, chiuso da recinzioni, tagliato dalle strade. Seduti su una roccia, sul bordo della pista di laterite, con Aditi immaginiamo quel che hanno visto dal ponte delle loro navi - i tuoi antenati - dice Aditi, perché i miei viaggiavano nella stiva, fino alla porta che li conduceva alla luce accecante del molo e ai carretti che li portavano sul luogo di lavoro. I tuoi: van West-Zanen, sul ponte dell' Enkhuizen, Cornelis Matelief, Pieter Both, dal cassero della Wapen van Amstelredam, e Thomas Herbert, dal ponte dell' Hart. Oppure i marinai della Gelderland, quando hanno posato i piedi nudi sulla sabbia morbida di Tamarin. I dodo erano ovunque! Sagome sulle coste rocciose - al tempo gli esploratori credevano di vedere dei pinguini -, curvi come vecchietti tra gli arbusti spinosi, in cerca di semi, e i loro sederi tondi promettevano a quegli stomaci affamati deliziosi strati di lardo, da fondere nei mastelli, da spalmarsi contro le bruciature del sole e del sale. Così parlava Willem van West-Zanen nei suoi umili versi:
Gli uomini qui si nutrono della carne fresca di creature pennute
della linfa delle palme e del tondo sedere dei dodo
allevano i pappagalli affinché pigolino e strillino
e gli altri uccelli vengano a farsi ammazzare a colpi di randello!
Ogni tanto Aditi va negli uffici del Mauritius Wildlife, a Curepipe, dove io copio delle carte, è lì che ci siamo parlati. In seguito ho capito che ha un segreto, è incinta di un bambino senza padre, rifiuta di sposarsi con uno qualunque e la sua famiglia l'ha messa alla porta. Da allora vive nella foresta. Non c'è guida migliore di lei. Aditi mi mostra il sentiero per la Mare Longue. Diventa stretto, fangoso, la foresta si restringe, più che una foresta, macchie di boscaglia. Gli alberi più diffusi sono le guaiave della Cina, con le loro foglie rosse, e gli arbusti giganti di lantana. Qua e là un ebano, smilzo, contorto. Aditi cammina veloce davanti a me, ha solo delle ciabatte di gomma ma corre senza problemi sulle pietre e tra le pozzanghere scivolose. Cerco di immaginarmi i dodo qui, in questo guazzabuglio vegetale, ma a sopravvivere è più che altro il ricordo dei fuggiaschi: degli esseri umani sempre in fuga, che s'insinuavano nella foresta inseguiti da schiere di cacciatori d'uomini. Erano i primi veri abitanti di quest'isola, insieme ai dodo, perché i loro padroni olandesi li avevano abbandonati nel 1695, dopo l'incendio del forte appiccato da una coppia di schiavi rivoltosi e la punizione di costoro, l'uomo squartato e fatto a pezzi, la donna impiccata. I fuggiaschi sopravvissuti costruirono i loro ripari di rami e foglie nel cuore della montagna inospitale, lontano dagli specchi d'acqua. Più in basso, nelle gole della Rivière Noire (che era appunto il loro fiume), chiusero l'entrata delle grotte con gli arbusti spinosi. Sorvegliavano la costa, l'immensa mezzaluna blu, bianca e turchese. Ogni tanto una nave gettava l'ancora nei pressi del Bénitier, o alla foce della Rivière Noire, e dall'alto della falesia i fuggiaschi potevano vedere i canotti scaricare gli schiavi. Colonne di formiche nere che camminavano sulla spiaggia del Marne e che andavano a nord, all'inferno delle piantagioni. Ogni tanto la rivolta cresceva, i fuggitivi accendevano fuochi sulle alture, per segnalare ai nuovi arrivati che non erano soli, che la libertà li aspettava nella foresta. Nella boscaglia, mentre scende la notte, mi pare di sentire le grida dei fuggiaschi. Non hanno voci umane. Imitano il grugnito dei maiali selvatici, le strida delle aquile, oppure abbaiano come cani, uaf! uaf! Lo fanno per seminare il terrore, perché i miliziani che li inseguono si fermino sulla pista e facciano dietrofront verso i loro bivacchi, anche se i luogotenenti dei proprietari delle piantagioni ridono della loro paura e li incalzano, avanti, cacasotto! Le milizie sono di stanza a Rivière Noire, a Tamarin. La notte raccontano le cose terribili che hanno visto nella foresta, i selvaggi nudi con il corpo cosparso di fuliggine, armati di lance e frecce di legno ferro, che scagliano pietre dall'alto dei dirupi, scavano trabocchetti che ricoprono di liane avvelenate, trappole che riempiono di spine di cactus. Adesso tutto tace, sulle rive della Mare Longue. Solo il vago ronzio delle zanzare, e in fondo ai dirupi inizia il canto dei rospi. Il sole scompare dietro il Piton de la Petite Rivière Noire, in un bagliore dorato che per un istante riempie il cielo, poi scende la notte. ╚ per questo che sono venuto, è quanto spiego ad Aditi prima che faccia ritorno al rifugio del MWF: «Sono qui per ascoltare la notte al centro dell'isola. Il silenzio che assedia gli alberi». Il mio tono solenne, un po' arrogante, l'ha fatta ridere: «Sei proprio un bambino» ha detto. Mi sono avvolto nel parka, la testa sullo zaino, e ho guardato le stelle apparire attraverso la bruma, finché il chiarore azzurrino ha illuminato ogni cosa. Lo stesso cielo che, notte dopo notte, i fuggiaschi guardavano nell'angoscia dell'attesa, forse spiando la stella che li avrebbe guidati alla Grande Terra, dall'altra parte dell'oceano. Cercando quella che avevano visto da bambini, sulla riva del fiume, prima che i demoni a cavallo li catturassero e attraverso deserti e acquitrini li portassero fino a Kilwa, fino a Zanzibar. Qui, a Macchabée, sono in mezzo all'oceano, il cielo è nudo, immutato, imperturbabile, senza niente che minacci o contamini. Nessuna luce, qui, nessun chiarore. Solo lo sfavillio delle stelle, gli astri che pulsano, che li fissano, una potenza remota e familiare. Sono nati sotto queste medesime stelle i grossi uccelli dalla pupilla dilatata, a tratti levano la testa al cielo, la palpebra sbatte quando passa un bolide, poi tornano al loro sonno, seduti sulle loro buche nel terreno, a covare il loro unico uovo. Gli schiavi fuggitivi ricordano la notte della loro infanzia, borbottano un incantesimo, una preghiera nella loro lingua. Un cielo senza nome, senza figure, senza scienza. Un cielo silenzioso che beve la loro vita, respira il loro fiato. | << | < | > | >> |Pagina 158Per Aditi, la foresta si apre ogni giorno all'alba. Scosta il lembo di tulle che ricopre il letto, nella camerata gli studenti dormono ancora, sospesi nelle loro amache, le ricordano dei bozzoli d'insetti in attesa. Nella radura una bruma lanuginosa, bianchissima, s'impiglia agli alberi. Esili gocce nate dal nulla aleggiano nel cielo. La voliera è già sveglia, in effervescenza. I parrocchetti vanno di posatoio in posatoio, le colombe rosate tubano. All'esterno, le coppie in libertà spiccano il volo verso i rami alti. I loro gridi acuti si rispondono in un'eco fino ai margini del parco nazionale, il fruscio delle ali in sordina. Aditi ama questo momento, sente dentro di sé una gioia schietta, che proviene da ogni parte. Ripercorre il tragitto segnato dai rami spezzati il giorno prima, in mezzo alla sterpaglia. E il suo sentiero privato, che chiude ogni sera con dei rami spinosi per ritrovarlo al mattino. Non indossa la battledress fornita dal MWF, ma una semplice maglietta e un paio di jeans strappati, i piedi nudi nelle sue infradito preferite, che un'amica le ha portato dal Brasile. Cammina verso il bordo della falesia a strapiombo sulle gole, da dove si vede il mare, tra le nuvole, il blu della laguna e in lontananza la striscia viola dell'oceano ancora al buio. ╚ il posto che sceglie per salutare il sole, anche se da questa parte dell'isola tarda a comparire. La luce calda aumenta di minuto in minuto, invade il cielo a ondate impercettibili, accende le cime delle due montagne, Brise-Fer a destra, i due pitoni a sinistra, e si disperde tra gli alberi, nera sulle rocce, verde intenso sulle foglie, rossa e gialla dove la terra è nuda. Aditi non parla forte. Seduta sul promontorio, davanti al mare, le gambe piegate sotto le natiche, il busto eretto, le mani aperte sui lati del pancione, pronuncia con voce trattenuta le parole che conosce fin dall'infanzia, Vaayura nilamam thametedam bhasmantam shariram
«Che questa vita torni al soffio immortale e questo corpo alle ceneri»
La luce entra in lei, la riscalda nel profondo. Aditi respira lentamente, il viso rivolto al cielo. La luce che aumenta nelle gole disfa ogni resistenza, scioglie tutti i legami e la lancia nello spazio. Non pensa più alla sua vita, né ai suoi desideri, né alle sue paure. Dimentica tutto quello che l'ha umiliata. ╚ semplicemente se stessa, Aditi. Non più la ragazza senza padre, l'operaia della zona franca che un uomo un giorno ha catturato in un'imboscata sul sentiero della fabbrica per violentarla su un terreno incolto. Lei è Aditi, la prima di una nuova stirpe, porta in grembo il figlio che non ha voluto, il figlio della violenza. Lo aspetta. Non sa chi sarà, maschio o femmina. Non avrà nome. Sarà il figlio della foresta, così ha deciso. Aditi conosce ogni albero, ogni cespuglio, ogni liana, si è scritta i loro nomi nel quaderno, con i disegni delle nervature delle foglie, delle loro ramificazioni, dei fiori, dei frutti, se n'è annotata l'odore, il sapore, e tutte le leggende che li circondano, gli spiriti che li abitano, sotto forma di insetti o di lucertole, i viaggi che hanno compiuto prima di approdare sull'isola. Ogni giorno percorre la foresta per una ricognizione delle metamorfosi, delle insorgenze, delle estinzioni, dell'invasione degli estranei, del passaggio degli animali, delle orme degli uccelli. I professori e gli studenti hanno il loro percorso, circolano su un furgoncino del MWF, si spostano da un punto di riferimento all'altro. I poliziotti vanno in cerca delle piantagioni di gangia, braccano i piccoli trafficanti. Le guardie forestali cacciano i macachi, i maiali selvatici, piazzano trappole, veleni. Aditi, lei cammina solo sulle proprie tracce, senza veri punti di riferimento, d'istinto, assaggiando le foglie, annusando l'aria. Ha la sua mappa memorizzata. Qui la liana a tre dita, là una tambourissa, un gelso del tintore, un'erba puzzolente, un'orfilea, un' Ochna mauriziana. Parla a ciascuna pianta, non a voce, ma con gli occhi, con il respiro, con il tocco della punta delle dita, a fior di labbra. Arrivata all'albizia si siede nell'humus, per sentire l'odore del lichene bianco sotto la corteccia, rovescia la testa all'indietro per vedere la fustaia così alta che la nebbia ci s'impiglia. Più lontano ritrova il canario, un gigante dalla corteccia rossa, percorso dalle formiche. Gli rivolge la sua preghiera muta, uguale a quella per le bestioline che strisciano a terra, lombrichi, onischi, ragni.
Il sole è alto nel cielo, la nebbia si è dissipata, spalancando abbaglianti
vastità azzurre. Adesso le foglie, le corolle si
fissano nella luce, senza un vuoto, senza un sussulto. ╚ un
mondo perfetto, pensa Aditi.
|