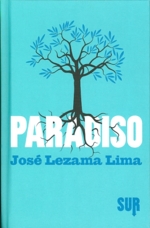
|
|
|
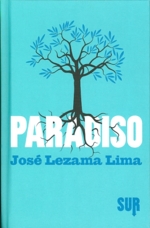
|
|
|
| << | < | > | >> |Indice
Habanarama. Cosa fare in Paradiso
di Chiara Valerio 5
Capitolo primo 19
Capitolo secondo 46
Capitolo terzo 74
[...]
Capitolo quattordicesimo 676
Nota del traduttore 741
Appendici
Trascrizioni 753
Glossario di voci cubane e ispaniche 756
Repertorio di luoghi, cose e personaggi 765
Coordinate lezamiane 781
Per arrivare a Lezama Lima
di Julio Cortázar 785
|
| << | < | > | >> |Pagina 19CAPITOLO PRIMOLa mano di Baldovina scostò i veli dell'apertura della zanzariera, frugò premendo delicatamente come se fosse una spugna anziché un bambino di cinque anni; aprì la camiciola e osservò il petto del bambino coperto di piaghe, di solchi dal violento rossore, e il petto che si gonfiava e si contraeva come dovesse compiere un poderoso sforzo per prendere un ritmo naturale; aprì anche la braghetta dei calzoni da notte, e vide le cosce, i piccoli testicoli coperti di piaghe che si espandevano, e quando allungò le mani ancora di più sentì le gambe fredde e tremanti. In quel momento, mezzanotte, si spensero le luci nelle case dell'accampamento militare e si accesero quelle dei posti di sentinella, e le lanterne delle ronde si trasformarono in un mostro errante che si gettava nelle pozzanghere, mettendo in fuga gli scarabei. Baldovina si disperava, scarmigliata, sembrava una damigella reale che, con un infante in braccio arretrasse da una stanza all'altra nell'incendio di un castello, eseguendo gli ordini dei signori in fuga. Aveva bisogno ormai che si andasse in suo soccorso, poiché ogni volta che apriva la zanzariera, vedeva il corpo espandersi e dare più risalto alle piaghe; atterrita, per porre in atto l'urgenza di fuggire che ormai provava, finse di cercare l'altra coppia di domestici. L'ordinanza e Truni, accolsero il suo arrivo con sorpresa allegra. Con gli occhi aperti a credere ogni cosa, parlava senza trovare le parole, del rimedio che ci voleva per la creatura abbandonata. Diceva il corpo e le piaghe, come se li vedesse crescere sempre o come se lentamente la spirale di lamina in movimento, di imperfetta gelatina, vedesse l'apparizione fantasmale e rosea, l'emigrazione di quelle nubi sul piccolo corpo. Mentre le piaghe prendevano tutto il corpo, l'ansimo indicava che l'asma tratteneva tanta aria nella creatura, che sembrava dovesse ricercare un'uscita attraverso i pori. La porta socchiusa a cui era giunta Baldovina, mostrò la coppia con le coperte del letto sulle spalle, come se l'apparizione della figura che giungeva avesse tale velocità nelle sue interrogazioni, da portarli a una condizione simile a un monte di sabbia che si fosse rovesciato sul tetto, lasciando loro scorgere appena lo spettacolo dalla stessa posizione di fuga. Molto lentamente le dissero di sfregarlo con l'alcol, perché di certo il formicaleone aveva punto il bambino mentre saltava in giardino. E che l'ansimo dell'asma non aveva importanza, andava e veniva, e intanto il corpo si dava a quel dolore e poi si sarebbe ritirato senza perdere la vera salute e la gioia. Baldovina tornò indietro, pensando magari qualcuno si portasse via il piccolo corpo, di cui doveva misteriosamente sentirsi responsabile, balbettare spiegazioni e vigilarlo in modo tanto minuzioso, perché in ogni momento le piaghe e l'asma potevano ricadere su di lui e riempire lei di spavento. Poi arrivava il Colonnello ed era lei a dover subire una sfilza di domande, a cui rispondere con nervosa distrazione, e gliene rimaneva un contrappunto con tante discrepanze, soprassalti e menzogne, che mentre il Colonnello baritoneggiava le sue risate, Baldovina diventava leggera, scompariva, scompariva, e quando veniva chiamata di nuovo faceva sì che la voce attraversasse una selva oscura, tali impossibilità, che doveva nutrire quell'eco di voce con tante voci, che ormai era tutta la casa a sembrarle di essere stata chiamata, e che a Baldovina, che ne era solo un frammento, toccasse una particola tanto piccola da doverla rinforzare con nuovi perentori, accrescendo il potenziale dell'onda sonora. Il teatro notturno di Baldovina era la Casa del Capo. Quando il padrone non c'era, appariva più incombente la sua figura, diventava più rispettata e temuta e tutto prendeva valore in rapporto alla gravità della paura rispetto a quell'assenza. La casa, nonostante la sua sontuosità, era stata eretta con la ristrettezza lineare di una casa di pescatori. La sala, al centro, era di tali proporzioni che i mobili sembravano figure di ballo in cui sarebbe stato impossibile imbattersi sia pure di notte. Su ogni lato c'erano due stanze: in una dormivano José Cemí e sua sorella, nell'altra dormivano il Capo e la moglie, con una salute così bene intrecciata da far apparire impossibile, in quel momento di terrore per Baldovina, che avessero generato la creatura ansimante, che sprigionava i suoi cerchi di piaghe. Dopo quelle due stanze, i gabinetti, seguiti da altre due stanze laterali. In quella di sinistra, viveva lo studente cugino del Capo, provinciale che studiava da ingegnere. Poi due stanze per la cucina, e lì c'era il mulatto Juan Izquierdo, il perfetto cuoco, soldato sempre vestito di bianco, con il gilè bianco, all'inizio della settimana, e di sabato ormai sporco, povero, a chiedere prestiti e avvolto in un silenzio invincibile da diorite egizia. Cominciava la settimana con l'arroganza di un mulatto orientale appartenente al colonato, precipitava negli ultimi giorni della settimana, in richieste infinitamente serie di cifre modestissime, sempre accompagnate dal terrore che il Capo si accorgesse che suo cugino era la vittima preferita di quei pagherò sempre rinnovati e mai onorati. Dopo la stanza del Colonnello e della moglie, appariva il gabinetto, rispettando l'elementare e rozza legge di simmetria che porta le abitazioni tropicali a parallelizzare, nelle case di simili grandezze, dove tutto vuole esistere e spandersi in partita doppia, i gabinetti e i minimi stanzini in cui si conservano i piumini e le trappole ormai inutilizzabili per topi. Seguiva poi la stanza dalla più segreta personalità in tutta la dimora, e quando nei giorni delle pulizie generali veniva aperta, mostrava la semplicità delle sue nature morte. Ma per i ragazzi, nella notte, nel succedersi delle loro notti, sembrava aleggiare come un'aura e pervadere ogni dove come l'abisso pascaliano. Se veniva aperta, in certi mattini furtivi, vi si aggiravano il piccolo José Cemí e sua sorella, di due anni maggiore di lui, osservando i tavoli da campagna del padre, di quando lavorava come ingegnere, nei primi anni della sua carriera militare; il gioco dello yaqui con la palla di budello d'anatra, non era quello solito con cui giocavano i due fratelli, o Violante, questo il nome della sorella, giocava con qualche servetta portata in casa per risolverle i momenti di noia o per alleviare qualche parente povero del peso di un piatto di minestra o della preoccupazione di altra biancheria da comperare. I libri del Colonnello: l'Enciclopedia Britannica, le opere di Felipe Trigo, romanzi di spionaggio della Prima guerra mondiale, quando le spie donne dovevano oltrepassare i confini della prostituzione, mentre quelli più temerari dovevano acquistare esperienza e un pizzetto brinato in ricerche geologiche in Siberia o nella KamČatka; conservavano quegli spazi mai più percorsi, di quelle persone concrete, precise, che appena comprano un libro, lo leggono la notte stessa, e che sempre mostrano i loro libri nello stesso modo scomodo e irregolare in cui hanno conseguito le loro sinuosità, e che non è libro delle persone più colte, anche se disposto sullo scaffale, ma dove un libro deve aspettare due o tre anni per essere letto ed è un colpo d'effetto quasi inconscio, certo, somigliante ai pantaloni degli inglesi eleganti, usati dai valletti per i primi giorni fino a quando assumono un'acuta semplicità. Le scrivanie del Colonnello, che era anche ingegnere, il che provocava nella truppa - quando assorta lo vedeva riempire le lavagne con le esercitazioni dell'artiglieria da costa - la stessa devozione che avrebbe potuto dimostrare di fronte a un sacerdote copto o a un re cacciatore assiro. Sulla scrivania, riuniti con fermagli ormai arrugginiti, fogli su cui erano disegnati sbarchi in paesi non localizzati nel tempo né nello spazio, come una sfilata di banda militare cinese posta tra l'eternità e il nulla. Poi, a formare torri, le scatole con i cappelli stagionali di Rialta, si chiamava così la moglie del Colonnello, da dove sceglieva quelli che più andavano d'accordo con il suo capriccio, a seconda della consonanza che mostravano con il suo mezzo uccello del paradiso, il quale era applicato, cosicché poteva essere spostato da un cappello all'altro, facendo così sembrare che quell'uccello rinsecchito tornasse ad agitarsi nell'aria, con nuove trattenute palpitazioni, risaltando, talvolta su una manciata di fragole, davanti alla quale rimaneva immobile senza osare beccarla, o su un fondo giallo canarino, dove il becco dell'uccello tornava ad affermare le sue condizioni di furore, desideroso di trafiggere come una daga. | << | < | > | >> |Pagina 42Il respiro sembrava riacquistare in lui la primitiva funzione sacra di flatus Dei. Quando non parlava, sembrava che quel respiro trasformato in dinamite di platino si disponesse sotto i mucchi dei suoi muscoli e dei suoi fasci di vene. Qualunque banalità dicesse sembrava scaturire da quell' almácigo di respiro concentrato. Ma nel giorno del sollazzo familiare, quel respiro si trasformava in albero del centro familiare e alla sua ombra sembrava raccontare, invenzionare, conseguire la sua migliore forma di parola e gesto, come se fosse venuto a presentarsi, secondo i segnali che i teologi attribuivano alla festa finale di Giosafat.
«I miei muscoli erano vivi come quelli del daino, quando ero giovane a
Bilbao e correvo sempre più forte sulle ali del vento», disse. In quel momento
cominciarono a servire il primo piatto, cubetti di frutta di stagione; si alzò e
cominciò a versare su ognuno dei vassoi portati dai più giovani,
vino d'uva lusitana. «È del vitigno», aggiunse facendo una
parentesi nel suo racconto, «che piace agli inglesi tories, ed
è bene che da ragazzi ci abituiamo al palato degli inglesi».
Concluse la frase con una risata che non si sapeva se fosse
di scherno o di rispetto per il palato degli inglesi, inghiottì
un racimolo di grossa uva viola, alzò ancora la voce e lo si
poté ascoltare da ogni parte:
«Io ero un carricolari», nel riprendere il racconto mostrava ormai la serenità di chi parla del proprio intimo, continuò, «si chiamano così a Bilbao i corridori da gara. Un gruppo di persone, quasi un pellegrinaggio, venne verso casa mia, per dirmi che era arrivato il belga Peter Lambert, che era il più veloce negli ex nostri Paesi Bassi, e che avevano pensato a me per affrontarlo. Mi decisi a entrare in competizione con l'allegra sicurezza di chi entra nella propria perdizione. Quel dannato belga correva come trascinato da nuvole di uragano. Stavo svenendo quando ho sentito bastoni appuntiti come lance, branditi da bilbaini orgogliosi, che mi punzecchiavano perché saltassi invece di correre, perché mi infilassi di nuovo gli stivali del miracolo. Eppure, il belga è arrivato primo dove bisognava arrivare. Da allora ho pensato di andarmene, perché chiunque mi incontrava sembrava mi lanciasse addosso la vergogna del fatto che quei bastoni non avessero operato il miracolo». Interruppe il racconto ed esclamò: «Ancora zapote, Enriqueta», che era il nome di sua moglie. Con nobile assaporare estinse la polpa dei frutti, si alzò e distribuì vino bianco secco sul vassoio in cui coloro che erano più avanti negli anni mostravano la stessa frutta servita ai ragazzi. «È una prova assai difficile per il palato», aggiunse, «frutta molto dolce e vino secco. Mi soffermo sui volti», aggiunse, «nel fare questo assaggio e subito mi faccio un'opinione, perché la maggior parte abbandona la frutta con disgusto». «Ancora zapote, Enriqueta», disse di nuovo, come se i suoi appetiti fossero ciclici e seguissero le leggi del suo pendolo gastrico. «Quando sono arrivato a Cuba», disse dopo la pausa necessaria all'estinzione dello zapote, «ho affrontato, per mia ulteriore perdizione, l'ormai felicemente démodé dibattito sulla supremazia tra la frutta spagnola e quella cubana. Il mio malizioso interlocutore mi disse: "Non sia ingenuo, tutti i vigneti di Spagna sono stati distrutti dalla mosca nera, e per sostituirli furono importati semi americani, e tutte le uve attuali della Spagna", concluse dando la stoccata finale, "discendono da quei semi". Dopo avere ascoltato quelle irrisioni apocalittiche, provai paura. Tutte le notti durante incubi da follia, sentivo che quella mosca si ingrandiva dentro il mio stomaco, e poi si riduceva per risalire lungo i canali. Quando era ridiventata piccola svolazzava contro il cielo del mio palato, mentre avevo le mascelle tanto serrate, che non riuscivo a cacciarla fuori dalla bocca. E così tutte le notti, paura dopo paura. Mi sembrava che la mosca nera avrebbe distrutto le mie radici e che mi portavano semi, migliaia di semi che facevano rotolare attraverso un imbuto verso la mia bocca. Un giorno sono uscito dal Resolución all'alba; le foglie come canali facevano colare acqua di rugiada; perfino le ossa sembravano rallegrarsi per l'umidità. Le foglie grandi della malanga sembravano cullare un neonato. Vidi un flamboyant sporgersi come un mollusco dalle valve del mattino, era tutto pieno di cocuyos. Lo statico fiore rosso di quell'albero mescolato alle punzecchiature dei verdi, improvvisa parabola di gessetto verde, era come se mi illuminasse dai visceri e da tutte le interiora. Sentii aumentare il sonno, che mi assaliva rovesciandosi su di me come mai aveva fatto. Sotto quei rossi e quei verdi mescolati dormiva un agnello. La perfezione del suo sonno si espandeva per tutta la valle, guidata dagli spiriti del lago. Il sonno mi diventava scivolo e caduta, mi costringeva a guardarmi attorno per cercare sostegno. Immobile l'agnello sembrava sognare l'albero. Mi distesi e mi appoggiai sul suo ventre, che si muoveva come per generare un ritmo favorevole alle onde del sonno. Dormii per tutto il tempo che di solito durante il giorno rimaniamo svegli. Quando tornai i parenti avevano cominciato a cercarmi, volendo seguire il cammino che avevo percorso, ma tutte le orme si erano cancellate». «Ancora zapote, Enriqueta», disse di nuovo, allungando la mano con una stanchezza che segnava la ritirata degli invitati e l'arrivo della luna crescente di gennaio. Faceva ritorno dopo la festa il Colonnello all'accampamento insieme a un pomeriggio che si arrese in fretta a una notte bassa, avvolta tra le gambe e che impediva di camminare in fretta. Assai vicino alla casa trovarono il mulatto Juan Izquierdo, in lacrime, ubriaco, infelicità e malvagità, metà e metà, senza sapere quale delle due metà avrebbe messo in mostra. La signora Rialta scese dalla macchina, nervosa, con tutto il suo essere teso sull'altezza dei tacchi. Piangeva il mulatto, come una gargolla, lacrime colavano dalle orecchie, dagli occhi e dal naso. Lo sfondo era oscuro e irrisolto. Subito, il Colonnello gli si avvicinò, dandogli un colpetto sulla spalla e gli disse: «Domani vieni a cucinare, devi farci delle yemas doppie che non abbiano orecchie d'elefante». Rise forte, sentiva d'avere la situazione in mano. Il mulatto piagnucolò, aumentarono le sue lacrime, biascicò perdono. Quando si allontanò sembrava chiedere una chitarra per calpestare il lamento e intonare il gaudio. La signora Augusta, dietro le persiane, che erano, come diceva il Colonnello, il suo binocolo da campagna, aveva visto la disinvolta chiarezza della scena. Quando sentì, dopo avere ascoltato l'allegro cigolare dei gradini della scala, che si avvicinava il Colonnello, si sbalordì fino al punto di essere lei a dare gli attenti. «Attenti, attenti», gridava, come chi accoglie all'improvviso un re che ha ingaggiato una battaglia vicino al castello senza che gli occupanti se ne siano neppure resi conto. | << | < | > | >> |Pagina 46CAPITOLO SECONDOJosé Cemí era uscito di scuola portando con sé un lungo gessetto, il gessetto conservava tutta la propria lunghezza, se vi si fosse appoggiato l'avrebbe spezzato, a causa di quell'assorta distrazione, tipica dei suoi dieci anni. La noia delle ore di scuola spiegava perché all'uscita cercasse appoggio, distrazione. Quel giorno lo aveva trovato grazie al gessetto. La scuola posta al centro dell'accampamento aveva sul retro un lungo prato, e sulla destra un muro che mostrava la sua calce sporca e la costolatura di mattoni allo scoperto, come se il tempo l'avesse strofinato con una pelle scamosciata mescolando sabbia, limone e lisciva. Si era avvicinato al muro cercando compagnia. Ma fu quella compagnia che seguiva solo sé stessa, pietra su pietra, pensiero su pensiero, irriproducibili. Il suo cammino procedeva in quel momento come il muro, passi dopo passi sommati, come sommati mattoni che ci davano l'altezza del muro. Mentre il cemento del muro sembrava pantano molliccio, mostrando lunghe strisce della propria pelle, il mattone ricotto dal diretto raggio zenitale, si adattava come le chiazze che formano il tronco del platano. Alla fine, appoggiò il gessetto come se chiacchierasse con il muro. Il gessetto cominciò a emanare il bianco, che l'obbligata violenza del sole riempiva di rilievo e di eccezione in rapporto agli altri colori. Arrivava ormai il prolungato gessetto alla fine del muro, quando la personalità fino a quel momento indiscussa del gessetto fu sostituita da una mano che lo teneva e lo stringeva esageratamente, come se temesse che la sua distrazione finisse per sfuggir via, poiché quella mano cominciava a pretendere obblighi, come se la mano richiedesse il corpo di una preda catturata. Se il gessetto era stato sostituito da un'altra mano, lui aveva dovuto mettere al posto del muro, il corpo; se ne accorse molto lentamente e ormai lo teneva per il braccio. Non se ne sarebbe accorto fino all'estinzione di quell'interposta avventura. Dietro il muro si nascondeva una casa dal grande cortile circolare, che mostrava le semplici camere occupate da una povertà soddisfatta. Si trascinò fino al centro del cortile, mentre quel corpo cominciava a vociferare. Un gridio tanto torrenziale contribuiva a mantenere l'indistinzione della persona che lo aveva spostato fin lì. Sembrava a Cemí un vortice di voci e colori, come se il muro fosse crollato e immediatamente si fosse ricostituito in un cortile circolare. Poté appena osservare la ristrettezza della porta d'ingresso in rapporto alla dimensione ingrandita del cortile riverberante di coperte, di grani odorosi, di sfavillii indecifrabili di inutili metalli, di sudori diversi di pelli straniere, di disperse risate di criollos sventati, che distribuivano incoscientemente, come arte dissipata, corpo e ombra. | << | < | > | >> |Pagina 74CAPITOLO TERZOLa tesa luce di luglio copriva con ridenti saltelli i contorni dell'albero delle noci, che delimitava uno dei quadrati di Jacksonville, negli iniziali crepuscoli dell'estate del 1894. Rialta, quasi sonnambula nell'inafferrabile penetrare vegetativo dei suoi dieci anni, si allungava sui rami più scricchiolanti, per raggiungere la venerabile capsula piena di rumori concavi che si toccavano la fronte blandamente. Il suo corpo tutto trasformato in senso a causa della tensione dello stiramento, non ascoltava l'assottigliarsi e il rumoreggiare di cedimento della fibra, ma il suo udito era rimasto attaccato al ricorrere e risuonare della bacca che correva invisibile dentro il guscio. Si risvegliò, ascoltò, si girò. «Rialta, don't steal the nuts». Frettolosa, nella testarda giustificazione delle proprie inutilità, Florita Squabs era passata davanti all'albero delle noci, e s'era accorta quasi di niente, i suoi occhi non volevano soffermarsi e i piedi esitavano di fronte al timore di vedere quel pagliaccetto alpaca, di un azzurro impenetrabile che si allungava verso le ultime fragilità del ramo. Rialta sentì che le noci disfacendosi in rugiada tornavano al loro pianeta inafferrabile, la voce di Florita, di ferro e di ghisa, la ricondusse, in tre o quattro salti, accanto al tronco delle noci, e improvvisa, la luce cominciò a invadere il suo contorno, riportandola di nuovo alla sua sicura levitazione terrena. Il giorno dopo, Florita andò a far visita alla signora Augusta. Fiorita era la moglie di Mr. Squabs. L'organista Frederick Squabs era calato, era questo il termine che lui usava sempre, dal North Carolina a Jacksonville, a causa di un'affezione laringea che richiedeva clima caldo. Ciò aveva ingenuamente oscurato il suo destino, che credeva opulento di doni artistici, inducendolo alla più densa concisione verbale e alla frequenza allusiva nei confronti dei garbugli della sua ananké. Ma gli insignificanti abitatori di Jacksonville si burlavano del fatto che, nonostante la sua mano fosse grassoccia e inquisitoriamente affusolata, scorreggesse le ottave, e l'intervento del registro flauto del suo strumento provocasse stridii nervosi, come tagli nella cotogna gelata. Aveva sposato Florita, figlia di madre cubana, dalla sensibilità sempliciotta con tendenza propizia a credere che il marito fosse un artista a cui la divinità si ostinava a girare le spalle. Mr. Squabs, debolmente risentito, aveva tentennato verso il puritanesimo chiuso di chissà quali carezzevoli voluttuosità, giunte inavvertitamente fino a lui, nel ripassare una lastra d'acciaio premiato dalla casa Winchester. Quando avvolto da inesorabili teli neri si esercitava nelle scale all'organo, ripassando a volte la Santa Cecilia di Haydn, arrivato al Resurrexit, in cui il coro commenta il Judicare vivos et mortes, gridava con voce moltiplicata dalla solitudine della capella al momento delle prove: «Vivi, vivi, sì, che venga presto a giudicare i vivi». E con un fazzoletto di grande estensione rimuoveva con cerimoniosa correttezza, il sudore dal suo freddo volto, e la moglie che lo contemplava nascosta, credeva che piangesse la propria intoccabile disperazione di grande artista frustrato. | << | < | > | >> |Pagina 113CAPITOLO QUARTOIl padre di José Cemí, che abbiamo visto nei capitoli precedenti alle prese con le ordinanze e con i cerimoniali del suo grado di colonnello, lo scopriremo adesso nella sua infanzia fino all'incontro con la famiglia di Rialta, sua moglie, sua allegra giustificazione e sua chiarezza sufficiente. Aveva a che fare il Colonnello ancora con l'albero universale nell'ultima fase feudale del matrimonio. Immense dinastie familiari s'imparentavano con il mistero sanguineo e con l'evidenza spirituale di altre tribù. Cioè, il fratello di Rialta era stato il suo primo e più stimolante amico. La madre di Rialta, la signora Augusta, era anche un po' sua madre, perché era orfano da quando aveva dieci anni. Così le due famiglie nell'imparentarsi si perdevano in ramificazioni infinite, in dispersioni e rincontri, in cui coincidevano la storia sacra, quella domestica e le coordinate dell'immagine proiettate verso un ondulante destino.
Nelle prolungate conversazioni durante il pranzo, José
Eugenio Cemí, il futuro colonnello, allora dodicenne,
scherzava con lo zio, arrivato dal
central
Resolución, incolto, sebbene ben piantato e con scompigliate presunzioni di
guajiro tipico; parlatore, sebbene con copioso annaffiamento di palatali mutate
in sillabe esplosive, in scorrette
divisioni in sillabe e in ingurgitamento di finali di parole.
Pochi giorni dopo aver scoperto L'Avana del 1902, ed essersi inerpicato come un
feudale e orgoglioso falco, nelle più
economiche e più alte poltrone, per ascoltare le arie di
Maria Barrientos, diceva, più per dimostrare il suo rapido
appropriamento delle mode dell'Avana, che le sue smancerie glaucopidi in fatto
di arte:
È faccinante, semplicemente faccinante.
E se qualcuno gli rinfacciava le debolezze della scuola spagnola,
quel tragico si sostenuto,
come diceva lui, la somma di note alte e acute, perché la scuola spagnola era
la somma della perenne acutezza italiana e dell'altezza di
quella spagnola meno contaminata; il trascurare la corda
media, preferendo il registro alto alle sicurezze classiche
dell'imposto, come nella lezione di piano del
Barbiere di Siviglia,
di cui invariabilmente María Barrientos ci serviva
l'aria della pazzia, della
Lucia,
le sue note erano tanto alte
che quasi arrivavano allo stridio che spezza il cristallo,
mentre trascurava quell'assopimento della voce, quel vagare in cui il suono deve
mancare di rifugio e di conoscenza,
per trovare riparo in un'estensione senza nome e senza
fumi nelle sue dimore più lontane. «Sempre filibusterismo», diceva, «ormai è
anacronistico, bisogna dedicarsi ad altre cose e soprattutto a lavorare.
Prendete la voce allo stato puro», continuava, «e godetela senza assopimenti né
trombe da assalto all'arma bianca. Lavorare e ascoltare
buone voci, magnifico motto», concludeva esaltandosi e
scatenando la sua rusticità ben visibile di nuovo arrivato all'Avana.
|