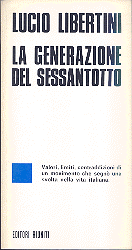
|
|
|
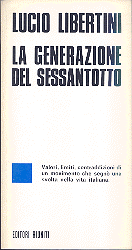
|
|
|
| << | < | > | >> |Indice
1. Premessa: fare sul serio i conti con il sessantotto 7
2. La rottura dei vecchi equilibri economici e sociali 10
3. La crisi del «socialismo reale» 25
4. Contestazione e forze politiche 30
5. La dimensione internazionale del movimento 36
6. I cattolici nella contestazione 39
7. I limiti e gli errori: per un'analisi critica
dell'estremismo 42
8. Il sessantotto degli operai 52
9. Il sessantotto degli studenti 76
10. Il movimento e i partiti storici 86
11. I nuovi caratteri dell'estremismo attuale 102
12. Cambiare la società vuol dire anche mettere
in discussione se stessi 111
|
| << | < | > | >> |Pagina 71. Premessa: fare sul serio i conti con il sessantottoUna ondata critica, che proviene dai luoghi piú disparati, investe in questa fase l'esperienza di contestazione e di lotta che si usa chiamare il «sessantotto»; e cioè quel complesso movimento che tra il 1968 e il 1972 — ma con radici profonde negli anni precedenti e con conseguenze molteplici negli anni successivi — coinvolse operai e studenti e sembrò scuotere nel profondo la società italiana, partendo dalla scuola e dalla fabbrica, alimentandosi via via con le notizie e le suggestioni che venivano dalle esperienze vicine di altri paesi, dagli Stati Uniti alla Francia, alla Germania. L'attacco piú banale e volgare punta il dito su alcune piaghe profonde della società in cui viviamo: il terrorismo; la disgregazione sociale e morale che sembra colpire in particolare tra le giovani generazioni settori importanti del ceto medio e aree della stessa classe operaia; le spinte corporative. Il «sessantotto» sarebbe gravemente responsabile, per la sua parte, di questi fenomeni. I capi delle Brigate rosse sono i figli dell'estremismo di dieci anni fa, un egualitarismo astratto ha dato un colpo troppo duro alle necessarie gerarchie sociali, il rifiuto del lavoro, dell'autodisciplina, di un impegno serio di vita hanno aperto le porte al disordine e alla irresponsabilità. Se c'è la peste, occorre trovare l'untore; si capovolgono i processi reali, e, oltretutto, si rendono causa della crisi anche le sue manifestazioni. A un livello piú elevato e diverso — e questa volta anche all'interno della sinistra — si collegano invece le piú gravi degenerazioni estremistiche — politiche , del costume e del linguaggio — all'estremismo di dieci anni fa, e si tende a identificare con quell'estremismo tutto il movimento del sessantotto. Si mette in luce come anche ciò che allora pareva oro fosse stagnola, si rivendicano le ragioni della esperienza e della tradizione contro l'immaginazione. Si rintraccia nelle convulsioni e nelle lacerazioni, dell'estrema sinistra, in certi suoi rapporti con il terrorismo, la prova che se si esce dall'ordine costituito dei partiti, delle strutture consolidate, dei metodi consacrati si smarrisce la strada e si finisce in un vicolo cieco. Si ammettono alcuni risultati positivi di quel movimento, ma contro la sua essenza si celebra la rivincita del buon senso, dei valori della tradizione, dei poteri stabiliti nell'ambito del movimento operaio. Il compromesso storico e la politica di unità nazionale vengono allora visti (ed è questa poi la stessa opinione che, sul fronte rovesciato, ne hanno i gruppi estremisti) come una politica di restaurazione, di pacificazione sociale, di fuoruscita dalle follie politiche e sindacali degli anni passati. Sono profondamente convinto che questa ondata critica, nelle sue diverse sfumature, richieda una risposta seria, dall'interno del movimento operaio. Intendiamoci, la critica del movimento del sessantotto è quanto mai necessaria, e del resto chi scrive l'ha condotta con i fatti negli anni passati, a prezzo di rotture anche umanamente dolorose, e intende qui ribadirla. Ma quest'aura di restaurazione mi preoccupa, e, soprattutto, ritengo che si debba, con un processo critico, salvare l'essenza di quel moto sociale e politico, perché senza di ciò è il presente che viene in qualche modo pregiudicato. E quel che tento di fare nelle pagine seguenti, utilizzando anche l'esperienza della mia vita; della vita di un militante comunista che è passato attraverso le vicende travagliate del partito socialista, ha partecipato ai movimenti di rottura degli anni sessanta e ai dibattiti e ai confronti cruciali sulle prospettive ideali e strategiche della sinistra. | << | < | > | >> |Pagina 427. I limiti e gli errori: per un 'analisi critica dell'estremismoL'analisi, che ho solo abbozzato nelle pagine precedenti, dei movimenti e delle radici del movimento del sessantotto dimostra che la sinistra italiana non può rinnegarlo senza rinnegare se stessa, le sue inquietudini, i suoi arricchimenti, la sua capacità di esprimere il travaglio e la ricerca della società contemporanea. Gli avvenimenti della fine degli anni sessanta segnano uno spartiacque storico. Non si può tornare all'indietro oltre esso; non si può dimenticarlo. Quei problemi e quegli interrogativi non sono sepolti, ma sono dinanzi a noi, tuttora vivi nella realtà. D'altronde la stessa sinistra, lo stesso partito comunista, gli stessi rapporti politici generali non sarebbero oggi quello che sono senza il sessantotto. I comunisti, in particolare, non possono valutare i grandi successi conseguiti dal 1975 in poi (e lo stesso balzo in avanti della forza organizzata comunista dopo il 1972) senza trovarne le radici proprio, in buona parte, in quegli avvenimenti. E questo un punto essenziale che discrimina non già solo un giudizio storico, ma un giudizio e un impegno che valgono per il presente e per il futuro. Valutare sino in fondo l'importanza del movimento del sessantotto, e realizzarne un adeguato recupero, non esclude, e anzi implica e richiede, un severo esame delle sue degenerazioni e dei suoi errori; senza di questo di navigherebbe in un equivoco terribilmente pericoloso. Prima di tutto a me sembra che la crescita di questo movimento per molti aspetti si è intrecciata con una tendenza all'irrazionalismo sempre piú forte nelle società capitalistiche in questi anni. Ciò appare limpidamente evidente nel modo di porre la questione della scienza, della conoscenza; questione assai dibattuta nelle correnti estremiste e piú in generale nel movimento operaio nel corso degli ultimi quindici anni. Si è giunti al punto di sostenere che il dogma della neutralità della scienza (l'idea, cioè, davvero discutibile che la scienza viva in un suo spazio, inattaccabile dalle vicende storiche e politiche) può essere sradicato solo se si acquista consapevolezza che non è possibile separare l'oggetto del nostro atto di conoscenza dalle ragioni di questo atto, e distinguere il momento dell'indagine della realtà dal momento della formazione di questa realtà; la realtà non sarebbe una natura vergine, ma esclusivamente un prodotto della storia degli uomini. La natura viene concepita come una semplice esteriorità, uno spazio morto di non valori. Non esiste o non ha significato una realtà indipendente dell'oggetto e quindi non ha fondamento il valore conoscitivo delle scienze naturali. Combattendo il feticismo dell'oggettualità — dal quale nasce effettivamente l'idea di una scienza neutrale — si finisce cosí con il negare in verità ogni oggettualità. Posizioni di questo tipo hanno avuto un notevole rilievo nelle correnti estremiste emerse alla fine degli anni sessanta. Attraverso di esse il materialismo scientifico viene di fatto cancellato, al suo posto si sviluppa un volontarismo idealistico. Per questa via la realtà dei rapporti di produzione, la complessità della società reale vengono cancellati e offuscati; si perde di vista la contraddizione necessaria tra forze produttive e rapporti di produzione, tra lo sviluppo della scienza e il sistema capitalistico. L'universo viene dipinto in bianco e nero, e il socialismo è una rivelazione improvvisa, tanto piú splendente quanto piú i suoi tratti sono confusi e mitici, frutto di una conseguente volontà rivoluzionaria, intrisa di moralismo, spoglia di ogni tentazione al compromesso. Si giunge cosí a pensare che i veri nemici della rivoluzione sono i dirigenti del movimento operaio, e le sue strutture, perché tardano a proclamare la rivoluzione, per scopi inconfessabili o per errori inconcepibili. La grande innovazione che Marx ha introdotto nella teoria politica, rompendo con le concezioni utopistiche del socialismo, è stata proprio quella di concepire il socialismo non come un anno zero nella storia dell'umanità, bensí come un processo che raccoglie le eredità positive accumulate dagli uomini e dalla società nel corso della loro storia. Il socialismo ha le sue radici nelle contraddizioni del capitalismo, nasce dalla sua crisi, ne eredita il patrimonio, materiale e culturale; agendo su di esso per una trasformazione radicale. L'analisi marxiana dello Stato democratico-borghese non nega affatto e anzi afferma che esso costituisce un avanzamento storico dal punto di vista democratico: e critica in esso non già i margini democratici che contiene, bensí i limiti che frappone allo sviluppo della democrazia, e le mistificazioni che vi sono implicite (le diseguaglianze che in determinate condizioni strutturali scaturiscono proprio dal diritto eguale; l'ingannevole oggettivizzazione di scelte e strutture che discendono invece da precisi rapporti di produzione). Ma per queste tendenze estremistiche, sulle quali soffia il vento dell'irrazionalismo, tutto ciò non esiste, o è un bieco inganno riformista contro il quale si può scagliare il piú rigoroso anatema. I meccanismi rappresentativi sono solo un imbroglio e vanno contestati e distrutti, sostituiti da un'indistinta democrazia diretta (a occhio e croce un regime di assemblee, o una democrazia della «azioni dirette») nella quale non si capisce bene in quale luogo si operi una sintesi politica o a chi essa spetti in concreto. La produttività è uno pseudoconcetto del capitale, che maschera solo lo sfruttamento, e il livello delle forze produttive è irrilevante per la instaurazione del socialismo. Su questa via talune avanguardie nevrotiche sono arrivate a teorizzare la soppressione del lavoro («contro il lavoro»), mentre è stato di massa l'equivoco per il quale si è creduto che in Cina, solo perché si mandavano borghesi e professori universitari a lavorare la terra per alcuni giorni all'anno, fosse stata davvero superata la divisione sociale del lavoro (e cioè quella corrispondenza tra specializzazione produttiva e gerarchia sociale che può essere via via attenuata, nel socialismo, solo dall'elevamento delle forze produttive, e non certo da decisioni amministrative). Se, come ha scritto Marx, la trasformazione del processo di produzione, l'applicazione tecnologica della scienza è la chiave di volta per lo sviluppo del capitalismo e costituisce la premessa necessaria del socialismo, ed essa è stata resa possibile dalla organizzazione del lavoro mediante la cooperazione, la divisione dei compiti e la sua unione con le scienze naturali, è fin troppo evidente che non è possibile pensare di ricomporre il lavoro cancellando di colpo la specializzazione. La lotta del movimento operaio è volta a ridurre la delega di potere agli specialisti, la divisione permanente tra coloro che sanno e coloro che eseguono, la corrispondenza tra una divisione di attività e di conoscenza e una gerarchia sociale. Ma per questo processo la volontà non basta; essenziale è la modifica delle condizioni complessive, che si genera già all'interno del sistema capitalistico, per la forza delle contraddizioni in esso insite e per l'azione consapevole del movimento di classe. Per gli estremisti e per gli irrazionalisti tutto ciò non esiste: la città del sole è dietro l'angolo, basta volerla vedere e raggiungere. La politica delle alleanze della classe operaia è pertanto, agli occhi di questi estremisti, un pericoloso cedimento, un progressivo affondare del nucleo rivoluzionario nel pantano dell'opportunismo e dei vecchi interessi. In una società che ci si raffigura assai semplicemente come divisa in due da uno steccato, ciò che occorre è solo l'appello vigoroso agli sfruttati contro gli sfruttatori; l'insorgere degli sfruttati è condizione necessaria e sufficiente per i piú profondi cambiamenti. Incanalatisi in questa direzione, molti gruppi estremistici finiscono con il fare insieme della classe operaia la piú acritica e mitica esaltazione e la piú severa condanna. Esaltazione, perché identificano in essa la verità e la vita, il solo e necessario agente della rivoluzione e del socialismo; e, ignorando la complessa realtà concreta, assumono che essa, tutta intera, aspetti solo un cenno per assolvere al suo ruolo rivoluzionario. Condanna, perché quando si deve spiegare come mai la rivoluzione non si faccia, allora si accusano gli operai di essere venuti meno ai loro doveri, di essersi integrati nel capitalismo, di essersi assoggettati a una logica nemica. Questi orientamenti spiegano poi perché, durante gli anni piú caldi della contestazione, Marcuse e le teorie dell'integrazione operaia nel sistema ebbero cosi larga e favorevole eco tra i gruppi estremisti, i quali cominciarono a volgere lo sguardo della speranza rivoluzionaria al Terzo mondo, alle minoranze dei ghetti capitalistici; ai «dannati della terra», salvo a liquidare successivamente ogni esperienza con i termini piú negativi quando i processi di liberazione assumevano i contorni concreti dettati dai rapporti di produzione, dai rapporti di forza politici, dalle influenze e dai problemi del quadro mondiale. | << | < | > | >> |Pagina 769. Il sessantotto degli studentiCertamente senza confronto piú profondo è stato l'inquinamento del sessantotto degli studenti. Tutto ciò che ho detto nelle pagine precedenti a proposito dell'estremismo e delle tendenze irrazionaliste lo ritroviamo nel movimento degli studenti, in dosi massicce e in modo molto generalizzato. Quelle posizioni che nel sessantotto operaio erano marginali, parziali, sono state abbastanza centrali nel movimento degli studenti. Inoltre quest'ultimo ha coinvolto solo una minoranza, sia pure robusta, chiassosa, incisiva, capace di bloccare i corsi, di mettere in discussione temporaneamente la tradizionale organizzazione degli studi. Nelle università una parte cospicua degli studenti non frequentava i corsi, non era fisicamente presente, è stata influenzata solo di riflesso da ciò che è accaduto. Un'altra parte, pure importante, era presente, ma passiva, neutrale, e solo in certe occasioni e per certi scopi si univa, in una sua frazione, al movimento. E, infine, nel movimento stesso occorre distinguere tra i nuclei permanenti e attivi e gli studenti che partecipavano solo in certi periodi dell'anno o della loro vita alle assemblee e alle contestazioni. I momenti culminanti del sessantotto si sono avuti proprio quando questa minoranza attiva è riuscita a coinvolgere, e ad egemonizzare, almeno in certe fasi, un'area piú estesa, anche se difficilmente superiore al terzo degli studenti; nei momenti negativi i contestatori erano gruppi relativamente sparuti. Nelle scuole medie la fluttuazione è stata molto maggiore. La contestazione e le lotte studentesche hanno avuto un andamento a chiazze, estremamente irregolare: salvo che in alcune classi e in alcuni istituti, ove si è radicata una tradizione particolare, il movimento degli studenti si è manifestato di volta in volta in certi periodi dell'anno, in certi giorni, in certi istituti, e in determinate zone del paese. Lo «sciopero» degli studenti (è difficile trovare un'espressione piú impropria di questa) non è stato d'altronde un'innovazione della contestazione del sessantotto. Nelle scuole medie e nelle università ve ne sono sempre stati: occasioni per sfuggire a una giornata scolastica, per sfogare un'esuberanza giovanile, per fare del chiasso e stare insieme liberi. Chi scrive ha frequentato le scuole in pieno periodo fascista, e nel profondo sud, ma si ricorda di molte manifestazioni consimili, a volte del tutto spontanee e tollerate largamente dal regime, altre volte usate per modesti suoi fini politici. Il sessantotto e la contestazione hanno dato a queste tradizionali agitazioni studentesche punti di riferimento politici, a volte non banali, a volte seri, anche se non tutti quelli che vi partecipavano erano consapevoli; piú che nei cortei e negli «scioperi» l'innovazione è stata nelle assemblee e nei dibattiti politici. Da ultimo, per illustrare questi aspetti negativi del sessantotto studentesco, c'è da richiamare un tema cui ho già accennato, e dal quale nessuno può prescindere se non voglia semplicemente fare della vieta propaganda reazionaria. Le agitazioni degli studenti non hanno sfasciato la scuola, come i conservatori sostengono, ma si sono inserite nello sfascio della scuola e sono semmai nate da esso, quando quell'edificio crollava per conto suo sotto molteplici spinte: la contraddizione oggettiva tra scolarizzazione di massa e vecchia scuola di classe, la diffusione dell'istruzione come consumo di diplomi, le conseguenze e i riflessi delle contraddizioni e della degradazione introdotte nella società dal consumismo di massa, dalle tendenze corporative, dalla diffusione della piccola borghesia e delle sue ideologie. Tra questo oggettivo precipitare della crisi della scuola e la contestazione studentesca vi è stata una non casuale coincidenza temporale — la radice comune è la crisi del vecchio assetto sociale — e l'estremismo e l'irrazionalismo che intorbidavano il sessantotto si sono poi davvero intrecciati e sommati in un processo di degradazione.
Quest'ultimo dato può essere individuato con esattezza all'interno di alcuni
fenomeni e problemi dei quali si è molto parlato. Faccio due esempi: gli appelli
mensili di esami e i cosiddetti seminari. Gli esami mensili, anche se talvolta
possono avere qualche giustificazione, disturbano il corso regolare degli studi,
sono il contrassegno di un'università disgregata, dove lo studio è al massimo
individuale, e dove ogni processo formativo comune è stato bandito.
Essi, certamente, sono stati richiesti e imposti con forza dagli studenti
estremisti, che per obiettivi di tal fatta sono riusciti a trovare un piú largo
consenso, almeno passivo. Ma sono stati altresí concessi rapidamente e senza
colpo ferire anche da docenti conservatori e reazionari,
anzi soprattutto da loro:
era questo un modo per realizzare un tacito scambio, e lasciare liberi docenti e
studenti, ciascuno per la sua parte, di fare tranquilli i propri comodi: meglio
gli appelli mensili e la degradazione degli studi che una scuola riformata, un
impegno piú duro, il confronto sulle questioni reali dello studio e della
ricerca. I seminari racchiudono un principio in sé prezioso di studio e di
elaborazione collettiva; ma sappiamo a che cosa generalmente si siano ridotti,
con la finzione dello studio, a volte con la scarsa serietà dei temi proposti,
tanto da divenire trappole per evitare l'esame e ogni forma di controllo
effettivo sullo studio e sulla formazione. Ma anche questo non lo si può
ascrivere alla contestazione. La proliferazione dei seminari, generalmente
affidati a insegnanti «precari» i quali spesso non erano in condizione di
insegnare alcunché, è stata, nella nuova situazione e in presenza di
un'enorme crescita del numero degli studenti, anche uno strumento di
consolidamento delle baronie cattedratiche: da un lato si organizzava
una piú vasta rete di potere accademico, dall'altra si ammortizzava la spinta
della contestazione, e si manteneva per molti docenti la libertà di darsi ad
attività estranee all'insegnamento, ottenendo però dagli studenti certificati di
«buona condotta» democratica.
|