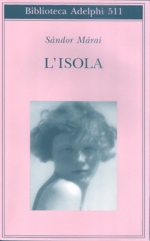
|
|
|
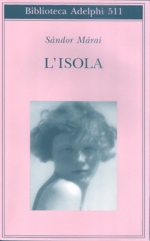
|
|
|
| << | < | > | >> |Pagina 11Il caffè veniva servito sulla terrazza, all'ombra di grandi ombrelloni dai colori vivaci. Il primo a lasciare la sala da pranzo comune fu il sudatissimo fabbricante di porcellane, il portavoce della tavolata tedesca dalla battuta sempre pronta. Era rasato a zero e, tra una portata e l'altra, sapeva tamburellare con coltello e forchetta, sul tavolo o sul bordo del piatto, le canzonette più in voga con fare invitante. «Nimm dich in Acht vor blonden Frauen» si mette a cantare alla maniera di una popolare attrice del cinema ogni volta che la padrona di casa, la direttrice dell'Hotel Argentina dai capelli color paglia, fa il suo ingresso nella sala. Questo giocoso invito a stare in guardia dalle bionde, carico di velate allusioni mercenarie, suscita sempre, e a buon diritto, l'ilarità generale. Il fabbricante di porcellane indossa la sua divisa estiva – calzoni di tela olona gialla, camicia sportiva senza colletto sbottonata sul petto carnoso abbrustolito dal sole e coperto di peli brizzolati, bretelle decorate da ricami bavaresi che sembrano cinghie da tapparella, occhiali gialli con la montatura d'osso, e berretto di stoffa bianco – come un costume da clown in una recita di dilettanti. Giunto alla porta che dava sulla terrazza, e dalla cui soglia si scorgeva già il mare, si arrestò e indietreggiò atterrito. «Schon übertrieben», che esagerazione, disse nel suo consueto stile telegrafico, scandendo le sillabe in tono sfacciatamente stridulo, a voce così alta che lo sentirono fin dentro la sala da pranzo. Girò la testa e, con l'aria di chi assiste impotente a un'imprevista catastrofe, sbatté le palpebre fissando il mare e il cielo. Si voltò verso il termometro appeso sopra lo stipite della porta e, alzandosi sulla punta dei piedi, strizzò gli occhi, come se il suo sguardo miope, abituato ai normali parametri terrestri, non riuscisse nemmeno a scorgere la sommità della colonnina di mercurio, e in tono sommesso, quasi riverente, lesse quanti gradi segnava. «Achtunddreissig» balbettò, ansimando ritmicamente a ogni sillaba. Nella sua voce si avvertiva l'ammirazione dell'uomo contemporaneo per i record. Spalancò con un calcio la porta a vetri della sala da pranzo, e urlò in direzione dei commensali: «Achtunddreissig im Schatten». Poi, siccome il coro invisibile non aveva degnato di alcuna risposta nemmeno quel grido d'allarme, mormorò tra sé: «Alle Achtung», mica male. Dopodiché, strascicando sul pavimento rovente della terrazza i piedi calzati in scarpe da tennis, andò ad afflosciarsi sull'unica sedia a sdraio all'ombra degli ulivi che si ergevano oltre la balaustra. Rimase così per qualche minuto, da solo. Poi estrasse dalla tasca dei calzoni la copia accuratamente ripiegata di un giornale tedesco. Sembrava quasi volesse indurre coloro che in quel momento se ne stavano in qualche modo al riparo dietro le imposte chiuse, tra sibilanti correnti d'aria, accanto ai loro bicchieri d'acqua minerale ghiacciata e a ciò che rimaneva dei gelati miseramente sciolti nelle coppe, a prendere coscienza della gravità della situazione. Trentotto gradi all'ombra! Mentre stavano ancora pranzando, di fronte all'edificio era apparso un venditore ambulante del luogo che ora aveva cominciato a sciorinare sulla balaustra della terrazza i propri manufatti, tovaglie, scialli e copriletto dai colori vivaci. Al di là della balaustra, si scorgevano il campo da tennis e l'orto che digradava verso il mare; dalla terrazza partiva una scala stretta e ricoperta di ciottoli che conduceva serpeggiando fino alla spiaggia. Il venditore ambulante andava su e giù per la scala, in silenzio, con nobile lentezza. Aveva preso dei sassi dal giardino, e li aveva usati per tener ferme le sue stoffe, che di tanto in tanto la torrida brezza spirante dal mare faceva svolazzare. Con le sue babbucce nere di cotone, le calze bianche di lana, i pantaloni di pelle scamosciata di un nero ormai sbiadito e la giubba a maniche corte filettata di rosso che gli copriva il torso smilzo fino alla vita, l'ambulante andava su e giù senza fare il minimo rumore, con una malinconia ingenua ed elegante, come se stesse prendendo parte a una strana cerimonia funebre. I colori e i disegni dei ricami e dei tessuti si armonizzavano con le linee smussate del paesaggio, con il profilo duro e triste delle rocce, con le tonalità spente della vegetazione riarsa dal sole. Circondato dalle sue stoffe, l'uomo, con quei gesti lenti e composti, si confondeva con il paesaggio, si mimetizzava alla perfezione tra gli ulivi e i cespugli di semprevivo. Dopo un po' andò a sedersi in cima alla scala, guardando dinanzi a sé con aria umile e smarrita, come in attesa di qualcosa, e distese le labbra in un sorriso. La tavolata tedesca apparve sulla porta, compatta come una schiera di soldati, vociante e spensierata come chi si sente al sicuro da ogni pericolo perché sa che l'unione fa la forza. A guidare il corteo era la coppia che si sedeva sempre a capotavola, formata da una signora ossuta, bruna, con un viso gradevole, e dal suo consorte, il quale, dando prova di un notevole anticonformismo, si presentava in pigiama anche all'ora di pranzo. Costui, precedendo di poco sua moglie, attraversò la terrazza, aggiustandosi gli occhiali sul naso camuso, a passi incerti da miope ma con la pancia protesa in avanti, con il carisma e la fermezza di un capotribù che guida la propria gente per una steppa irta di pericoli. Anch'essi si accorsero che faceva molto caldo. Le signore indossavano abiti colorati di tessuto dozzinale, intrisi di sudore. La calura a quell'ora diventava intollerabile, così opprimente e vischiosa che ogni corpo suscitava un'impressione di disagio e di sporcizia. Unica eccezione in mezzo al gruppo dei tedeschi era una donna dagli occhi grigi e dai capelli biondo cenere, che nel suo abito candido sembrava fresca come una rosa: si muoveva in quell'afa appiccicosa con la disinvoltura tipica delle donne anemiche dalla pelle bianchissima, quasi si trovasse nel proprio elemento, con aria altera, conscia di essere l'unica, tra tutti quei corpi fradici e ordinari, capace di resistere alle avversità del clima. Il suo corpo rifletteva le onde termiche, come se i suoi esili muscoli fossero ricoperti non dalla pelle, ma da un sottile strato di amianto. «Achtunddreissig!» esclamano boccheggiando anche i nuovi arrivati, e tra risolini imbarazzati cominciano a disquisire del clima. Considerata la stagione, la temperatura è effettivamente eccezionale, persino per questo luogo, uno degli angoli più meridionali e notoriamente afosi dell Adriatico. Un signore di Belgrado, funzionario ministeriale, dalla cui barba corvina e squadrata alla Enrico IV gocciolano unte stille di sudore, ricorda che quattordici anni addietro in quello stesso mese pioveva a dirotto, spirava un vento freddo, e solo i più temerari osavano fare il bagno in mare. La maggior parte dei membri del gruppo si era accomodata sulla terrazza. Le sedie a sdraio erano attaccaticce per l'umidità. Il venditore ambulante si alzò in piedi, come se fosse finalmente giunto il suo momento, e allontanandosi dalle stoffe si fece avanti sorridendo. Ma le signore si guardavano attorno con un'espressione languidamente perplessa, e alla fine rimasero tutti immobili. Proprio come certi insetti, che davanti al pericolo si fingono morti. | << | < | > | >> |Pagina 47Trascorse quasi sempre sveglio le ventiquattr'ore del breve viaggio, la notte non scese nemmeno nella sua cabina, si allungò su una sedia a sdraio in un angolo riparato dal vento del ponte di coperta, sonnecchiando e svegliandosi di soprassalto. Viaggiarono sotto un cielo stellato e senza nubi. Il giorno dopo, verso mezzogiorno, la nebbia calda del mattino si diradò e sull'acqua cominciò a spirare un vento rovente; solo la corrente d'aria provocata dal movimento della nave mitigava il senso di oppressione che dava lo scirocco. Svogliatamente gettò un'occhiata in giro per la nave, osservò la sala da pranzo che, con la sua eleganza un po' antiquata, ricordava in tutto e per tutto la sala di prima classe del ristorante di una stazione ferroviaria austriaca di provincia, e il salone, dove vecchie cartoline di località tedesche giacevano sparse sui tavoli ricoperti da lastre di vetro; copie sgualcite di giornali umoristici serbi erano a disposizione degli ospiti per i loro momenti di svago e alle pareti, accanto ai ritratti fotografici a grandezza naturale del re e della regina, era appesa una serie di vecchie vignette del «Punch» che raffiguravano scene di derby e le amenità della vita di mare. Il soffocante provincialismo di quell'ambiente lo fece sentire ancora più depresso. Era tormentato da mille dubbi: aveva fatto bene a cedere alle insistenze dei suoi amici che gli consigliavano «due settimane in un posticino tranquillo» e a spingersi fin laggiù, in uno degli angoli più sperduti del mondo, dove tutto gli pareva così meschino, il paesaggio e per certi versi persino il mare, un posto in cui ci si imbatte nella versione galleggiante dei ristoranti delle stazioni austriache, dove soffia un vento afoso, e dove – era questo, soprattutto, a farlo sentire triste e colpevole – non c'era assolutamente niente che lo attraesse in modo particolare? Rimase lì per ore, sdraiato sul ponte, immobile, con le mani intrecciate sotto la nuca, a contemplare il panorama della costa che sfilava poco distante. Sulla riva apparivano minuscoli borghi medioevali, con le loro casette ammassate l'una sull'altra, di un bianco accecante nella luce fulgida di mezzogiorno, paesi lindi e malinconici, qualche campanile qua e là, e sulla facciata degli edifici si vedeva scodinzolare il leone alato di Venezia, avventuratosi fino a quei remoti lidi; in un porto vide un anziano prete con un berretto di velluto verde che mangiava un'arancia con l'avidità tipica dei vecchi e guardava la nave con aria ingenua, asciugandosi di tanto in tanto sulla tonaca le mani appiccicose di succo d'arancia; e sopra il gruppo di oziosi che bighellonava lungo le banchine, sopra il paesaggio e le piccole città visibilmente rassegnate alla banalità del loro destino, fiammeggiava simile al fato crudele l'inesorabile solleone. Non hanno letteratura, pensò apatico, con un clima del genere non sarebbe nemmeno possibile. Nella loro lingua ci sono troppe consonanti. Non riteneva che valesse la pena di sollevarsi dalla sdraio per degnare della sua attenzione i minuscoli porti e correre a mescolarsi agli altri passeggeri affacciati alla balaustra del ponte che ammiravano a bocca aperta il paesaggio costiero. Non erano in molti a viaggiare su quella nave; si trattava in gran parte di turisti tedeschi, comitive di vacanzieri piuttosto chiassosi e socievoli che già a poche ore dalla partenza brindavano alle nuove amicizie. Tutto questo lo attraeva assai poco. Provinciali, pensò con noncuranza, stiracchiandosi sulla confortevole sdraio, nave da provinciali, paesaggio provinciale, destini provinciali. È stato un grosso sbaglio venire fin qui. Ma che succede?, si rimproverò subito dopo, rianimandosi un po'. Che razza di mentalità è questa? Che vuol dire «provinciale»? Il mondo in sé è generalmente provinciale. Da quando in qua, e soprattutto per quale motivo si permetteva di giudicare paesaggi e destini umani con la sprezzante arroganza dell'uomo metropolitano? Che razza di prospettiva era mai quella, il punto di vista lagnoso e stucchevole di una ballerina da cabaret parigino? Non riusciva a capire. Però è davvero provinciale, continuava ostinatamente a pensare. Si sentiva a disagio. In qualche maniera quel mondo gli andava stretto, era un mondo frusto, il mondo da quattro soldi di trasognate vedute da cartolina... e improvvisamente gli venne il sospetto di avere una gran paura di quel mondo ristretto e tranquillo, paura di dover vivere contando solo su se stesso, fra attrazioni turistiche di scarso interesse e incapaci di distrarlo, e che quell'inconsueto timore di tutto ciò che è «provinciale» altro non fosse che la straziante nostalgia della metropoli che era stato costretto ad abbandonare, dove gli bastava andare in giro per strada per sentirsi bene. Ma non osava confessare per quale motivo si sentiva così bene andando in giro per le strade di una certa metropoli.In ogni modo lui aveva paura dei «posticini tranquilli» che parenti e amici gli avevano dipinto a tinte così piacevoli e rassicuranti innanzitutto lo annoiavano. Anche questo è destino, si disse. Non gli era mai riuscito di trascorrere le vacanze estive in un luogo che non fosse noioso, austero, anonimo. Tutti coloro che ci circondano e forse pure noi stessi traiamo dal nostro temperamento delle conclusioni un po' affrettate su quale debba essere la nostra condotta, una condotta che siamo poi obbligati a tenere fino alla fine dei nostri giorni. Tutti, anche i suoi genitori e in seguito sua moglie, sua figlia, i suoi dipendenti e colleghi, ritenevano assolutamente naturale che lui, Viktor Henrik Askenasi, non potesse trascorrere le proprie ferie se non in «posticini tranquilli», e cioè lungi dal volgare baccano degli svaghi mondani, in una di quelle località straordinariamente serie e notoriamente noiose che in genere le masse di vacanzieri vocianti e ridanciani, dalla dubbia moralità, amanti delle danze e dei divertimenti più grossolani, e sprezzanti del «sano riposo», evitano come la peste. | << | < | > | >> |Pagina 82Sua moglie era seduta su una poltrona accanto alla finestra, vestita di tutto punto, in abito da giorno; in un primo momento Askenasi non capì esattamente se fosse seduta lì da un pezzo – magari dalla sera prima – oppure si fosse alzata molto presto al mattino e si fosse vestita solo allora; del resto anche il letto era perfettamente intatto. Si sedette sul bordo del materasso di fronte a lei e scosse la testa. La donna lo guardava senza dire una parola e lui, come se vedesse per la prima volta quel viso bianchissimo, ne osservò con curiosità i lineamenti familiari eppure così estranei. Che bella donna, pensò con una specie di cavalleresca ammirazione. Bellissima. Molto più bella dell'altra. Era quasi sul punto di dirglielo; ma si trattenne, perché gli venne in mente che in quel momento e in quelle circostanze un simile complimento sarebbe stato alquanto inopportuno.
Del resto, nessuno dei due provava un gran bisogno di discutere. Restarono
seduti così a lungo, immobili; forse addirittura per ore; Askenasi in seguito
ricordò di aver sentito un rumore di stoviglie provenire dalla stanza accanto,
stavano apparecchiando
per il pranzo o forse sparecchiando la tavola della
colazione, e di aver udito pure la voce della sua
bambina che parlava alla cameriera. Riteneva verosimile che non solo Anna, ma
pure sua figlia, la domestica e tutti in generale sapessero esattamente
quel che era accaduto. Anche senza bisogno di spiegazioni, tutti sapevano che a
Viktor Henrik Askenasi, all'età di quarantasette anni, era accaduto qualcosa che
era difficile da spiegare, da giustificare o
da cambiare, come se nel pomeriggio del giorno
precedente fosse stato investito da un tram, o gli fosse stato diagnosticato un
cancro; ormai nessuno poteva più fare nulla, la cosa fondamentale era mantenere
la calma e attendere gli sviluppi. Lui in realtà
avrebbe avuto voglia di intavolare una conversazione amichevole, di condividere
con Anna quell'esperienza, così come avevano condiviso tutto fino allora; gli
pareva impossibile che lei non si rallegrasse
del fatto che gli fosse finalmente accaduto qualcosa
di così eccezionale e meraviglioso. Ma non trovava
le parole adatte per comunicare quella grande gioia. Le parole che lui conosceva
così bene, delle quali sapeva indagare le radici più remote e oscure, con
le quali lavorava come il muratore lavora con i mattoni, adesso gli sembravano
strumenti rozzi e inservibili, ricavati da una materia grezza ed estranea.
Evidentemente, rifletté mentre se ne stava seduto
sul bordo del letto, con il cappello in mano, di fronte ad Anna, la donna con la
quale aveva vissuto e dormito per quindici anni in quella stanza e in quel
letto, la vita è fatta di una materia diversa da quella
che ho conosciuto finora. Anche la lingua è una materia estranea, è solo un
insieme di segni, di istruzioni, come la scrittura ideografica. Per dire
qualcosa si dovrebbe prima tradurla. Quest'idea lo tenne occupato per un po'.
Quel lungo tacere era l'unica forma di comunicazione, l'unica possibilità di
dialogo in quel momento. Sentiva di non aver mai discusso
con nessuno con tale foga, profondità e ricchezza di
argomenti come durante quel silenzio. Anna non
aveva pianto; era molto pallida, ma i suoi occhi non
erano arrossati; sedeva con la schiena eretta, con un
contegno un po' severo, lo scialle di pizzo sulle spalle, le braccia conserte.
Forse ne morirà, pensò Askenasi freddamente, di sfuggita. Sarebbe tremendo.
Che cosa si deve fare in queste circostanze? Ma non
gli veniva in mente nessuna soluzione. Allo stesso
tempo aveva la certezza che Anna non sarebbe morta: Anna era molto più forte,
anche ora, mentre se ne stava seduta lì di fronte a lui in un silenzio più
assordante di qualsiasi urlo, mentre discutevano in
quella lingua, la «vera» lingua, una sorta d'idioma
sconosciuto – era lui, Askenasi, ad avere ragione, eppure era l'altra a gridare
più di lui. È lei la più forte, pensò pieno di stupore, come chi batte le mani
in preda alla meraviglia rendendosi conto di quanto
sia ingiusta la vita. Lei ce la farà e sarò io a soccombere! Questo gli sembrava
indecente e iniquo, offendeva il suo senso di giustizia. Con le sopracciglia
aggrottate guardava fisso dinanzi a sé con aria sdegnata. In quelle ore si
dibatteva finalmente la causa più importante della sua vita, e lui lo sapeva;
ne era quasi felice, come un imputato che al termine di un
lungo periodo di carcerazione preventiva si rallegri
di esser giunto all'udienza finale, quale che sia il
verdetto, e che però allo stesso tempo vorrebbe protestare, perché c'è stato un
malinteso, i ruoli sono stati scambiati, qui lui non è imputato, bensì parte
lesa. Anna lo guardava senza batter ciglio, e si fissavano a vicenda quasi
sfrontatamente, come se avessero scoperto l'uno nell'altro una specie di nuova e
atroce nudità – una nudità insostenibilmente oscena. Lanciò uno sguardo irato
verso Anna, perché era ormai certo che Anna fosse la più forte tra loro
due, a dispetto di ogni legge e giustizia. Sapeva che
era cominciato qualcosa – e certamente non era cominciato il giorno precedente
alle tre del pomeriggio, in una pensione di infima categoria, né riguardava
soltanto il suo rapporto con Anna e con la sconosciuta, o il fatto che di lì a
poco se ne sarebbe andato via, avrebbe abbandonato quella casa, la sua
bambina, Anna, il suo lavoro, le convenzioni in generale, e sarebbe andato a
vivere con un'altra donna, in un'altra casa, secondo altre convenzioni –, e
che tutto questo era solo un aspetto secondario, un
dettaglio di quel processo o esperienza che stava incominciando, e che anche la
sconosciuta sarebbe uscita dalla sua vita, ma quel processo sarebbe continuato,
e il soggetto, il fine ultimo era lo stesso Askenasi, e non soltanto quel che
lui era adesso, mentre se ne stava lì con il cappello in mano, a quarantasette
anni, con la sua calvizie e gli occhiali, di fronte a
sua moglie, ma anche qualcos'altro: il destino di una persona, un ideale che
crolla in circostanze tanto vili e insignificanti come lo erano Askenasi, quella
stanza, Anna e la sconosciuta alla pensione. Non era
necessario, né sarebbe stato opportuno, spiegare
che cosa gli era successo – come se, a proposito di un
terremoto, qualcuno spiegasse che non è colpa sua,
rammaricandosi dell'accaduto e chiedendo scusa perché un mondo intero sta
sprofondando insieme a lui. In quel momento non poteva davvero spiegare
se stesso ad Anna, né tanto meno avrebbe potuto
spiegarlo a un'altra Anna, poiché egli stesso cominciava solo ora a capire
qualcosa, balbettando e sforzandosi come un bambino che impara una lingua
straniera.
|