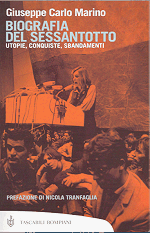
|
|
|
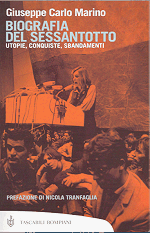
|
|
|
| << | < | > | >> |Indice
Prefazione di Nicola Tranfaglia V
Nota introduttiva XI
I "FIGLI DELLA GUERRA" E
I TEMPI DELL'AMBIGUA DEMOCRAZIA
Quale democrazia? E come? 3
Scudo crociato e falce e martello 20
La modernità tra movimento operaio e capitalismo 28
Una difficile iniziazione alla politica 37
Una gioventù in bilico tra continuità e rottura 47
La trasgressiva e ritmica beat generation 60
Verso un impegno politico conflittuale 70
Il violento engagement dei neofascisti 80
Le origini dei movimenti di base 88
LA RIVOLUZIONE IN ATTESA E
L'ATTESA DELLA RIVOLUZIONE
Dagli anni bui agli anni solari 97
Gli integrati e l'impegno per la democrazia 102
La formazione delle correnti "apocalittiche" 112
La tempesta del signor Tambroni 120
Vincitori e vinti di fronte al centro-sinistra 132
IDEE E PASSIONI DELL'ESTREMISMO DI SINISTRA
Contro l'abominevole 141
L'aggregazione riformista e i suoi avversari 145
Nuova società e neocomunismo 155
Nascono i gruppettari 169
Creatività, femminismo e liberazione sessuale 177
La Cina e i "marziani" d'Occidente 184
IDEE E PASSIONI DELL'ESTREMISMO DI DESTRA
Nero profondo 203
All'armi siam fascisti! 206
Boia chi molla! L'antimodernità come progetto 213
Ripartire da Hitler o da Salò 220
Il "tira e molla" del Msi 230
E FECERO IL SESSANTOTTO
Un colpo di rasoio alla storia? 239
La koinè rivoluzionaria 248
Alle origini della grande contestazione 262
L'utopia in azione 273
Mito del futuro e riti di lotta 283
Principi, forme e fini della contestazione
globale 291
"Guardie rosse" contro "baroni" 300
Fascisti contro "guardie rosse" 309
Il Pci tra "Il Manifesto" e Potere operaio 324
Per un sommario bilancio critico 343
IL LUNGO SESSANTOTTO
Le due durate 351
Studenti e operai 356
Il Movimento studentesco tra Potere operaio
e Lotta continua 368
Gli schemi ideologici degli "opposti estremismi" 379
Il Pci tra affanno e rimonta 385
La tollerata violenza della destra 395
La lotta al potere e i fondamentalisti cattolici 407
L'espropriazione del Sessantotto 413
Il tempo delle Erinni 420
Antirepressione e guerriglia,
Calabresi e Saltarelli 431
Premesse per una conclusione 456
EPILOGO. DAL SESSANTOTTO ALLA CRISI DELLA STORIA
Il blocco dell'anima 465
Due teoremi 470
Come gli etruschi 478
Post Scriptum 482
Nota bibliografica 484
Indice dei nomi 491
|
| << | < | > | >> |Pagina 239Il Sessantotto cominciò molto prima del 1968 e si concluse molto dopo, anche se quell'anno – come, del resto, era già accaduto nel secolo precedente per il 1848 – ha assunto da tempo un valore quasi canonico per la storiografia, ai fini della periodizzazione degli eventi del XX secolo. Sia gli storici che la comune opinione sono soliti rappresentarselo come la data di un netto processo di rottura tra il prima e il dopo. Di esso e dei suoi postumi fu incontrastata protagonista la generazione politica costituita dai figli del dopoguerra, che abbiamo già visto all'opera fin dalla prima metà del decennio. Una generazione che fruiva ancora degli apporti di numerosi elementi di quella immediatamente precedente (i figli della guerra) e delle nuove leve emergenti dei figli del miracolo economico. Di fatto, le varie componenti generazionali si fusero in un'unica aggregazione giovanile, dotata di comune sensibilità e alimentata da comuni ideali, che andò incontro a una lunga stagione, durata quasi per l'intero secolo e destinata, per varie vie individuali o collettive, a incidere in profondità sulla trasformazione culturale e sociale del Paese. I protagonisti di tale lunga stagione avrebbero in genere condiviso la sorte di essere riassorbiti da un'avvilente normalità, tutt'altro che corrispondente ai loro progetti originari o, per meglio dire, ai loro sogni giovanili. Condannati a non avere veri e propri successori politici, spesso avrebbero finito con l'essere ingenerosi con se stessi, lasciandosi sopraffare da sensazioni di fallimento e di impotenza; sensazioni, come vedremo, eccessive e non propriamente fondate. Alcuni si sarebbero avvitati su se stessi in uno strano pudore e si sarebbero chiusi nel silenzio, per motivi che avremo modo di approfondire nell'epilogo di questo libro; altri avrebbero tentato di forzare la sorte con avventure estreme e scriteriate. L'analisi dei fatti farà emergere i motivi oggettivi che furono all'origine della sfortuna finale di quell'esperienza, pur segnata fin dai suoi esordi, e per lungo tempo, da vibranti entusiasmi e da passioni travolgenti: un'esperienza per molti versi eccezionale e irripetibile, che si svolse in un orizzonte nazionale che si integrò con il mondo intero, nel quale si mossero, sotto la spinta di una generosa utopia, numerosi soggetti collettivi e singoli individui tra loro diversificati nella ricerca degli strumenti per realizzare i propri ideali, impegnati in uno sforzo di emulazione reciproca e normalmente discordi e litigiosi, ma in un comune alveo di protesta, di rivolta e di lotta contro la realtà di un tempo avvertito come avverso, ingiusto e mediocre. Passo dopo passo, entreremo nella storia vitalissima e drammatica di questi giovani di cui, per quanto riguarda lo specifico scenario italiano, già conosciamo le premesse. La scelta di concentrare l'attenzione prevalentemente su uno spazio nazionale non deve far mai dimenticare l'orizzonte mondiale del processo. Solo in tale orizzonte, infatti, gli eventi di casa nostra possono trovare adeguate spiegazioni, giacché il Sessantotto, nel suo complesso, realizzò quella che potrebbe dirsi una prima esperienza di globalizzazione culturale della gioventù nell'Occidente capitalistico; e non solo in esso, se si pensa allo slancio drammatico e sfortunato della Primavera di Praga nell'Est comunista. | << | < | > | >> |Pagina 248Quale fu il collante delle diversità? Che cosa le rese compatibili, favorendo sinergie spontanee? Si è già accennato all'importanza unificante della comune vocazione antimperialistica, interpretabile come aspetto pubblico e politico dell'avversione dei giovani verso l'autoritarismo privato esercitato da padri e maestri, e delle donne verso quello esercitato dai maschi in genere. Al di là degli specifici numi venerati dai singoli gruppi, l'antimperialismo aveva le sue bandiere, i suoi ritratti da portare in processione e i suoi nomi-simbolo, al di sopra delle parti, da gridare nelle piazze: Fidel Castro, il Che, Ho Chi Minh, Mao Tse-tung, e un nome che indicava il comune Paese dell'anima: Vietnam. Che cosa significasse il Vietnam nell'immaginario dei sessantottini, l'avrebbe ben spiegato un documento studentesco: "Il Vietnam è importante perché è la dimostrazione pratica di come l'organizzazione politica e umana possa sconfiggere qualunque tipo di apparato tecnologico". L'intera sinistra giovanile era convinta che il Vietnam fosse il banco di prova della capacità dell'utopia di battere in tutti i suoi aspetti – e non soltanto sul terreno dello scontro con l'imperialismo – il cinico realismo del sistema capitalistico. Con le mani e con il cuore, con l'intelligenza politica di un popolo contadino eroicamente in guerra contro il più moderno e potente esercito del mondo; con la stessa travolgente energia di cui stavano dando prova in Cina le guardie rosse della rivoluzione culturale, usando armi insolite per la loro offensiva antiburocratica (la provocazione creativa, l'ironia, e infine – così si credeva, eludendo le domande sulle crudeltà connaturate a quegli eventi – lo strumento punitivo della gogna, per mettere fuori gioco, insieme ai controrivoluzionari, tutti gli attuali e potenziali corrotti e i corruttori). Temi, questi, ai quali si è già accennato esaminando il repertorio ideale del terzomondismo, e dei quali è da evidenziare adesso il particolare ruolo ideologico generale che avrebbero sempre più nettamente svolto nella cultura giovanile, quali fattori regolativi della koinè rivoluzionaria. Temi assai suggestivi ed efficaci per assicurare un fondamento ecumenico all'utopia di un mondo migliore nascente dalla catastrofe del capitalismo, unificando la propaganda e il linguaggio dei gruppi al di sopra delle loro specifiche diversità. La comune passione militante per Ho Chi Minh metteva immediatamente d'accordo le correnti pacifiste e non violente (sia laiche che "evangeliche") con quelle marxiste e specificamente maoiste, favorevoli allo scontro, inevitabilmente armato, con la "tigre di carta" dell'imperialismo. Oltretutto nel Vietnam era già in corso da tempo un sottile confronto, una competizione, tra Urss e Cina, e tra entrambe e i partiti comunisti, sulla questione della coesistenza pacifica e sul ruolo rivoluzionario del Terzo mondo. [...] L'andamento unitario delle manifestazioni antimperialiste, con quel particolare tipo di intellettualità progressista e umanitaria a tutto campo, si sarebbe confermato e addirittura rafforzato per molto tempo dopo il 1967. In quell'anno, in particolare, l'emozione raggiunse il diapason in seguito all'assassinio del Che, in Bolivia. Ma sarebbero emersi dallo scenario mondiale della guerra fredda altri eventi e processi capaci di produrre analoghe emozioni. Sempre nel 1967 erano cominciate le manifestazioni contro lo scià di Persia, Reza Pahlavi, e la moglie Farah Diba, indicati come mostri simbolici del consumismo capitalistico e del vassallaggio ai poteri imperialistici mondiali. Nel settembre-ottobre del medesimo anno si estesero da Milano in numerose aree e città del Paese le proteste contro la Bolivia, proseguite nell'anno successivo con quelle per l'arresto e la condanna del giornalista francese Roger Debray. Poi sarebbe stata la volta della "solidarietà militante con gli studenti messicani", gli oltre cento giovani massacrati dalla polizia in apertura dei giochi olimpici, nella tremenda giornata di sangue della piazza delle Tre Culture di città del Messico conclusasi con la morte di circa cinquecento persone, poi cremate in una caserma: Il perché della morte degli studenti messicani uccisi, feriti ed arrestati è il perché dei 400.000 vietnamiti sterminati dal napalm. È il perché della morte di Che Guevara, di Camillo Torres, è il perché dei milioni di morti per fame, malattie, miseria ed indigenza in Asia, Africa e Medio Oriente. È la logica dell'imperialismo, dello sfruttamento, del capitalismo. Il sangue degli studenti messicani è lo stesso dei minatori cileni, degli indios boliviani, dei vietcong, il sangue degli studenti francesi, statunitensi, italiani, scientificamente eliminati nella speranza di far tacere le loro istanze di libertà, uguaglianza, democrazia, il sangue degli operai che vengono stritolati nelle officine dalle macchine, dei lavoratori delle campagne dimenticati dallo sviluppo tecnologico. La sopravvivenza dell'imperialismo è garantita solo dalla brutalità che esso esercita quotidianamente sulle classi e sui popoli oppressi, sia che si presenti sotto la forma dello sfruttamento salariale sia che intervenga armato. La legge di questa logica è l'eliminazione fisica di chi si oppone. In quanto sfruttati, violentati nelle coscienze, castrati nelle facoltà creative e impossibilitati nell'esercizio della libertà e dell'autodecisione, per tutto questo noi diciamo che il massacro degli studenti messicani, dei vietnamiti, dei guerriglieri e delle popolazioni asiatiche e latino-americane è un massacro che coinvolge tutti noi. Dopo i fatti messicani, negli anni a venire ci sarebbe stato da trepidare e da protestare per gli esiti assai infelici della Primavera di Praga, per la Cambogia invasa dagli americani, per l'Africa asservita agli interessi neocolonialistici, per il gollismo in Francia e per l'Algeria ancora insidiata dai resti dell'Oas; poi per la Grecia che si era fascistizzata con il regime dei colonnelli e, più in là, per il Cile caduto sotto la dittatura militare del generale Pinochet. Faceva parte del repertorio delle trepidazioni l'attenzione costante per il dramma del popolo palestinese. Per lungo tempo, ogni movenza dell'allarme o della protesta, per vari canali interpretativi, sarebbe sempre stata ricondotta sia ai pericoli di colpi di stato in Italia e alle croci quotidiane della classe operaia, sia alla complessa dimensione simbolica (tragedia e speranza, oppressione e liberazione) del caso vietnamita. Nell'insieme, a partire dal biennio 1967-1968, la fusione emozionale nell'antimperialismo prese forma in una vera e propria cultura giovanile che d'ora innanzi chiameremo "cultura sessantottina". Quella cultura, in definitiva, parlava una sola lingua, con la sua logica, la sua sintassi. Per questo motivo tanti individui sommamente gelosi della propria singolarità riuscivano a celebrare riti comuni, sollecitati da eventi che inducevano alla sintesi delle emozioni. Tra questi eventi, a parte quelli già ricordati, i principali dell'anno '68 sarebbero stati tre: l'assassinio di Martin Luther King, l'assassinio di Bob Kennedy e il Maggio francese. | << | < | > | >> |Pagina 262Insomma, il Sessantotto italiano cominciò in realtà negli ultimi mesi dell'anno 1967, e nessuno si accorse che stava avendo inizio qualcosa di dirompente per la storia. In un Paese ormai abituato agli scioperi e alle manifestazioni di piazza, sembrò piuttosto che si fosse aperto un ennesimo capitolo del conflitto sociale: un capitolo piuttosto strano, perché questa volta gli attori principali non ne erano i sindacati operai, ma tumultuose quanto improvvisate ed eterogenee aggregazioni di studenti riuniti in assemblee di base e dibattiti interminabili, dalle scuole medie alle università, non di rado con la complicità silenziosa o con la diretta e aperta partecipazione di uno stuolo di professori e professoresse. I precedenti del fenomeno, normalmente ignorati dalla storiografia sull'argomento, non mancavano: già nell'ormai lontano 1963, gli studenti di Architettura della Statale di Milano avevano occupato per sei giorni la Facoltà e già allora si era registrata "una capacità nuova del movimento universitario di porsi come forza unitaria e autonoma all'interno della lotta politica e sociale del Paese": gli architetti avevano architettato il primo soviet studentesco in Italia. Nell'organizzazione nazionale delle rappresentanze studentesche, da tempo era prevalso un orientamento segnato da un corale "non se ne può più dei baroni delle cattedre". Era stata infatti ancora l'Unuri a promuovere, all'inizio del 1964, una Giornata nazionale per l'autonomia e l'autogoverno dell'università "ad ogni livello degli studenti, degli assistenti e dei docenti". Nel quadro di un sistema in fibrillazione, un'altra occupazione era avvenuta quasi in sordina a Firenze, nel gennaio del 1965, contro il ministro Gui. Agli ormai lontani fatti torinesi del 1962 (la cosiddetta "battaglia" di piazza Statuto) si è già accennato innanzi. Un'altra esperienza inaugurale di quella che sarebbe stata la lunga vicenda delle occupazioni di sedi universitarie – un'esperienza non isolata, ma in sincronia con un'analoga mobilitazione a Pisa e in altre sedi – si era registrata alla Sapienza di Roma tra la fine di aprile e il maggio del 1966, sia per manifestare pubblica indignazione per l'assassinio dello studente Paolo Rossi, sia per protestare contro il potere accademico impersonato da Giuseppe Ugo Papi (secondo l'"Avanti!" "il rettore più antidemocratico che abbia avuto l'Italia in tutti i tempi"), accusato di parteggiare per i neofascisti. Le "avanguardie" di una volta – l'Unione goliardica italiana (Ugi) e la cattolica Intesa – che per circa un quindicennio avevano guidato insieme, nell'Unuri, la lotta per la democratizzazione degli Atenei, avevano esaurito la loro funzione e furono costrette ad avviarsi verso l'autoliquidazione da una folgorante iniziativa movimentistica di massa che non tollerava sigle riconducibili a partiti politici. Fu appunto questa la grande "contestazione": il Sessantotto. [...] L'establishment stentava a cogliere la rilevanza di dirompente tema politico generale che aveva assunto la questione del diritto allo studio: una questione che, a partire dalla scuola e dall'università, era in grado di espandersi a quella più vasta del "modello di sviluppo" e di coinvolgere il giudizio sull'assetto del potere e sull'intero sistema sociale, passando proprio dalla finestra della questione giovanile. Comunque erano sotto gli occhi di tutti, e preoccupavano soprattutto le autorità accademiche, i dati (sui quali abbiamo già avuto modo di riflettere) che evidenziavano una rapida e abnorme crescita della popolazione universitaria. A voler essere precisi nel giudizio, era ancora piuttosto impropria e azzardata la definizione di "università di massa", anche se in Italia – come ebbe a rilevare il ministro Gui – gli immatricolati avevano raggiunto un numero tra i più alti in Europa (332.096, più 93.370 fuori corso, nell'anno accademico 1966-67) e l'Ateneo di Roma, con i suoi 70.000 studenti, era il più grande del mondo. Indubbiamente l'impressione di una realtà elefantiaca destinata ad area di sofferenza e di stagnazione per i molti incapaci o falliti e scioperati che vi parcheggiavano dipendeva soprattutto dall'inadeguatezza delle strutture. Ma insistere, come si faceva, sul tema di un "disagio" determinato soprattutto da tale vistosa inadeguatezza equivaleva a non considerare gli aspetti classisti dell'accesso agli studi e delle successive selezioni, e a esorcizzare il problema del distacco crescente del mondo giovanile dall'establishment, ovvero a non vedere (o a fingere di non vedere) la radicalità di un'opposizione dai caratteri e dalle matrici generazionali che nessuna riforma tecnica del sistema dell'istruzione avrebbe potuto affievolire o eliminare. Il governo di centro-sinistra, guidato da Aldo Moro, si era incamminato sulla strada del riordino del sistema degli studi, rimasto pressoché fermo al quadro disegnato in età fascista, per adeguarlo alle trasformazioni prodotte dalla società di massa. Il ministro Gui, per fronteggiare le emergenze rivelate dalla rivolta studentesca, stava lavorando a un progetto per il riordino dell'università (ispirato largamente dal socialista Tristano Codignola) destinato a un difficoltoso tragitto parlamentare e alla fine bocciato sotto il fuoco incrociato dei baroni e delle destre, oltre che delle stesse sinistre, dal Pci ai gruppettari, che volevano di meglio e di più. Per quanto la cosa possa apparire paradossale, a breve si sarebbe visto che la lotta per il rinnovamento dell'università costituiva, per i sessantottini, poco più che un'esperienza di second'ordine, se non addirittura un pretesto, per marciare verso mete ben più impegnative e lontane. Questo orientamento del processo in corso fu evidente fin dalle origini, nel febbraio del 1967, sia in quell'epicentro politico di elezione da tempo costituito dall'Ateneo pisano, sia in quel vero e proprio laboratorio di alleanze sociali "rivoluzionarie" che cominciò a funzionare all'interno dell'Università di Torino, per l'impegno organizzativo di alcuni studenti intraprendenti, tra i quali Luigi Bobbio, il figlio del noto filosofo. A Pisa, l'avvio della grande "contestazione" animò febbrilmente la Sapienza di rivendicazioni mosse, nell'immediato, da istanze legate alla riforma universitaria e al diritto allo studio, ma spinte a puntare più in alto dalle forze locali del Potere operaio pisano e di altri gruppettari. Sempre in febbraio, a Torino, le medesime richieste, all'origine di una prima mobilitazione politica nelle sedi universitarie, furono il collante di iniziative a più vasto raggio, nella direzione del rapporto organico degli studenti con i metalmeccanici (già sperimentato sul campo nel 1962), che sarebbero culminate, a fine anno, i1 27 dicembre, nelle cariche della polizia contro gli studenti che, a Palazzo Campana, avevano occupato le Facoltà di Legge e di Lettere. Dai processi conflittuali di una vicenda all'inizio, per molti versi, eccezionale, in rapida e febbrile evoluzione a Torino, stava emergendo la candidatura a spiccati ruoli di avanguardia di alcune forze giovanili ancora piuttosto fluide ma comunque decisivamente influenzate dalle lezioni operaiste di Panzieri, di Tronti e dei "Quaderni rossi", nonché dalle specifiche posizioni estremistiche rappresentate, in un movimento in rapida formazione, da vivaci leader come Luigi Bobbio e Guido Viale (quest'ultimo autorevole collaboratore dei "Quaderni piacentini"). Il che non era certo casuale nella città della Fiat, di per se stessa simbolo e crocevia di verifica della condizione operaia dell'intero Paese. Il movimento torinese inaugurò, nel corso della prima occupazione di Palazzo Campana, l'esperienza dei controcorsi e dei lavori di gruppo degli studenti. Molto più legata, ai suoi esordi, allo specifico delle questioni universitarie, ma aperta a rapide evoluzioni verso più ampie "questioni di giustizia" che avrebbero inevitabilmente richiesto la ricerca di un rapporto con il movimento operaio, fu la mobilitazione studentesca a Milano, a partire da quello specialissimo Ateneo privato che era (ed è) la Cattolica del Sacro Cuore, un luogo dal quale nessuno in Italia avrebbe potuto seriamente aspettarsi il travolgente avvio della contestazione studentesca. I "luoghi" si sarebbero rapidamente moltiplicati, ampliando il quadro dei fermenti e delle prime prove di "lotta" della seconda metà del '67: c'erano, con la temperie degli studenti della Facoltà di Sociologia di Trento, le molte micce da tempo accese in varie sedi universitarie, mentre Pisa manteneva un ruolo trainante. Ogni luogo avrebbe avuto le sue specificità, talvolta con varianti e modalità d'espressione assai diverse, dato il carattere sempre sperimentale e informale dell'organizzazione del movimento. | << | < | > | >> |Pagina 278Se, a rileggere le cronache del tempo, lo storico rimane francamente frastornato, si può ben immaginare la confusione dei lettori non specialisti. Per fortuna, più che gli episodi di dettaglio (che pure hanno la loro rilevanza rappresentativa), sono importanti i ritmi dell'intera dinamica, l'andamento e il tono complessivo dell'azione.L'osservazione è valida anche per lo scontro più drammatico e vistoso della contestazione studentesca romana: la "battaglia" di Valle Giulia, di cui si erano avute avvisaglie fin dal 26 febbraio e che ebbe il suo culmine in un memorabile primo marzo in cui studenti e poliziotti (con l'ovvia partecipazione di provocatori, teppisti e neofascisti) si batterono per il controllo della Facoltà di Architettura; un evento che sarebbe stato presto caricato di un particolare valore simbolico, destinato successivamente a unire e a dividere, nonché a rappresentare nell'immaginario giovanile la primogenitura del Movimento studentesco italiano anche rispetto al Maggio francese, ancora di là da venire. La polizia aveva fatto un uso soverchiante di candelotti lacrimogeni e di manganelli contro il fronte unito (di sinistra, ma anche di destra) degli studenti ribelli i quali, a loro volta, avevano reagito duramente con pietre e spranghe, nonché dando alle fiamme alcune delle classiche jeep della Celere. Lo scontro, dalle movenze iniziali alla sua fase più acuta, aveva prodotto, sul campo, un centinaio di feriti. Di quell'episodio, Pier Paolo Pasolini (per alcuni versi anche lui un sessantottino) colse l'irritante natura di una prova di pura estetica della violenza e dell'aggressività dei figli di papà dediti al gioco della rivoluzione. Nel riferire sui fatti alla Camera dei deputati, il ministro dell'Interno Taviani azzardò qualche similitudine tra le agitazioni universitarie (riferendosi alle violenze di Valle Giulia) e lo squadrismo fascista. Gli fece subito da contrappunto l'indignata presa di posizione a favore degli studenti di un gruppo di docenti e ricercatori della Facoltà di Fisica, capeggiati dal noto scienziato professor Amaldi, che rilevarono in una lettera la grossolanità del paragone, aggiungendo perentoriamente: "se di fascismo si deve parlare, esso va individuato nei residui di legislazione fascista che ancora oggi strozzano le strutture universitarie". Quei professori si dicevano inoltre convinti che non si dovesse declassare il movimento a una kermesse di "esuberanza giovanile", perché la sua azione stava inaugurando un processo di elevato valore politico, volto a cambiare una situazione particolarmente intollerabile nella scuola e nell'università. Sante parole per tutti i rivoltosi che, decisi a continuare a oltranza le occupazioni, le lessero pubblicamente – in alternativa alle idee "autoritarie" del povero rettore d'Avack – nel corso dell'enorme raduno del 3 marzo a Villa Borghese, che si articolò in quattro commissioni di studio e alla fine partorì l'idea di convocare a Roma i rappresentanti degli altri Atenei italiani in agitazione per costituire un Coordinamento nazionale delle lotte degli studenti. Il famoso pittore Renato Guttuso, tra gli altri, aveva preso netta posizione a loro favore e, in opposizione a Pasolini, svolse il ruolo di principale padre nobile delle animazioni pubbliche contestuali al lavoro politico del raduno. Il movimento era di per sé ben poco coordinabile, e del resto non gradiva granché i coordinamenti, anche se si stava formando un insieme di capi riconosciuti e di suoi propri intellettuali, tra i quali, a livello nazionale, stavano conquistando chiara fama, da Pisa a Trento, da Roma a Torino, molti dei gruppettari citati innanzi, nella rete preparata in passato dalle redazioni delle riviste "Quaderni rossi", "Classe operaia" e "Quaderni piacentini". | << | < | > | >> |Pagina 291Gli organi di stampa, la televisione, i dirigenti dei grandi partiti di governo e di opposizione e un'opinione pubblica in gran parte costituita da un universo eterogeneo di padri sia borghesi che operai, in bilico tra allarme e curiosità e diviso al suo interno tra simpatia e irritazione (con punte favorevoli a una decisa repressione), erano soliti rivolgere a quegli irruenti figli ribelli l'accusa di agitarsi senza avere idee chiare sui fini della loro azione. Certamente eccedevano, con un giudizio così semplicistico e liquidatorio, ma c'è da riflettere sui fattori che ne erano all'origine. Di fronte alla "rivolta", un vasto aggregato generazionale di esclusi o di minacciati dal movimento tendeva in vario modo (spesso per opposti motivi a seconda che ci si trovasse su posizioni di sinistra ufficiale o di destra) a esorcizzarne i demoni libertario-rivoluzionari, ora declassandoli a espressioni di una scriteriata effervescenza giovanile, ora semplicemente negandone l'autenticità e facendone risalire le cause alla sobillazione dei gruppi estremistici. Gli stessi opinionisti liberal, come il già citato Egidio Sterpa – esempio dei padri illuminati che coglievano le radici esistenziali del processo in corso e ne avvertivano il fascino – sostanzialmente disconoscevano il valore politico della rivolta che, se accettato, li avrebbe costretti a prendere posizione sulla vertenza apertasi con il sistema capitalistico. Più facile era declassarla a mera protesta sociale e insistere nel sottolineare la babele dei suoi linguaggi e delle sue proposte. Chi scrive capisce bene siffatti giudizi perché, all'inizio, egli era tra quelli che li condividevano, ed è ben consapevole del peso e della fondamentale sensatezza delle osservazioni, allora formulate a caldo, da un punto di vista quasi opposto a quello di Sterpa, da Arturo Colombo, ancora sul "Corriere", in polemica con la definizione di "rivoluzione senza volto" inventata in Francia da Edgar Morin per definire quanto stava accadendo: Mi sembra che occorra [...] respingere l'immagine brillante ma inutile [...] proposta da Edgar Morin e sforzarsi di delineare il "volto" (o meglio i "volti") che vanno assumendo i diversi movimenti, andando al di là delle suggestive analisi folkloristiche [...]: Continuiamo a parlare di protesta "giovanile", ma in realtà se guardiamo più a fondo le cose come stanno in casa nostra e all'estero, dobbiamo ammettere che i protagonisti appartengono tutti (o quasi tutti) al mondo studentesco. L'ambiente contadino, che statisticamente ha un peso considerevole, sembra tagliato fuori da questa "febbre agitatoria", quasi a smentire lo schema maoista della campagna povera che assale e distrugge la città opulenta. E anche i giovani operai delle fabbriche, salvo le piccole frange di estremisti politicizzati, continuano a rimanere sordi al richiamo della famosa contestazione globale. Lo studioso e pubblicista milanese (il cui limite nell'analisi del movimento consisteva, tra l'altro, nell'incapacità di vedere l'estrazione contadina specifica di una parte rilevante degli studenti ribelli, cioè di quelli appartenenti a famiglie che stavano ancora vivendo il dramma del grande esodo dalle campagne del Mezzogiorno) aveva certamente una qualche ragione nel ritenere che fosse perlomeno improprio parlare genericamente di protesta giovanile, quando gli attori ne erano soprattutto gli studenti universitari. Ma, non avendo familiarità con i concetti marxisti di avanguardia e di egemonia, nel giudicare della portata del fenomeno egli evitava quasi deliberatamente di usare la parola rivoluzione (stigmatizzava Morin per aver osato farlo), in linea con il generale rifiuto della cultura borghese di riconoscere un credibile spessore politico alla contestazione. Certamente si sbagliava, non perché i rivoltosi non fossero per vari motivi dei velleitari nel considerarsi rivoluzionari, e nemmeno perché non fossero confusionari e spesso oscuri nel formulare progetti e ipotesi strategiche, ma perché è ben normale – si è già avuto modo di rilevarlo – che ogni processo di elaborazione rimesso all'inventiva della democrazia di base sia di per sé destinato a essere un frutto sempre incerto e precario di differenze e conflitti mai definitivamente risolvibili. Anzi, con un'equanime valutazione resa ormai possibile dalla distanza dai fatti, va addirittura riconosciuto in sede di giudizio storico che il movimento degli studenti italiani – certamente avvantaggiato da un intenso rapporto culturale e politico dei suoi capi con la leadership europea francese e della cosiddetta Scuola di Berlino – fu particolarmente precoce nel mettere a punto un organico progetto strategico della contestazione globale. Altra cosa è rilevare, come è pur corretto fare, l'eccessività delle proposte e il loro carattere di iperboli ideologiche, nonché il permanere di oscurità e contraddizioni rilevanti nel tentativo di tenerle insieme nel quadro di una strategia rivoluzionaria: tutti difetti, e non di rado fanatismi, da fare risalire alla deliberata enfasi utopica dell'elaborazione. Il 19 marzo, ventunesimo giorno di occupazione della Statale, venne approvata pubblicamente una piattaforma politica della contestazione globale, una "Carta programmatica" che sintetizzava l'elaborazione delle assemblee di base degli altri Atenei italiani in agitazione. In essa si compiva uno sforzo rilevante per coordinare organicamente le richieste specifiche degli studenti, relative all'ordinamento universitario e alle pratiche dello studio, con quelle complessive e generali dello scontro con il sistema dei poteri capitalistici. La premessa di tale piattaforma era l'analisi dei rapporti di classe intercorrenti tra la scuola e il vigente sistema di potere, con un netta condanna del meccanismo di subordinazione della scuola e degli studi al mercato capitalistico, che si riteneva potenziato dalle riforme progettate dal governo Moro. "La tendenza dei paesi industrialmente avanzati" si legge nel documento –, "è di unificare tutti i meccanismi di controllo sociale al servizio dei centri decisionali che tendono a concentrarsi nelle mani di una ristretta oligarchia economica e finanziaria. Il problema della classe dominante è quello di subordinare la scuola alle esigenze del sistema produttivo". Di conseguenza, la scuola diventa un fondamentale "strumento di integrazione" preposto all'asservimento dell'intero mondo del lavoro e delle professioni. "L'ingegnere, il medico, il filologo, tutti i vari tecnici e 'professionisti' escono dalle scuole provvisti di una preparazione strettamente specialistica, ma incapaci di coscienza critica", sicché "la scuola perpetua e approva delle differenze sociali che non hanno affatto corrispondenza nella realtà produttiva. La vita universitaria è vissuta come corsa all'acquisizione di un privilegio da conseguire attraverso la memorizzazione acritica di nozioni che verranno presto dimenticate". In perfetta coerenza con questo suo uso capitalistico, la scuola diventa "strumento di selezione" e "strumento di subordinazione". In essa, a tutti i livelli, "la didattica autoritaria sopprime le esigenze culturali e le istanze politiche, nega la loro autonomia e vi sostituisce la loro subordinazione e l'accettazione delle imposizioni dell'autorità e il conformismo dell'ordine costituito". Da queste premesse, l'indicazione strategica: "La prospettiva di movimento della lotta studentesca è quella del diritto allo studio espressa dalla contestazione globale all'assetto del sistema." Nel corso della lotta, il movimento non può che scontrarsi "in tutta Italia con le strutture dell'autoritarismo accademico (cattedre, Consigli di Facoltà, rettorati, ecc.) sostenuto dall'apparato repressivo dello Stato (polizia e magistratura)". Quali gli obiettivi della lotta? Senza alcun dubbio, l'annientamento dell'apparato autoritario-repressivo e della sua forma costitutiva generale, cioè il sistema capitalistico. Per conseguirli, occorre intanto creare le condizioni, nelle università e nelle scuole, per un immediato passaggio di tutto il potere "all'Assemblea generale degli studenti", compresi il potere decisionale "sui bilanci di gestione e ogni altro atto in materia amministrativa e finanziaria". Il documento affronta poi l'intera questione della didattica democratica – impossibile non avvertirvi l'influenza determinante delle problematiche sollevate da don Milani – e dell'organizzazione e dell'articolazione dell'attività comune di docenti e studenti per eliminare l'autoritarismo e inaugurare, al di là del nozionismo, un lavoro di studio e ricerca capace di formare la coscienza critica. [...] Il movimento, nel fragore delle iniziative e sotto la pressione costante della lotta antisistema, aveva ormai definitivamente acquisito, ben oltre le questioni spicciole del tradizionale sindacalismo studentesco, un deciso carattere di forza politica generale, dotata di una sua specifica base di massa e soprattutto della capacità di condurre a sintesi i temi ideologici e le finalità della Nuova sinistra rivoluzionaria. Era proprio questa sua caratterizzazione, decisamente non corporativa e anzi anticorporativa, il fattore fondamentale di cui beneficiava per impostare e stabilizzare un'azione comune con un più vasto fronte di intellettuali estremisti nel quale, come sappiamo, avevano già un'autorevole collocazione, con i più vari gruppettari, molti giovani docenti. Per effetto delle sinergie che si stabilizzarono con quella particolare area di "professori compagni" (di norma, giovani e precari) gli studenti di fatto riuscirono spesso a ottenere – anche sul terreno delle rivendicazioni più spicciole e concrete relative alla didattica e all'andamento degli studi – molto di più del dieci preventivato sul cento richiesto. | << | < | > | >> |Pagina 343Nel delineare un primo, sommario bilancio critico dell'anno 1968 – prima di avviarci agli anni del "lungo Sessantotto" – forse non è inopportuno che chi scrive torni a intrecciare l'analisi storica con i propri ricordi personali. A quei tempi non tutti, e a maggior ragione i meno giovani dei giovani, si rendevano conto di quel che stava accadendo. Del resto, persino della Rivoluzione francese ebbero probabilmente una chiara e distinta percezione soltanto i parigini e gli abitanti di qualche altra grande città. Se si indaga sul volto sociale della storia, è stupefacente scoprire di quanti eventi storici importanti non si siano ben accorti i contemporanei. Chi, come il sottoscritto, stava nelle retrovie del Sessantotto, disponeva delle informazioni dei quotidiani e viveva l'eco dei fatti reali in animazioni locali piuttosto limitate e discontinue. Non credo che la maggioranza della gente si trovasse in una situazione molto diversa dalla mia, eppure la ventata di quell'anno così speciale avrebbe finito per attraversare un po' tutti. E tutti, in vario modo e in tempi diversi, se ne sarebbero accorti. Mi viene in mente un'amica approdata al femminismo solo nei tardi anni settanta, arrabbiata con se stessa per aver perso tanto tempo ad acconciarsi i capelli senza capire che intanto il mondo stava cambiando. Mai come allora la moda veicolò le ideologie delle avanguardie, diffondendole e radicandole, seppure lentamente. Il che accade ogni volta che nella storia prenda forma quell'assetto che Gramsci chiamò "egemonia". Quasi senza accorgersene, si passava da uno stato di conformismo o di blando progressismo a una più o meno autentica sensibilità rivoluzionaria. Posso testimoniare che, se nessuno era costretto a dichiararsi di sinistra, il non riuscire a esserlo, o a volerlo essere, produceva uno stato di emarginazione o almeno un fastidioso senso di autoesclusione. Conobbi un liberale, già formatosi a Napoli all'Istituto Croce, che per "inverare" il liberalismo divenne comunista. Si chiamava Salvatore Onufrio ed era un noto studioso crociano di Georges Sorel. Non era un banale voltagabbana. Solo da marxista, quel delicato collega e amico avrebbe potuto parlare di libertà ai suoi studenti. Era in gioco, per lui – che sarebbe poi stato coerente con la sua conversione – la possibilità di comunicare con le nuove generazioni. Se non si approdava alla sinistra, era allora molto meglio, come Armando Plebe, dichiararsi consapevolmente di destra: questa scelta consentiva di coltivare eccentrici progetti di rivolta o, se non altro, di sentirsi parte di un fronte dell'azione. La confluenza antagonistica delle forze impegnate e delle esperienze culturalmente condivise in fronti avversi, inducono a una rappresentazione storica unitaria del Sessantotto come una grande azione collettiva. Di essa i contemporanei – protagonisti diretti o spettatori più o meno assenti e distaccati – conobbero soprattutto delle movenze episodiche che, con il trascorrere del tempo, sarebbero diventate così ripetitive e quasi monotone da ottenere spazi sempre meno vistosi sulla stampa. Che tali movenze episodiche fossero legate dal sottile filo rosso di un processo capace di produrre intense e profonde trasformazioni sociali, lo si sarebbe visto molti anni dopo. Nella percezione immediata dei contemporanei, l'anormalità si era in un certo senso normalizzata. Al di là del frastuono delle iniziative degli studenti, nella società allargata si produssero trasformazioni molecolari che incisero sul costume e modificarono i comportamenti e le idee persino degli anziani. Prima o poi divenne inevitabile, per chiunque fosse in grado di stabilire un rapporto consapevole con la vita sociale, scegliere una propria "visione del mondo", quasi sempre in alternativa o in polemica, da sinistra o da destra, con l'esistente. Per quanto il fenomeno possa oggi apparire incredibile, si sviluppò un interesse di massa e una vocazione partecipativa per la politica e per le ideologie che la alimentavano. Di tutto questo, i giovani furono davvero gli incontestati protagonisti, tanto da assicurare un immediato fondamento oggettivo alla loro intenzione di far nascere dalla condizione giovanile qualcosa di simile a un autonomo soggetto politico capace di cambiare il mondo. L'animazione collettiva si allargò, per via di spinte imitative, dal suo originario palcoscenico – costituito, come si è visto, soprattutto dalle università – all'intero scenario delle istituzioni e dei luoghi della scuola. Sulla base del comune modulo assembleare, scioperi e proteste si manifestarono non solo nelle scuole medie superiori ma anche in quelle inferiori e persino – in qualche pittoresco accenno di rivolta – nelle scuole elementari. Ma il Movimento non restò circoscritto a quell'ambito; tracimava e traboccava nelle piazze in una sequela di cortei normalmente non autorizzati. E ben presto, come vedremo per il "lungo Sessantotto", divenne una componente importante delle manifestazioni di massa promosse, per le rivendicazioni operaie, dalla Triplice sindacale. Nel travolgente dinamismo della contestazione globale, il crollo dell'antiquato assetto disciplinare nelle scuole fu forse la meno importante tra le cose che sollevavano il raccapriccio dei conservatori (la "maggioranza silenziosa"?). La normativa scolastica subì un'ufficiosa abrogazione, nonostante i disperati sforzi di non pochi presidi e rettori per tentare di farla ancora valere. Poi vennero alcune parziali ma importanti riforme: la liberalizzazione degli accessi all'università, i "provvedimenti urgenti" sullo stato giuridico dei docenti e, per la scuola media, il nuovo esame di Stato e altre novità. Ben più rilevanti offese investirono il quadro dei rapporti tra autorità e società. Fu resa largamente inapplicabile dalle eccezionali circostanze la normativa sull'ordine pubblico (in particolare, quella relativa all'interruzione dei pubblici servizi), se non altro perché il governo di centro-sinistra, per una fondamentale ispirazione di Aldo Moro, insisteva con tenacia sulla sua linea neogiolittiana. Anche se non mancarono episodi di drammatica esplosione del conflitto sociale che sembrarono ripristinare le pratiche più funeste della Celere di Mario Scelba: in vari casi la polizia, normalmente assai truce con il suo armamentario di manganelli e gas lacrimogeni, adottò metodi violenti contro le manifestazioni non autorizzate, e a fine anno, il 2 dicembre, si rese responsabile dell'ultimo eccidio di poveracci e disoccupati del Sud, sparando sugli inermi contadini di Avola, con un bilancio di sangue di due morti e cinquanta feriti.
Nel complesso, però, la condotta governativa nei confronti degli studenti
(che, nella percezione delle pubbliche autorità, erano tutt'altra realtà che i
poveracci meridionali, essendo in gran parte figli degli stessi ceti sociali sui
quali si fondava l'establishment del Paese) sembrò evidenziare l'affanno del
potere dinanzi al Movimento e illuse i protagonisti di essere alla testa di una
rivoluzione in piena regola, capace di abbattere il sistema.
|