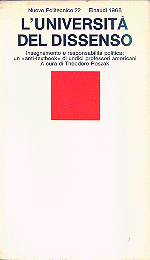
|
|
|
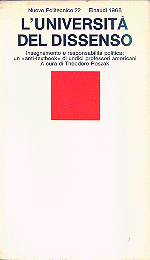
|
|
|
| << | < | > | >> |Indice
7 Prefazione
L'università del dissenso
THEODORE ROSZAK
13 La delinquenza accademica
LOUIS KAMPF
53 Lo scandalo delle cattedre di letteratura
SUMNER M. ROSEN
73 Keynes addomesticato
STAUGHTON LYND
103 Passato storico e presente esistenziale
MARSHALL WINDMILLER
121 I nuovi Mandarini
KATHLEEN GOUGH
147 Rivoluzione mondiale e scienza dell'uomo
JOHN WILKINSON
171 La civiltà del dialogo
ROBERT ENGLER
195 Scienze sociali e rifiuto della responsabilità sociale.
Lo scandalo delle università
CHRISTIAN BAY
223 Scienze politiche: con ottimismo e squallore
GORDON C. ZAHN
247 Dai colli di Salamanca agli sbarchi nel Vietnam.
Le università cattoliche negli Stati Uniti
NOAM CHOMSKY
269 La responsabilità degli intellettuali
313 Notizie sugli autori
|
| << | < | > | >> |Pagina 7PrefazioneMentre questo libro viene dato alle stampe il mondo accademico americano è agitato e tormentato dalle discussioni politiche come forse non è mai stato in tutta la sua storia. La guerra nel Vietnam ha suscitato, da parte di insegnanti e studenti, una serie di resistenze che vanno dalla petizione scritta all'esercizio della disobbedienza civile in massa; e anche se occorre tener presente che coloro che partecipano attivamente a queste forme di resistenza sono ancora una piccola minoranza nella comunità accademica, è pur vero che fin dai teach-in del 1965 nessun gruppo particolare della nostra società ha espresso in maniera altrettanto persistente ed esplicita la propria opposizione alla politica ufficiale. Per coloro che rifiutano la guerra nel Vietnam come fondamentalmente sbagliata e immorale, come per coloro che ritengono la partecipazione al dibattito sulle piú vitali questioni pubbliche un dovere per un membro del mondo universitario, questa straordinaria manifestazione di interesse attivo non può essere che incoraggiante: e potrebbe anzi rappresentare l'evento piú promettente di tutta la storia americana del dopoguerra, perché significa, finalmente, l'ingresso dell'intelletto e della coscienza nel nostro mondo politico. Questa manifestazione di interessamento attivo può anche significare che finalmente abbiamo l'occasione di smettere di vivere passivamente sulla rendita del capitale rappresentato dalla politica del New Deal, e, peggio, dall'osservanza della antiquata diplomazia della guerra fredda; e può significare anche che le università sono sul punto di liberarsi del loro stato di dipendenza nei confronti delle varie élite politiche, militari, paramilitari o economiche che le finanziano, e di diventare fonti autonome di conoscenza, di valori, di critica. Se tutto ciò è vero. allora è vero che, in America, il governo può diventare un'arte anziché una logora forma di ingegneria sociale, fondata sui riflessi condizionati e sulla istituzionalizzazione del cinismo. Ma poiché questo ritorno — tanto atteso — ad una democrazia sostanziale sia possibile, è necessario prendere coscienza di una verità ancor piú triste che la guerra nel Vietnam può insegnarci: e cioè che la guerra stessa è, in grandissima parte, il prodotto di un difetto culturale insito nella comunità accademica. Essa è stata chiamata «la guerra liberale»: definizione che, in larghissima misura, corrisponde alla verità. I consiglieri che hanno spinto alla guerra il governo Kennedy prima, e poi il governo Johnson, sono quasi tutti intellettuali di grande prestigio e tradizionalmente liberali, provenienti dalle nostre migliori università. La retorica della guerra, le sue giustificazioni, e una buona parte del lavoro di consulenza tecnica che ha contribuito alla formazione dei diversi governi di Saigon, tutto ciò ha avuto origine da quegli intellettuali che Mary McCarthy ha chiamato «gli intellettuali paramilitari». Inoltre il fatto stesso che la guerra abbia potuto, da quell'impegno marginale che era all'inizio, montare senza sosta, e senza critiche degne di nota, fino a diventare uno dei problemi piú gravi del paese, è dovuto molto al silenzio e alla cautela che hanno caratterizzato le nostre università fino al 1965. Coloro che avrebbero potuto porre gli interrogativi di fondo, e formulare le alternative possibili, hanno preferito tacere. In questo senso il Vietnam costituisce una misura del fallimento degli intellettuali, ed ora comincia ad essere anche una misura della loro coscienza. Perché la storia del Vietnam non si ripeta altrove, come sembra invece che stia accadendo, impercettibilmente e con i medesimi processi, in altre parti del mondo, forse è necessario che gli intellettuali facciano molto di piú e non si limitino a protestare contro questa guerra in particolare. Insomma è giustificata la domanda: forse le normali attività del mondo accademico americano contribuiscono alla creazione di altri Vietnam piú di quanto non facciano per analizzare, correggere e opporre resistenza a una politica che ha condotto a un disastro morale di quelle proporzioni? A tale questione questo libro è dedicato. Gli autori dei vari capitoli sono stati scelti in quanto intellettuali impegnati socialmente, ciascuno dei quali, oltre a servire il suo campo di sapere come insegnante e come ricercatore, è entrato in maniera significativa nella discussione in atto sulla politica dello stato. Otto degli autori rappresentano le discipline umanistiche e sociali; oltre a ciò un capitolo speciale di Gordon C. Zahn riguarda il ruolo delle università cattoliche, mentre un capitolo conclusivo di Noam Chomsky si occupa della parte avuta dagli accademici nella formulazione dell'attuale politica governativa. Occorre anche avvertire che la sociologia è assente perché una eccellente e vasta critica di questa disciplina esiste già nell'opera The Sociological Imagination di C. Wright Mills. Gli autori suddetti partono da una base polemica comune e accettano come un dato di fatto che i valori del mondo in cui viviamo sono gravemente minacciati. Non è scopo di questo libro ricominciare le discussioni già fatte per dimostrare questo punto: qui si argomenta invece che, messi a confronto con lo stato di protratta emergenza nella quale si trova la nostra civiltà, i nostri uomini di cultura non hanno saputo raggiungere un livello soddisfacente di coscienza intellettuale, e al di là di ogni polemica si cerca poi di trovare una definizione dell'attività intellettuale tale da consentire agli uomini di cultura, e al mondo universitario nel suo complesso, di contribuire in misura significativa al compito di formare dei cittadini attivi e consapevoli. Agli autori dei capitoli che seguono è stato chiesto di svolgere questi temi: in che modo la vostra professione, e in genere la comunità accademica della quale fate parte, assolvono le loro responsabilità sociali? E in che modo esse dovrebbero svolgere i loro compiti educativi? I metodi usati per rispondere a tali domande variano a seconda degli autori. Ci si può attendere un certo disaccordo tra essi su molti punti, sia per quanto riguarda i modi dell'analisi che per quanto riguarda i valori personali. Ma ciò che emerge chiaramente è la convinzione unanime che sia compito fondamentale dell'accademico esaminare pubblicamente la vita umana sotto l'aspetto della sua qualità morale. Dalla prima all'ultima pagina, lo spirito che anima il «dissenso accademico» espresso da questo libro è lo spirito di Socrate. Un'ultima osservazione: se il libro si limita alle discipline umanistiche e sociali, ciò è in parte dovuto ad arbitrari motivi di spazio, ma anche al fatto che le scienze fisiche sono osservate e criticate attentamente, rispetto a questioni di responsabilità sociale, fin da Hiroshima. L'esistenza di pubblicazioni come il «Bulletin of the Atomic Scientists», o di enti come la Society for Social Responsibility in Science, dimostra chiaramente che i problemi morali dello scienziato, per quanto ancora lontani da qualunque soluzione, sono già, per lo meno, materia accettata di pubblica discussione, mentre quelli dell'umanista e del cultore di scienze sociali cominciano appena adesso a diventarlo. L'esame delle caratteristiche della vita e del lavoro accademico è limitato perciò, in questo libro, ai campi suddetti. | << | < | > | >> |Pagina 15Ci fu un tempo nel quale gli uomini di cultura definivano gli scopi della loro vita in modo tale da commuovere gli spiriti nobili e da agghiacciare gli spiriti vili... Se tutti noi che insegnamo oggi nelle università dovessimo rispettare questo principio, quanti fra i nostri studenti crederebbero in noi, o ci comprenderebbero? E fra questi, quanti si troverebbero ad aver imparato ciò che sanno dalle nostre lezioni e dal nostro esempio? «Osa conoscere!» Cosí definiva Kant la funzione dell'intelletto, in un tempo in cui l'esame critico della vita e delle società non era visto né come un passatempo divertente né come una professione lucrativa, ma come un atto di sfida e di rischio. Quello era un tempo in cui gli uomini di cultura portavano bandiere di battaglia, sulle quali iscrivevano motti di audacia e di avventura. «Tutto — insisteva Diderot — dev'essere esaminato, tutto dev'essere frugato, senza eccezioni e senza cautele». E Voltaire comandava: «Ecrasez l'infame!» Erano uomini segnati, e lo sapevano: per dirla con Jefferson, la loro intellettualità era un giuramento pronunciato sopra un altare, contro nemici numerosi e potenti. Denunciando l' Enciclopedia alla vigilia della sua soppressione, il ministro francese della giustizia tracciò, con minacciosa precisione, una linea di separazione tra l'autorità costituita e il libero intelletto: La Società, la Religione e lo Stato si presentano oggi al tribunale di giustizia al fine di sottoporre le loro proteste... L'empietà cammina a testa alta... L'umanità rabbrividisce, i cittadini sono in allarme... È con dolore che siamo costretti a dirlo: ma è forse possibile continuare a nascondere a noi stessi che esiste un progetto già elaborato, e una società già organizzata, per propagare il materialismo, per distruggere la religione, per ispirare uno spirito di indipendenza, e per alimentare la corruzione della morale?... Ma il grande progetto continuò ad avanzare lo stesso, anche se i suoi autori vennero spinti alla disperazione e alla rovina. Ciò accadeva un tempo... che non è piú il nostro. Quali sono gli imperativi che i nostri studenti troverebbero iscritti sulle nostre bandiere? «Trovare i fondi!» «Aggiornare la bibliografia!» «Pubblicare o perire!» La vita accademica sarà anche intensa ed ansiosa, ma è l'intensità e l'ansia della competizione carrieristica a riempirla, non quella dell'avventura rischiosa. Se gli studenti vogliono conoscere le menti audaci della nostra epoca, è fuori dai confini del mondo accademico che debbono cercarle. Ma dopotutto dobbiamo riconoscere che solo raramente l'audacia ha caratterizzato la professione accademica. Si potrebbero forse contare sulle dita di una mano le volte che l'università è stata qualcosa di meglio che non essere al servizio della società ufficiale, come ritrovo delle élite di potere e come centro di formazione di quel tipo di funzionario di volta in volta richiesto dallo status quo. Le grandi menti dell'illuminismo, in particolare i philosophes francesi, naturalmente non erano accademici: preferivano pensare a se stessi come a «uomini di lettere». La maggior parte degli studi contemporanei li identificano col termine piú generico e piú libero di «intellettuali», nel senso di pensatori e scrittori indipendenti dall'università. La distinzione è storicamente corretta, ma troppo spesso diventa, per l'accademico, un comodo alibi morale. «Essi erano intellettuali, mentre io sono un accademico. La loro tradizione è diversa dalla mia; i loro ideali non mi riguardano». Ma perché i philosophes non erano accademici? Perché le università del loro tempo si erano dimostrate inospitali verso il pensiero critico piú avanzato: la storia intellettuale piú vera doveva farsi al di fuori dell'ambiente opprimente dell'establishment universitario. I philosophes non erano accademici perché a quel tempo, per esserlo, occorreva avere una mente gretta e meschina, cioè «fidata», dal punto di vista dell'autorità. L'accademico di oggi che si riattacca alla tradizione rappresentata da menti simili rivendica una discendenza che storicamente sarà legittima, ma che purtroppo non possiede certo una grande nobiltà. L'università americana non ha fatto eccezione a questa regola storica, e ha offerto agli accademici ben poche occasioni di liberarsi dalla triste tradizione del conformismo ufficiale. Senza dubbio le cose sarebbero state diverse se Jefferson fosse riuscito nel suo intento. Per Jefferson infatti, come si legge nel suo progetto per l'università della Virginia, scopo dell'università era quello di esercitare una critica indipendente verso quelle forze, di chiesa o di stato, che «hanno timore di ogni cambiamento che possa mettere in pericolo le comodità di cui godono». L'università doveva «smascherare la loro usurpazione e il loro monopolio degli onori, delle ricchezze e del potere». Ma l'influenza di Jefferson fu limitata alla durata della sua vita, e ad una sola scuola. I suoi controversi ideali di non settarismo e di insegnamento di conoscenze pratiche furono sí, alla fine, raccolti dalle grandi università di stato del diciannovesimo secolo, ma la sua idea di critica indipendente non si dimostrò mai accettabile da parte delle forze della chiesa, dello stato e delle grandi corporazioni industriali, che dovevano dominare l'istruzione superiore. È interessante notare che, oggi come ai primi del secolo scorso, sono stati gli studenti a prendere l'iniziativa di reclamare una funzione di critica sociale come parte integrante della loro educazione. Il mezzo scelto allora dagli studenti per perseguire questo obbiettivo fu la società letteraria (o di discussione) extracurricolare: tali società si moltiplicarono dopo la rivoluzione, e per i primi trent'anni del secolo diciannovesimo costituirono l'elemento di gran lunga piú vitale dell'istruzione americana. Loro scopo era lo studio e la discussione delle questioni contemporanee, in piena tradizione dei philosophes. ... scopo delle società letterarie non era la propagazione di un dogma: esse rispettavano invece la ragione, alimentavano la mente, e sottoponevano a indagine e a discussione gran parte di ciò che era stabilito... I circoli servivano anche a portare dentro l'università la voce di personalità controverse (per esempio Rufus Choate, o Ralph Waldo Emerson, al quale venne spesso rifiutato il permesso di usare gli edifici delle università nelle quali era invitato a parlare), pubblicavano riviste letterarie, e raccoglievano biblioteche della migliore letteratura del momento. È facile indovinare che i circoli non furono mai bene accetti dalle autorità accademiche. Ma con l'indebolimento della tradizione del dibattito, dovuto principalmente alla diffusione delle associazioni studentesche, l'ideale del dissenso non si trova piú in onore, con l'eccezione di poche scuole: fra queste l'università di Oberlin nel primo periodo di attività, durante il quale essa era consacrata a un attivismo cristiano che rapidamente condusse a una posizione di dissenso sul problema della schiavitú, con episodi di resistenza addirittura eroica alle manifestazioni, spesso violente, di antipatia da parte della comunità circostante. Ma verso la fine del secolo, quando l'establishment accademico moderno si fu definitivamente consolidato, nelle università importanti il massimo di funzione critica indipendente che ci si permetteva consisteva nel fornire assistenza tecnica alle commissioni legislative di stato, e fornire personale agli enti consultivi, che stavano diventando un elemento essenziale dell'America industriale. L'università che probabilmente si è spinta piú oltre nel dare una forma dottrinaria a questo genere di servizio è stata quella del Wisconsin, specie durante la presidenza di Charles Van Hise, ma anche qui, non appena cominciò la prima guerra mondiale, i suoi amministratori decisero di applicare il freno patriottico: critica di carattere tecnico, sí; dissenso radicale, no. Da allora, tutta l'istruzione superiore americana è stata dominata (e divisa) da tradizioni che non hanno piú nulla a che vedere con quello spirito di indagine, socialmente cosí aggressivo, che Voltaire e Jefferson ritenevano la caratteristica essenziale dell'intelletto. Con questo non si vuol dire che le tradizioni dominanti siano sempre state totalmente prive di una certa nobiltà iniziale di intenzioni, ma è certo che, nonostante queste intenzioni, esse si sono rapidamente corrotte: a causa soprattutto di un'insistenza nel considerare l'accademico non come una personalità unitaria, ma piuttosto come il ricettacolo di tanti talenti specializzati e separabili. Ma come ammoniva Socrate parlando ai sofisti, dividere la personalità costituisce il primo passo nell'abbandono della saggezza; isolare un qualsiasi talento umano (come facevano i sofisti con l'arte della retorica), coltivarlo, e giudicarlo indipendentemente dalla persona totale in cui esso risiede, significa immiserire, insieme con quel talento, la stessa persona. Le tradizioni di istruzione superiore delle quali si parla qui potrebbero essere definite coi termini «servizio pubblico» e «lavoro di ricerca». Il primo termine è una specie di slogan che descrive un'interpretazione tipicamente americana dell'insegnamento superiore: l'idea è chiaramente espressa nel Morrill Land Grant Act del 1862 dove si dice che le università pubbliche debbono essere parte integrante della comunità e debbono servire i suoi bisogni. In questa concezione dell'università era ed è ancor oggi contenuto un chiaro ideale democratico. [...] Per chiarire meglio ciò che intendo farò alcuni esempi immaginari. Si supponga che un insegnante di storia americana prenda parte attiva nell'organizzare nel suo stato una campagna molto ben pensata e preparata contro la pena di morte. Raccoglie intorno a sé degli studenti favorevoli alla sua causa, e riesce a impegnare in un serio dibattito sull'argomento funzionari e laici della comunità. Quest'uomo ha dato o non ha dato un contributo intellettuale piú reale che se avesse compilato uno studio definitivo sul declino delle aziende cotonifere degli stati del Sud nel periodo 1865-94? Quale dev'essere la nostra valutazione «professionale» di quest'uomo? Si supponga che un insegnante di psicologia, sentendo che nella sua comunità la politica è in ribasso, decide di porre la sua candidatura al Congresso, con l'intenzione di stimolare una seria discussione pubblica sui diritti civili o sulla politica estera. Conduce dal principio alla fine una campagna di alta responsabilità intellettuale, costringendo tutti gli altri candidati a dichiarare chiaramente la loro posizione: cosa che altrimenti essi avrebbero evitato come si evita la peste. Come dobbiamo valutare il contributo di quest'uomo? È piú valido o meno valido di uno studio esauriente sul comportamento olfattivo del ratto in libertà? Si supponga che un insegnante di filosofia si ponga alla testa di una manifestazione di disobbedienza civile contro l'apertura di un laboratorio per la guerra batterica. Egli decide di farlo dopo aver fatto una indagine personale sulla futura attività del laboratorio in questione, e dopo aver scritto, ad uso del pubblico, un articolo in cui vengono esposti i suoi principi etici. Quanti articoli specializzati sul descrittivismo, sulla sopravvenienza e sulla universalizzabilità si potrebbero dare in cambio di questa azione? Si supponga che un insegnante di letteratura dedichi molto del suo tempo a organizzare «scuole della libertà» per ragazzi sottoprivilegiati, magari partecipando anche ai picchetti del CORE. Dovremmo, ai fini degli avanzamenti e del trattamento valutare il suo lavoro allo stesso modo di quello richiesto per uno studio critico della traduzione di Golding delle Metamorfosi di Ovidio? Si supponga che un insegnante di antropologia si occupi dell'organizzazione di un teach-in sulla guerra nel Vietnam. Fa anche un viaggio nel Vietnam per conto della Commissione interuniversitaria, e al ritorno scrive un articolo, e lo manda a una rivista come «Atlantic» o «New Republic», intorno agli effetti della guerra sulla vita dei villaggi e sul carattere morale degli americani. Il suo lavoro vale piú o meno, intellettualmente parlando, di uno studio sull'unità e la diversità di celebrazione dei riti di guarigione del bestiame in un villaggio indiano del Nord? Sarà bene fare un'osservazione sugli esempi che abbiamo offerto. Dato che tutti i nostri insegnanti immaginari sono impegnati in «azioni», che molti accademici potrebbero considerare distinte dal «pensiero», non dovremo pensare che essi non meritano nemmeno di essere presi in considerazione? Ricordo che questa questione sorgeva spesso nelle discussioni che si svolgevano fra i membri dell'ormai defunto Consiglio per la corrispondenza, che è stato forse il tentativo piú importante del dopoguerra per organizzare gli accademici e far di loro una forza politica. La questione si rifà alla tradizionale dicotomia tra «pensare» e «fare», che si direbbe una malattia professionale degli accademici. Una risposta può consistere nel chiedersi quale sia il senso di trattare «pensiero» e «azione» come attività separate o addirittura incompatibili. L'analisi e la discussione, là dove esse abbiano qualche rilevanza politica, diventano atti politici, ed è proprio questo che abbiamo specificato essere la caratteristica responsabilità sociale degli intellettuali. Pensare, parlare, insegnare, scrivere, tutte queste sono forme di azione; ed è appropriato considerarle come sue componenti essenziali e come parte indispensabile del processo politico. Anche limitandosi ad esse l'accademico può contribuire ad arricchire e nobilitare la vita della sua società. Ma se va oltre che succede? Se il pensiero di un uomo si traduce in forme piú esplicite di azione, come quelle dei nostri esempi, dovremo considerare ciò come qualcosa di per sé piú vile? Certamente no, poiché in una personalità sana il pensiero e l'azione si fondono armoniosamente in un solo spettro, e non vi è barriera artificiale che possa impedire a un uomo di intraprendere un lavoro di guida o di organizzazione per realizzare nei fatti ciò che la sua intelligenza gli suggerisce che debba farsi. Occorre anzi comprendere che l'azione — per esempio sotto la forma drammatica della disobbedienza civile — può in molti casi essere l'unico modo di costringere un'autorità reticente a un dialogo intellettuale. In situazioni simili la mancanza della volontà di agire, di fare azione di disturbo, può significare che la persona non è del tutto seria rispetto alla posizione intellettuale che professa, e che forse in fondo non gli interessa che i valori che difende vengano messi in tavola. Assumiamo dunque, per le persone dei nostri esempi, trattarsi di uomini capaci di fare un'onesta difesa intellettuale della loro attività: uomini in cui l'azione scaturisce dal pensiero, e in cui il pensiero è stimolato dall'azione. Cosa possiamo dire del loro valore in quanto membri delle loro rispettive professioni? Naturalmente non molto, trattandosi di esempi immaginari. Si può immaginare ogni sorta di questione da porre per la scelta di un insegnante da assumere o da promuovere. Ma il fatto è che in nessun istituto universitario dell'America di oggi, tranne forse pochissime eccezioni, la condotta civica di insegnanti come questi riceverebbe la pur minima considerazione. Non importa quanto giusta intellettualmente o moralmente coraggiosa, non importa di quanto beneficio per gli studenti o per la comunità, quella condotta verrebbe, normalmente, trascurata del tutto nella valutazione dell'uomo. E ciò dà la misura della distanza fra il concetto accademico moderno di intelletto e quello caro ai philosophes. Perché dev'essere cosí? Forse perché si ha la sensazione che, dato che tutti possono fare della politica, fare cose di quel genere non valga gran che? Ma questo non ha senso: vi sono modi intelligenti e modi sciocchi di fare politica, e vi sono modi profondi e modi superficiali di parlarne, cosí come vi sono attività culturali intelligenti e sciocche, superficiali e profonde. Forse un Warren Harding era davvero uno sciocco; ma uomini come Jefferson, come Norman Thomas, come Muste, o come H. Stuart Hughes (che presentò la sua candidatura al senato del Massachusetts) fecero politica con tutta la forza del loro intelletto. Fare politica cosí, con profondità e intelligenza, è un'impresa rara e ammirevole, che per di piú richiede spesso molto piú coraggio della «ricerca pura». O forse la condotta civica è da trascurare perché si teme che gli accademici politicamente impegnati non sappiano preparare i neolaureati ai metodi della ricerca, o non assolvano il loro dovere di scopritori di conoscenza? Ma se si accetta come una delle funzioni dell'intelletto l'uso della conoscenza in difesa dei valori civili, allora è probabile che questi uomini siano capacissimi di «preparare» gli intellettuali futuri. È probabile che questi uomini siano capacissimi di fare precisamente ciò che le forme attuali di istruzione postlaurea non fanno mai: obbligare un allievo a riflettere sulle funzioni e sugli scopi piú profondi del suo impegno professionale. Sostengo infatti che la formazione dei futuri accademici e la preparazione alla ricerca, cosí come funzionano oggi queste attività, hanno come risultato una gran quantità di lavoro specialistico senza senso, di futilità e di pedanterie alle quali non si dovrebbe riconoscere nessuna rispettabilità intellettuale. Probabilmente non c'è un solo campo, in tutte le scienze sociali e in tutte le discipline umanistiche, che non vanti già una quantità di «conoscenza» piú vasta di quanta se ne potrebbe «volgarizzare» — assimilandola cosí nel grande fiume culturale di tutta la società — nei prossimi cinquanta o cento anni. È questa enorme eccedenza di «conoscenza», raccolta da esperti con tecniche di precisione, ciò di cui abbiamo davvero bisogno? Ovvero, nello stato di protratta emergenza in cui la nostra civiltà si trova, la nostra priorità piú alta non va assegnata alla capacità dell'intellettuale di collegare le sue conoscenze specialistiche o il suo intuito morale ai nostri bisogni sociali? Questo è appunto ciò che qui sostengo: che nel valutare le qualità morali di un uomo di cultura ci si chieda ciò che vale, per la difesa dei valori civili, il suo pensiero, o l'esempio costituito dalle sue azioni. Questa persona ha cercato di elevare la pubblica discussione fino a un livello di rispettabilità morale e intellettuale? Anche se questa non è la sola domanda da porsi per dare un giudizio sul nostro collega, essa dovrebbe almeno essere una delle prime. In quale contrasto tutto ciò stia rispetto ai criteri prevalenti nei gruppi accademici può essere illustrato dall'esempio seguente. L'autore ha lavorato in istituti nei quali gli accademici suoi superiori disapprovavano che si indicasse la propria università o il proprio dipartimento nel firmare una petizione, nel sottoscrivere una dichiarazione politica da pubblicare a pagamento sui quotidiani, nel prendere parte a riunioni politiche, o anche nello scrivere al proprio rappresentante parlamentare. È chiaro che da tali attività il dipartimento o la scuola non cerchino di trarre «prestigio». Ma d'altra parte, ogni volta che è stato proposto che le pubblicazioni scientifiche restino anonime, o per lo meno che al nome dell'autore di un articolo, di un libro o di una recensione non si faccia seguire l'indicazione del suo dipartimento, la proposta è stata invariabilmente trattata come se fosse una sciocchezza: eppure non è affatto chiaro come l'anonimato possa interferire con la «ricerca disinteressata della verità». Ciò che si chiede qui all'accademico singolo dovrebbe essere chiesto ai gruppi professionali come tali. Supponiamo che si debbano valutare questi ultimi ponendo loro la seguente domanda: in quali settori dell'intelletto le istituzioni della nostra società, e specialmente il governo, hanno dovuto imparare ad avere la mano leggera per non suscitare una resistenza critica da parte della collettività della comunità accademica? La risposta non potrebbe essere incoraggiante. Per quanto riguarda le materie umanistiche e le scienze sociali, ma spesso anche le scienze naturali, il governo sa che tutte le volte che ne ha bisogno può farsi perdonare qualunque pasticcio propagandistico, perché, nei suddetti settori, non ha di fronte a sé un pubblico organizzato o autorevolmente critico, se si eccettua quello rappresentato dai giornalisti piú coscienziosi. Tra gli accademici troverà solo qualche sparso dissenso, molti dei quali in grado di raggiungere solo un pubblico di minoranza: ma questi dissensi sono piú che compensati dall'impiego degli «specialisti» la cui funzione è di fornire un «servizio» alle condizioni dettate da chi li impiega. Gli esperti di questa sordida specie sono numerosi e spesso godono di un grande prestigio nei gruppi accademici. Non occorre molta immaginazione per vedere di quanto potrebbe arricchirsi la nostra politica grazie a un servizio di critica che venisse esercitato dalle professioni accademiche. Se in America non abbiamo una politica intellettualmente rispettabile, ciò è dovuto principalmente al fatto che le professioni accademiche, cioè il gruppo singolo con interessi intellettuali piú vasto della nostra società, hanno rinunziato alla politica. Questo gruppo non ha sentito l'obbligo professionale di legare la vita dei suoi membri e il loro lavoro ai grandi problemi di giustizia e di sopravvivenza che dominano la nostra epoca; non si è battuto perché l'intelletto diventasse una dimensione della vita del cittadino. Esso intende invece l'intelletto come un mezzo per far carriera nel mondo universitario, o nel caso migliore come un mezzo per collezionare conoscenze fini a se stesse. Se le grandi istituzioni della società venissero informate che ciò che fanno e dicono viene freddamente esaminato da un pubblico di accademici attenti e coscienziosi; se le opinioni degli uomini di pensiero, dei maestri, fossero elemento costante e riconosciuto delle pubbliche controversie, queste potrebbero per lo meno innalzarsi al livello di un dialogo razionale, invece di restare una provincia di miserabili richiami pubblicitari, di cinica propaganda, di consensi prefabbricati. Certo non è sempre facile trovare soluzioni semplici e univoche ai grandi problemi pubblici: ma le soluzioni razionali diventano impossibili quando, come accade nell'America contemporanea, le decisioni politiche sono un segreto di stato, dal quale gli interessi costituiti e il lavoro arcano degli specialisti tengono escluso un pubblico in letargo.
Finché la nostra vita politica conserverà questo carattere c'è ben poco di
cui gli accademici – siano essi umanisti o scienziati, specialisti o eclettici,
tecnici o ricercatori – possano sentirsi orgogliosi. Essi potranno continuare a
coltivare, con arte raffinata e gusto squisito, il loro lussureggiante giardino
di conoscenze e di teorie. Ma su quel giardino - e su tutto il mondo che lo
circonda - incombono le ombre minacciose e ripugnanti del potere maldiretto e
dell'estinzione termonucleare. Ogni concezione dell'intelletto che porti a
ignorare questo fatto è, alla fine dei conti, futile e vile.
|