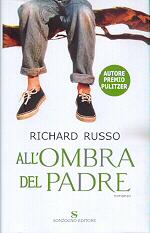
|
|
|
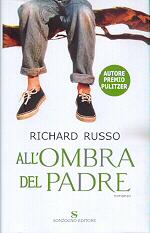
|
|
|
| << | < | > | >> |Pagina 58Forse a mo' di consolazione, mi parlò di suo padre, un ubriacone che picchiava il figlio e la moglie e che aveva incontrato una morte improvvisa e insolita. Mentre parlava di quell'uomo, aveva un'espressione vaga e distante. A quanto pareva, quando padre Michaels aveva un anno o due più di me, suo padre aveva avuto una visione che l'aveva redento all'istante. Dopo due settimane di bevute e di assenza da casa – e di sollievo, per il ragazzo e per la madre, i cui occhi, ammaccati dall'ultimo pestaggio, erano ancora verde-giallognoli — un pomeriggio si era presentato all'improvviso, e la moglie si era preparata a gettarsi dal terzo piano, se necessario. Il marito, però, benché ancora in preda ai tremori, era sobrio e indossava inaspettatamente un completo nuovo. Si era sbarbato e pettinato e aveva annunciato di essere diventato un altro. In effetti, sembrava proprio così. Il ragazzino e la madre facevano fatica a riconoscerlo. Il sacchetto di cibarie che aveva portato con sé, però, fu molto gradito, così come la notizia che aveva trovato un lavoro, un buon lavoro. Poi aveva baciato gli occhi gialli della moglie e proposto al figlio di andare con lui a vedere la partita di base-ball ai Polo Grounds, mentre la mamma preparava la cena. Giunti allo stadio, padre e figlio avevano preso delle bibite gassate e si erano seduti sulle gradinate in alto per guardare la partita. Padre Michaels ricordava l'episodio come il giorno più bello della sua giovane vita.Alla fine della partita, il padre lo aveva preso per mano, e insieme erano scesi dalle gradinate. Padre Michaels rammentava che il sole accecante sembrava essersi posato sopra gli spalti di fronte a loro; forse per questo suo padre aveva pensato di essere giunto all'ultimo gradino, mentre invece ne rimaneva ancora un altro. Da ubriaco era sopravvissuto miracolosamente a una serie di cadute pericolose. Più di una volta aveva mancato il primo gradino delle scale sul pianerottolo del loro appartamento al terzo piano, per accorgersene solo quando si ritrovava seduto sul pianerottolo sottostante. Era caduto da sedie, auto in movimento dentro canali di scolo, scalini di verande, biciclette, pattini da ghiaccio, innumerevoli sgabelli di bar e, persino, da sopra delle donne. Ma quel pomeriggio, sobrio e pieno di nuova vitalità e amore struggente per il figlio così a lungo trascurato, pensando di essere arrivato in fondo alle gradinate dello stadio aveva messo male il piede e, benché si fosse sbagliato di appena pochi centimetri, la gamba gli si era spezzata come un legno secco, e l'osso era andato a conficcarsi nell'inguine. Quel pover'uomo era sprofondato immediatamente in stato di choc ed era morto prima che i medici dell'ospedale – dove alla fine l'avevano portato – potessero fare la loro diagnosi. Se padre Michaels non mi avesse spiegato la morale della storia, mi sarebbe di certo sfuggita, perché a me sembrava che l'errore di suo padre fosse stato quello di diventare astemio, quando la sua condizione naturale era chiaramente quella della trance da alcolizzato. Il mio amico, invece, mi spiegò che Dio aveva concesso generosamente a suo padre l'opportunità di morire in stato di grazia e a loro due di trascorrere insieme un bellissimo pomeriggio di cui sarebbe rimasto il ricordo. Proseguì dicendo che era stato soprattutto il ricordo del padre, più di qualsiasi altra cosa, a spingerlo a farsi prete. Illustrato e considerato sul piano provvidenziale, il disegno divino risultava chiaro e inequivocabile, ma a me pareva comunque un tantino contorto, benché io non fossi certo un esperto in materia. Secondo me, se Dio desiderava dei discepoli, sarebbe stato più conveniente adottare il metodo della folgorazione di san Paolo sulla via di Damasco, perché in quel caso la conversione aveva richiesto solo la presenza della persona in questione (a meno che non si volesse contare anche il cavallo), senza pestaggi o sevizie reiterate ai danni della moglie, del figlio o di altri innocenti. Comunque, padre Michaels e io eravamo legati da una simpatia reciproca, e lui credeva che mio padre, se anche non fosse più tornato, avrebbe ugualmente continuato a influenzare la mia vita. Dovevo essere felice di averlo conosciuto, e del poco tempo trascorso con lui, sebbene a me come padre non sembrasse granché. Il mio nuovo amico mi esortava anche a essere felice di avere la mamma, che lui considerava una donna straordinaria, non solo per come sapeva maneggiare la pistola, ma per il coraggio e la pazienza, perché aveva accettato la propria sorte e mi faceva da madre e da padre, compiendo per intero il proprio dovere senza mai lamentarsi. Lui riusciva a esprimere tutto ciò dall'altare, lanciandole un'unica occhiata, nonostante lei di solito si sedesse a metà strada tra il vestibolo e l'altare, nel settore più buio della chiesa, sotto la quinta stazione della Via Crucis. Non faceva mai la comunione, fatto che suscitava grandi perplessità e commenti nell'ambito dell'esigua congregazione. E non si confessava nemmeno. Quella donna era tutta una contraddizione: spesso, di mattina, frequentava le messe infrasettimanali, che non erano obbligatorie, senza mai "assumere" – per usare la terminologia di suor Matilda Marie, insegnante di catechismo – "la Messa, il Corpo e il Sangue di Cristo". Com'era strana, ora che ci ripenso dopo tanti anni, lì inginocchiata nella chiesa semivuota, con le prime luci del mattino che accendevano le vetrate dipinte, in mezzo a una manciata di donne anziane dalla pappagorgia cascante, che snocciolavano con dita nodose le perle del rosario! D'altra parte, immagino che anche mia madre fosse una specie di vedova. Non avevo mai pensato molto a lei prima del giorno in cui padre Michaels mi disse che era una donna straordinaria. Le volevo bene, credo, ma il mio era l'amore di un bambino di dieci anni, un amore arrogante, distaccato e non troppo ardente. Lei era la costante della mia vita; si accertava che avessi biancheria pulita nel cassetto più alto del comò, che la carne nel freezer si scongelasse per tempo, in modo da poter cucinare la cena una volta tornata dalla compagnia telefonica. Padre Michaels volle sapere tutto della nostra vita insieme, e io lo accontentai, rendendomi conto solo allora di quanto fosse insolita. Quando gli descrissi il nostro tran-tran quotidiano, indovinò subito quale dovesse essere la sua più grande preoccupazione al momento: l'inizio dell'estate. Una volta finita la scuola, lei avrebbe dovuto sistemarmi da qualche parte. Ero quasi grande abbastanza per essere autosufficiente – cioè per prepararmi da solo un panino per mezzogiorno — e quasi abbastanza maturo da meritarmi la sua fiducia. Quasi. Per quanto tranquillo, studioso e timido di natura, cominciavo a manifestare tendenze che la preoccupavano. Per esempio, ammiravo Elvis Presley. Soprattutto i suoi capelli. Né lui né i suoi capelli né la sua musica sembravano degni di ammirazione per mia madre, che mi proibì di infilare il pettine nero nel taschino laterale dei pantaloni, necessario a domare un ciuffo ribelle ostinato e molto poco elvisiano. No, qualcuno mi doveva tenere d'occhio. In passato avevamo contato sulla zia Rose, per luglio e agosto, ma quell'anno lei aveva lasciato intendere che forse le sarebbe piaciuto andare da qualche parte in vacanza, dato che dai tempi della guerra non si era più allontanata da Mohawk. Aveva visto, in fotografia, dei parchi nazionali all'Ovest che desiderava vedere dal vero, per capire se erano proprio così belli anche nella realtà. Mia madre trovava ridicola l'idea della zia Rose a Yellowstone, però capì al volo quello che la cugina intendeva dirle. Non aveva voglia di assumersi la responsabilità di tenere un bambino di undici anni per tutta l'estate. Quarantacinque minuti al giorno andavano bene, perché poteva darmi degli amaretti al cocco e accendere il televisore, ma non avrebbe saputo che cosa fare con un ragazzino della mia età per le vacanze estive. Amava i bambini, e il fatto di non averne avuti era il più grande rimpianto della sua vita; io, però, non ero più esattamente un bambino, e comunque non ero il suo bambino. | << | < | > | >> |Pagina 195Fu nel corso di una di queste gite in moto, nella primavera del 1960, in quel primo anno di convivenza con mio padre, che imboccammo la Third Avenue, e io vidi il cartello davanti alla nostra vecchia casa. Non ci ero più tornato da quando l'avevo riempita di oggetti rubati al grande magazzino Klein. Chissà perché, mi sembrava diversa, più piccola, sicuramente per via delle mie recenti escursioni nel mondo dei ricchi, i cui edifici in stile Tudor e i cui ranch a piani sfalsati mi avevano aperto nuovi orizzonti quanto alle dimensioni delle abitazioni umane. Ormai, la mia vecchia casa mi sembrava quasi una miniatura, come se la gente di altezza normale dovesse abbassarsi per passare dalle porte. Anche l'inverno aveva lasciato il segno, e da quel momento in poi mi domandai spesso come mai gli agenti atmosferici danneggiassero sempre di più gli edifici disabitati rispetto a quelli abitati, quasi avessero ottenuto una qualche strana licenza cosmica di distruzione. La casa era sporca e grigia, con la vernice parecchio scrostata vicino alle grondaie e sotto il colmo arrotondato del tetto. Non ricordavo di averla mai vista tanto squallida, e le misere condizioni in cui versava, assieme al cartello conficcato nel prato con su scritto "Vendesi", suscitarono in me una repentina e terribile consapevolezza: mia madre era morta durante l'inverno, e nessuno me l'aveva detto."Che cos'hai?" mi domandò mio padre quando Drew e io ricomparimmo. Tra lui e il ragazzo, in quel periodo, non c'erano screzi, dato che era stato papà a prestare i soldi per le ruote nuove della moto; Sammy, però, non perdeva occasione per schernire senza pietà Drew, avvertendolo, tra le altre cose, che se avesse mai avuto un incidente con me a bordo, avrebbe fatto meglio a rimontare in sella e allontanarsi il più possibile da Mohawk. Risposi che non avevo niente. Lui socchiuse gli occhi. "Non prendertela con me", disse Drew, girandosi e notando con sorpresa l'espressione cupa che avevo in volto. "Non è che puoi sempre dare la colpa a me per tutto, cazzo." Vedendo il cartello con la scritta "Vendesi" e rendendomi conto di quel che significava, avevo concluso che mio padre dovesse esserne al corrente. Forse lo sapevano tutti. Eileen, di sicuro. Forse persino Drew. Perché, sennò, si sarebbe preso la briga di scorrazzarmi in giro con la moto, quando avrebbe potuto fare da chauffeur a una o a più ragazze, tutte leggermente sovrappeso e con i capelli sporchi, che gli si stringevano alla schiena con i loro grossi seni. Magari lo sapevano anche i frequentatori del Mohawk Grill. Cercai di ricordare se qualcuno mi avesse trattato con particolare gentilezza, negli ultimi tempi, e più ci pensavo più trovavo prove. Alcune di queste risalivano a qualche mese prima, ma io non sapevo da quanto tempo il cartello con la scritta "Vendesi" si trovasse nel giardino anteriore della mia vecchia casa. Forse la morte della mamma era già roba superata. Forse si erano scordati del segreto che avevano giurato di mantenere in mia presenza. Molti erano uomini che dimenticavano le loro stesse famiglie senza che nessuno glielo chiedesse. A quel punto, probabilmente, si erano già dimenticati persino del fatto che mia madre fosse mai esistita. Quella sera, mentre eravamo soli nell'appartamento a guardare il notiziario delle undici e mio padre, in mutande, si grattava con aria assorta, gli dissi che volevo andare a trovare la mamma, quella domenica. Dovevo aver parlato con una voce strana, perché lui mi guardò incuriosito prima di rispondere. "Perché no?" disse. "Dico sul serio", ribadii. Lo osservai per valutare la sua reazione, ma lui non ne ebbe alcuna. Non che ci fosse da meravigliarsene, d'altronde. Giocando a Bugiardi mio padre era capace di dichiarare sei 2 senza averne in mano neanche uno e conservando, malgrado un'espressione distaccata, assorta, quasi annoiata. Ma era possibile che non lo sapesse? Era possibile che mia madre fosse talmente insignificante da morire a Schenectady senza che nessuno si fosse preso la briga di informarci? Dopo tutto, noi non avevamo il telefono, e non ero sicuro che la casa di cura avesse il nostro indirizzo. Sulla nostra casella postale nell'atrio buio al piano di sotto non c'era neppure scritto il nostro cognome, e il postino non si curava nemmeno di riempirla di pubblicità. Chiunque volesse contattare mio padre, lasciava un messaggio da Harry o da Greenie, dai Littler oppure in qualche altro suo covo abituale. Probabilmente erano scattati dei meccanismi burocratici, e il problema della casa di mia madre era stato gestito da qualche studio legale più a sud, dove nessuno sapeva dell'esistenza mia e di papà; o magari, anche ammesso che qualcuno sapesse di noi, non erano riusciti a trovare elenchi né altri registri ufficiali sulla cui base localizzarci. In tal caso, ben ci stava, a me e a lui. Di certo, alla casa di cura si era presentato un uomo in completo scuro con tanto di bloc notes per prendere appunti. Mia madre aveva parenti? Visitatori? Sarà pur venuto qualcuno a trovarla... Una persona che si sia chinata per baciarle la scarna guancia... No, doveva aver risposto la buona infermiera. La paziente era sempre rimasta sola. Era morta in solitudine. "Allora sarà meglio che ti tagli i capelli", disse mio padre, squadrandomi di nuovo da capo a piedi, vagamente insoddisfatto di quel che vedeva, ma incapace di individuare quel che mancava per rendermi presentabile a una donna che lui – posto che la ritenesse davvero ancora in vita – non poteva immaginare se non stremata, rinchiusa in se stessa, sedata o in stato comatoso, ma che preferiva ricordare molto bella, irascibile, forse armata e piena di rancore. | << | < | > | >> |Pagina 329E così ebbe inizio l'ultima fase della mia vita da ragazzo a Mohawk. In seguito, da adulto, ci sarei ritornato più volte, ma solo come visitatore, non come residente. Tuttavia, non mi stabilii mai davvero in nessun altro posto, essendomi unito alla moltitudine di americani vaganti che condividono in gran numero un passato a Mohawk, il cui ricordo li spinge non si sa bene dove, purché lontano di lì. Quanto a ritornare, ritorniamo, ma solo per guadagnare nuovo slancio per compiere il salto successivo, ogni volta più lontano di quello precedente, fino all'esaurimento della forza elastica che ci attira verso casa. F. William Peterson aveva pensato a tutto. Aveva trovato alla mamma un bell'appartamento al piano superiore di una villetta in pietra di Greenwood Drive. La proprietaria era un'anziana rimasta vedova da poco che affittava la casa a un prezzo inferiore alla media della zona. Faceva parte dell'accordo. In estate, tagliavo l'erba del prato con il vecchio tosaerba traballante, in autunno rastrellavo le foglie e le bruciavo nel grosso bidone arrugginito, e in inverno spalavo la neve dal marciapiede e dal lungo vialetto che collegava la strada al doppio e vuoto garage della villetta. (Né noi né la nostra padrona di casa avremmo posseduto un'auto fino al 1965, quando, nella seconda metà dell'ultimo anno di scuola superiore, acquistai una Galaxie grigia del 1959 per potermene andare all'università, all'Ovest.) E. William Peterson non aveva potuto fare niente per salvare la vecchia casa, e i profitti ricavati dalla vendita erano stati divorati dalle spese. Noi, però, non eravamo per nulla indigenti. I mobili erano ancora nostri, e avevamo ancora alcune migliaia di dollari. Mia madre, inoltre, che doveva continuare a prendere le sue medicine e dunque era stata dichiarata invalida, riceveva un piccolo sussidio statale. Dalla finestra della mia bella camera da letto godevo di un'ampia vista della via tranquilla e alberata in cui abitavamo, una di quelle che Drew Littler e io avevamo perlustrato avanti e indietro in motocicletta. Credo che F. William Peterson avesse deciso di sposare mia madre, una volta superato l'ostacolo dato dal fatto che lei continuava a essere sposata con mio padre. Non mi pare che la mamma avesse fatto alcunché per dargli l'impressione di essere disposta ad accettare la sua offerta di matrimonio, però non gli aveva neppure detto chiaramente di no. A trentotto anni, era diventata quasi completamente grigia, metamorfosi che, una volta cominciata, aveva avuto luogo in pochi mesi. Per altri versi, tuttavia, aveva un aspetto più giovanile che negli ultimi anni. La terribile fragilità, che aveva sciupato il suo viso da ragazza già un anno prima che le venisse l'esaurimento nervoso, era ormai scomparsa, e aveva messo su qualche chilo. Il magro seno che F. William Peterson aveva intravisto sotto il camice verde chiaro dell'ospedale era di nuovo pieno, e lui non avrebbe potuto ammirarla di più neanche se l'avesse disegnata lui stesso, come in un certo senso aveva fatto. All'inizio ci frequentava molto spesso, ed era il nostro unico ospite per cena, anche se non rimaneva mai a dormire. Per quanto possa sembrare incredibile, l'altra mia vita cessò semplicemente di esistere. Non vidi più mio padre, e solo di rado mi capitava di incontrare qualcuno dei suoi amici; inoltre, non tornai più al Mohawk Grill. Su insistenza di mia madre, smisi di fare le pulizie da Rose e dovetti anche rinunciare a raccogliere palline al campo da golf; in compenso mi riabituai alle lenzuola pulite, alle camicie stirate di fresco, alle cene consumate seduti a tavola nella casa in cui abitavo. Una volta m'imbattei in Wussy, il quale mi disse che Drew Littler era stato rinchiuso nel manicomio statale a Utica. Dopo che ero tornato a vivere con mia madre, era stato arrestato tre volte per essersi introdotto nella casa dei Ward; tutte e tre le volte era finito in galera, dove aveva intrattenuto ubriachi e secondini sbattendo la fronte contro le sbarre della cella fino a sanguinare e a perdere conoscenza. Un giorno, più o meno un mese dopo che ci eravamo trasferiti nel nuovo appartamento, suonò il campanello di casa e mi ritrovai davanti due poliziotti che volevano parlarmi della scomparsa di Willie Heinz. Mia madre li informò che aveva ben presente la famiglia in questione e che era certa che suo figlio conoscesse solo di sfuggita un ragazzo del genere. Seguii i poliziotti in strada e raccontai loro del pomeriggio in cui, uscendo dalla chiesa della Madonna Addolorata, avevo visto Willie Heinz che correva a rotta di collo inseguito da un'auto della polizia. Vollero sapere la data e l'ora esatta dell'avvistamento, e io scoprii di essere in grado di fornirgliela, per via della morte di Jack Ward. Venne fuori che, tra le persone interrogate, io ero quello che l'aveva visto per ultimo, cosa alquanto agghiacciante. Aveva mai detto di voler fuggire?, mi domandarono. Mi aveva mai parlato della sua vita in famiglia? Risposi di no. Avrei voluto aggiungere che sembrava incapace di correre per più di due o tre isolati di seguito senza deviare e tornare indietro, ma non avrei saputo spiegare la cosa senza confessare la mia partecipazione a circa un anno di squallidi vandalismi. Tutto sommato, non ce la passavamo male, mia madre e io. Greenwood Drive non era un brutto posto in cui vivere, e ben presto in quell'appartamento cominciammo a sentirci proprio a casa nostra. "Quante belle cose", osservò un giorno la mamma con aria assorta e l'ormai abituale sorriso vago stampato sulle labbra. Stava osservando uno degli oggetti che avevo rubato al grande magazzino Klein. "Quante belle cose che non ricordavo di avere."
All'ospedale, però, e in seguito nella casa di cura, si era dovuta
confrontare con una miriade di misteri e aveva imparato
ad accettare l'esistente per quel che era.
Lei e F. William Peterson temevano un'altra guerra. In fin dei conti, avevano a che fare con Sam Hall, e avevano entrambi buoni motivi per valutare con attenzione le potenziali conseguenze della cosa. L'avvocato aveva scelto di proposito un appartamento a un piano sopraelevato per mia madre e aveva fatto cambiare le serrature davanti e dietro rimettendoci un bel po' di denaro, nell'eventualità che le cose prendessero una brutta piega. Aveva messo in allarme anche le autorità del municipio. Io non ero stato interpellato, ma al posto loro non mi sarei disturbato più di tanto. Benché mia madre fosse sotto l'effetto del Librium, sarebbe bastata una, o al massimo due, delle telefonate di cui mio padre era un maestro per rispedirla immediatamente in casa di cura, con o senza serrature nuove. Tuttavia, non accadde mai nulla. Un pomeriggio, una settimana prima che cominciassero le vacanze estive, tornai da scuola e vidi il furgone di Wussy parcheggiato davanti a casa nostra con lo sportello posteriore aperto; era chiaramente fuori posto in quella via alberata. Lui e mio padre stavano uscendo dal garage, quando raggiunsi in bicicletta il vialetto d'accesso. "Ciao, straniero", disse mio padre, e io mi sentii assalire da un senso di colpa così forte da tagliarmi le gambe. "Ti sei dimenticato dov'è il centro della città?" "No", risposi. "Allora devi essere invisibile", osservò Wussy. "L'abbiamo sistemato piuttosto bene", disse papà. "Per la verità, dovrebbe stare in casa, ma tua madre non ha voluto saperne." Guardai la fila di finestre al piano di sopra. Dietro una di quelle vidi muoversi una tenda. Wussy tornò nel furgone, e mio padre e io rimanemmo zitti per un minuto. Durante i due anni trascorsi con lui, eravamo arrivati al punto che nei giorni migliori riuscivamo a dialogare in senso proprio, magari scambiandoci una battuta o due, ma nelle poche settimane che erano passate da quando ero tornato a vivere con mia madre avevamo perso l'abitudine. "Ti troverai bene, qui?" domandò infine. Risposi di sì, certo. Mi sarei trovato bene. Avevo un groppo in gola. Lui e Wussy non avevano trascinato quel pesante tavolo da biliardo giù per tre rampe di scale solo perché lui voleva regalarmelo. "Lei è in forma", disse. "Mi ha fatto entrare. Mi ha persino mostrato la casa e tutto il resto. Per poco non mi cascavano tutti i denti per la sorpresa. Naturalmente, Wussy non ha voluto farlo entrare, però..." Lasciò la frase in sospeso. "Però si è sistemata bene." "Dove vai?" chiesi infine. "Vado via. Per un po'. Tornerò, credo." "Quando?" Estrasse qualche banconota da un dollaro e me ne diede una. Dichiarai tre 3. "Bugiardo", fece lui. Aveva ragione. Non c'era neanche un 3, e dubitavo che sarei stato in grado di vederlo, se anche ci fosse stato. Percorremmo il vialetto diretti verso il furgone. Mio padre chiuse lo sportello. "Quel tavolo vale sette-ottocento dollari. Se proprio lei non lo può vedere, vendilo. Per me è uguale. Basta che non ti fai fregare." Dissi che non l'avrei venduto. "Non ho lottato molto per tenerti, eh?" disse, riferendosi al fatto che la mattina in cui mia madre si era presentata in casa sua annunciando le proprie intenzioni, lui si era limitato a rispondere: "Va bene, prenditelo pure". "Non è come credi tu, comunque", continuò. "Il fatto è che qui starai meglio. Lontano da tutti i casini." Non gli rimaneva che darmi uno scappellotto, e me lo diede. "Per lo meno ci siamo divertiti un po', eh?" Gli dissi di sì, e infatti era vero. Ci stringemmo la mano, dopo di che lui salì sul furgone accanto a Wussy, abbassò il finestrino e mi sorrise. "Tu non lo sai ancora, però mi hai prestato qualche centinaio di dollari. Te li spedisco più o meno fra una settimana." "Lascia stare", gli dissi, "non li voglio." "E invece sì che li vuoi", replicò, "altrimenti non mi avresti costretto a cercarli dappertutto."
E così se ne andò.
Non lo rividi per dieci anni e non seppi più nulla di lui e dei suoi spostamenti. Non una lettera, non un biglietto per Natale.
D'altra parte, probabilmente me lo aspettavo, perché, dopo
aver visto partire il furgone, andai in garage e giocai a biliardo
per ore sotto la lampadina nuda appesa al soffitto, da solo, a
parte la silenziosa e turbinante nuvola di falene.
|