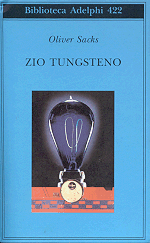
|
|
|
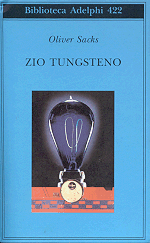
|
|
|
| << | < | > | >> |Indice
I. Zio Tungsteno 11
II. «37» 21
III. Esilio 30
IV. «Un metallo ideale» 45
V. Luce per le masse 60
VI. Il paese della stibnite 70
VII. Svaghi chimici 85
VIII. Chimica, odori pestilenziali
ed esplosioni 96
IX. Visite a domicilio 112
X. Un linguaggio chimico 124
XI. Humphry Davy: un chimico-poeta 139
XII. Immagini 152
XIII. I tondini di legno del signor Dalton 169
XIV. Linee di forza 178
XV. Vita in famiglia 193
XVI. Il giardino di Mendeleev 212
XVII. Uno spettroscopio tascabile 236
XVIII. Fuoco freddo 246
XIX. Mamma 259
XX. Raggi penetranti 272
XXI. L'elemento di Madame Curie 282
XXII. Cannery Row 297
XXIII. Il mondo liberato 312
XXIV. Luce brillante 326
XXV. Fine di un amore 343
Postfazione 349
Note 353
Ringraziamenti 393
Indice analitico 395
|
| << | < | > | >> |Pagina 11Molti dei miei ricordi d'infanzia sono legati ai metalli - come se avessero esercitato su di me un potere immediato. Spiccando sullo sfondo di una realtà eterogenea, si distinguevano per la lucentezza, il bagliore, l'aspetto argenteo, la levigatezza e il peso. A toccarli erano freddi, e quando venivano percossi risuonavano. Mi piaceva il giallo dell'oro, e quel suo essere così pesante. Mia madre si sfilava dal dito la fede nuziale e me la lasciava tenere in mano per un po' mentre mi parlava della sua inviolabilità, di come non si annerisse mai. «Senti com'è pesante» aggiungeva. «Più pesante del piombo». Che cosa fosse il piombo già lo sapevo, perché avevo maneggiato un pezzo di tubatura, fatta di quel metallo tenero e pesante, che l'idraulico aveva dimenticato a casa nostra. Anche l'oro era tenero, mi spiegava mia madre, e perciò solitamente lo si rendeva più duro combinandolo con un altro metallo. Lo stesso accadeva col rame: lo si univa allo stagno per ottenere il bronzo. Bronzo! - solo il suo nome era per me come uno squillo di tromba, giacché il suono stesso della battaglia era un vivace cozzare di bronzo su bronzo, lance di bronzo su scudi di bronzo, il grande scudo di Achille. Altrimenti, il rame si poteva legare allo zinco, raccontava mia madre, e in tal caso si otteneva l'ottone. Tutti noi, mia madre, i miei fratelli e io, avevamo i nostri menorah di ottone - i caratteristici candelabri per la festa della chanukkah. (Mio padre ne aveva uno d'argento). Conoscevo il rame, il lucente colore rosato del grande calderone in cucina - lo tiravamo giù solo una volta all'anno, quando in giardino maturavano le mele selvatiche e le cotogne e mia madre le cuoceva per fare la gelatina. Conoscevo anche lo zinco: la vaschetta per far fare il bagno agli uccelli, in giardino, opaca e leggermente azzurrina, era fatta di zinco; e lo stagno, per via della pesante stagnola in cui avvolgevamo i sandwich destinati ai picnic. Mia madre mi mostrò che quando lo stagno o lo zinco venivano piegati emettevano un «grido» particolare. «Dipende dalla deformazione della struttura cristallina» mi spiegava, dimenticando che avevo solo cinque anni e non potevo capire le sue parole - ciò nondimeno, esse mi affascinavano e suscitavano in me il desiderio di saperne di più. In giardino c'era un enorme rullo in ghisa per il prato - pesava più di duecento chili, diceva mio padre. Noi, da bambini, non riuscivamo nemmeno a spostarlo, ma lui era immensamente forte, ed era capace di sollevarlo da terra. Era sempre un po' arrugginito, e questo mi disturbava, perché la ruggine si sfaldava, lasciando dietro di sé piccoli buchi e croste, e io temevo che tutto il rullo potesse corrodersi e un giorno o l'altro andare in pezzi, ridotto a una massa rossiccia di polvere e frammenti sfaldati. Dovevo poter pensare ai metalli come a qualcosa di stabile, qualcosa come l'oro - capace di sottrarsi ai danni e agli insulti del tempo. A volte chiedevo a mia madre di tirar fuori l'anello di fidanzamento e di mostrarmi il diamante che vi era incastonato. Brillava come nessun'altra cosa avessi mai visto, quasi come se emettesse più luce di quanta ne assorbiva. Mia madre mi mostrava con che facilità graffiasse il vetro, e poi mi diceva di posarmelo sulle labbra. Era freddo: stranamente e sorprendentemente freddo; anche i metalli erano freddi al tatto, ma il diamante era proprio gelato. Era così, mi spiegò lei, perché conduceva splendidamente il calore, meglio di qualsiasi metallo, e quindi lo sottraeva alle labbra non appena esse lo sfioravano. Questa fu una sensazione che non dimenticai più. Un'altra volta, mia madre mi mostrò che se si toccava un cubetto di ghiaccio con un diamante, quest'ultimo avrebbe sottratto calore alla mano trasferendolo al ghiaccio, che si sarebbe lasciato tagliare come burro. Aggiunse che il diamante era una forma speciale di carbonio, proprio come il carbone che usavamo per riscaldare le stanze in inverno. Questa rivelazione mi sconcertò: com'era possibile che il carbone - nero, friabile e opaco - e la pietra preziosa dura e trasparente incastonata nel suo anello fossero la stessa sostanza? | << | < | > | >> |Pagina 16Le mie domande erano infinite, e spaziavano su tutto, sebbene tendessero a tornare ciclicamente e di continuo sull'oggetto della mia fissazione: i metalli. Perché erano lucenti? Perché lisci? Perché freddi? Perché duri? Perché pesanti? Perché si piegavano senza spezzarsi? Perché risonavano? Perché due metalli teneri come lo zinco e il rame, o come lo stagno e il rame, potevano combinarsi e produrne un altro più duro? Che cosa conferiva all'oro la sua qualità aurea, e perché non anneriva mai? In linea di massima mia madre era paziente, e cercava di spiegarmi, ma alla fine, quando non ne poteva proprio più, mi diceva: «Questo è tutto quello che so - se vuoi saperne di più, chiedi a zio Dave».Lo chiamavamo zio Tungsteno da tempo immemorabile, perché fabbricava lampadine a incandescenza il cui sottile filamento era fatto di tungsteno. La sua azienda si chiamava Tungstalite; spesso lo andavo a trovare nel vecchio stabilimento di Farringdon e stavo a guardarlo mentre lavorava, con una camicia dal colletto a punte ripiegate e le maniche arrotolate. La polvere scura e pesante di tungsteno veniva pressata, martellata, sinterizzata al calor rosso, e poi tirata in fili sempre più sottili dai quali ottenere i filamenti delle lampadine. Le mani dello zio erano segnate dalla polvere nera, in un modo che nessun lavaggio poteva ormai più ripulire (per farlo, avrebbe dovuto rimuovere tutto lo spessore dell'epidermide, e anche così, ho il sospetto che non sarebbe stato abbastanza). Dopo trent'anni di lavoro con il tungsteno, immaginavo che il pesante elemento gli fosse penetrato nei polmoni e nelle ossa, in tutti i vasi e i visceri, in ogni tessuto del suo corpo. Pensavo a tutto questo come a un fatto prodigioso, non come a una condanna - come se il suo corpo fosse rinvigorito e fortificato dal potente elemento, dal quale traeva una forza e una resistenza quasi sovrumane. Ogni volta che visitavo lo stabilimento, zio Dave mi portava in giro a vedere le macchine, o incaricava il suo caporeparto di accompagnarmi. (Il caporeparto era un uomo basso e muscoloso, una specie di Popeye dalle braccia enormi, palpabile testimonianza dei benefici arrecati dal lavoro con il tungsteno). Non mi stancavo mai di guardare quelle macchine ingegnose, sempre meravigliosamente pulite, lucide e ben oliate, o il forno in cui la polvere nera incoerente veniva compattata e convertita in barre dense e dure che emettevano bagliori grigi. Durante le mie visite allo stabilimento, e a volte anche a casa, zio Dave mi insegnava qualcosa sui metalli servendosi di piccoli esperimenti. Già sapevo che il mercurio, quello strano metallo liquido, era incredibilmente denso e pesante. Perfino il piombo ci galleggiava sopra, come mi dimostrò zio Dave mettendo un proiettile di piombo in un recipiente pieno di mercurio. Poi, però, estrasse dalla tasca una piccola barra grigia, e con mia grande meraviglia essa andò immediatamente a fondo. Quello, mi disse, era il suo metallo, il tungsteno. | << | < | > | >> |Pagina 39Le mie uniche vere vacanze, durante la guerra, furono le visite nel Cheshire, nel cuore della foresta del Delamere, dove zia Len aveva fondato la Jewish Fresh Air School per «bambini cagionevoli» (si trattava di bambini di famiglie della classe operaia di Manchester, molti dei quali soffrivano d'asma, alcuni avevano avuto il rachitismo o la tubercolosi, e un paio, ripensandoci a posteriori, dovevano essere autistici). Tutti i bambini avevano un orticello, un quadrato di terra con il lato d'un paio di metri, delimitato da pietre. Desideravo disperatamente poter andare a Delamere invece che a Braefield - ma questo fu un desiderio che non espressi mai (mi chiedevo, però, se mia zia, affettuosa e perspicace com'era, non lo avesse capito).Zia Len mi incantava sempre con ogni sorta di meraviglie botaniche e matematiche. Mi mostrò i motivi a spirale sui capolini dei girasoli in giardino, e mi suggerì di contare i flosculi al loro interno. Quando lo ebbi fatto, mi mostrò che erano disposti secondo una serie - 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, ... - in cui ogni numero era la somma dei due che lo precedevano. E se si divideva ogni numero per quello che lo seguiva (1/2, 2/3, 3/5, 5/8, ... ) ci si avvicinava sempre più al numero 0,618. Questa serie, mi spiegò, era chiamata «serie di Fibonacci», dal nome di un matematico italiano vissuto alcuni secoli fa. Il rapporto 0,618, aggiunse zia Len, era noto come divina proporzione, o sezione aurea: una proporzione geometrica ideale spesso usata da architetti e artisti. Zia Len mi portava con sé a fare lunghe passeggiate nella foresta, insegnandomi la botanica; mi faceva vedere le pigne cadute, mostrandomi che anch'esse avevano spirali basate sulla sezione aurea. Mi indicava gli equiseti che crescevano vicino a un corso d'acqua, facendomi toccare i loro fusti rigidi e articolati e suggerendomi di misurarli e di riportare su un grafico la lunghezza dei segmenti successivi. Quando lo feci, e vidi la mia curva appiattirsi, zia Len mi spiegò che si trattava di incrementi «esponenziali», e che di solito la crescita ha luogo proprio in quel modo. Quei rapporti, quelle proporzioni geometriche, mi disse, si trovavano ovunque in natura: il mondo era costruito in base ai numeri. L'associazione delle piante e dei giardini con i numeri assunse per me una forma simbolica di una strana intensità. Cominciai a pensare a un regno o dominio dei numeri, con una sua geografia e con lingue e leggi sue proprie; ma, ancor di più, immaginavo un giardino di numeri - un giardino segreto, meraviglioso e magico. Era un luogo nascosto e inaccessibile ai bulli e al preside; un giardino nel quale mi era in qualche modo riservata un'accoglienza benevola e un aiuto. In questo giardino, fra i miei amici non c'erano solo i numeri primi e i girasoli di Fibonacci, ma anche i numeri perfetti (come 6 o 28, somma dei loro divisori, essi stessi esclusi); i numeri pitagorici, il cui quadrato è la somma di altri due quadrati (come 3, 4, 5, oppure 5, 12, 13); e i «numeri amici» (come 220 e 284), coppie di numeri nei quali la somma dei divisori di uno è uguale all'altro, e viceversa. Zia Len, poi, mi aveva mostrato che il mio giardino di numeri era doppiamente magico - non solo una fonte di piacere e conforto sempre disponibile, ma anche parte del piano in base al quale era costruito l'intero Universo. I numeri, diceva mia zia, sono il modo di pensare di Dio. | << | < | > | >> |Pagina 94Oltre alla collezione di campioni di minerali, ne avevo anche una di monete, sistemate in un armadietto di legno di mogano lucidissimo, con le antine che si aprivano come le porte di un piccolo teatro, rivelando una serie di sottili vassoi con appositi alloggiamenti circolari, rivestiti di velluto: alcuni del diametro di soli sei millimetri (per i groat, i pezzi da tre penny d'argento, e i Maundy Money, minuscole monete d'argento che si davano ai poveri a Pasqua), altri di quasi cinque centimetri (per le corone, che io adoravo; e per i giganteschi pezzi da due penny coniati alla fine del diciottesimo secolo, ancor più grandi delle corone).C'erano anche gli album per i francobolli, e i francobolli che mi piacevano di più erano quelli di isole remote, che mostravano scene e piante locali, francobolli che da soli potevano rappresentare il surrogato di un viaggio. Adoravo quelli che mostravano diversi minerali, e quelli con particolarità di vario tipo: francobolli triangolari, non perforati, con la filigrana invertita o ai quali mancavano delle lettere o delle scritte stampate sul dorso. Uno dei miei preferiti era un curioso francobollo serbo-croato del 1914 che, mi dissero, mostrava i lineamenti dell'arciduca Ferdinando assassinato, visto da un certo angolo. La collezione che mi stava più a cuore, però, era una singolare raccolta di biglietti d'autobus. A quei tempi, a Londra, ogni qualvolta si prendeva un autobus si acquistava un cartoncino oblungo colorato recante lettere e numeri. Fu dopo aver acquistato un O16 e un S32 (le mie iniziali, ma anche i simboli chimici dell'ossigeno e dello zolfo, e accanto ad essi, per un caso fortuito, anche i loro pesi atomici) che decisi di raccogliere i biglietti d'autobus «chimici», per vedere quanti dei novantadue elementi sarei riuscito a procurarmi. Fui straordinariamente fortunato, o così almeno mi sembrò (sebbene fosse solo una questione di caso), perché i biglietti si andarono rapidamente accumulando e ben presto ne ebbi un'intera collezione (W184, il tungsteno, mi diede un particolare piacere, anche perché era l'altra mia iniziale, che mi mancava). Ci furono, certo, alcuni pezzi difficili: fatto irritante, il cloro aveva un peso atomico di 35,5, che non era un numero intero; senza darmi per vinto, raccolsi un Cl355, e gli aggiunsi un minuscolo punto decimale. Le singole lettere erano più facili da trovare: ebbi subito un H1, un B11, un C12, un N14 e un F19, oltre all'O16 originale. Quando mi resi conto che i numeri atomici erano ancor più importanti dei pesi atomici, cominciai a raccogliere anche quelli. Alla fine, avevo tutti gli elementi conosciuti, da H1 a U92. Nella mia mente, ogni elemento divenne indissolubilmente associato a un numero, e ogni numero a un elemento. Mi piaceva portare con me la mia piccola raccolta di biglietti d'autobus chimici; mi dava la sensazione di avere, in tasca e in un piccolissimo spazio, l'intero Universo con le sue unità costruttive. | << | < | > | >> |Pagina 125Zio Dave considerava tutta l'impresa scientifica non esclusivamente sul piano intellettuale e tecnologico, ma anche su quello umano, e a me sembrò naturale fare lo stesso. Quando allestii il mio laboratorio e cominciai a fare qualche esperimento chimico per conto mio, ero desideroso di imparare la storia della chimica in senso lato: scoprire che cosa facessero e come ragionassero i chimici, in quale atmosfera si muovessero nei secoli passati. Da tempo ero affascinato dalla storia della nostra famiglia e dal nostro albero genealogico - dai racconti sugli zii andati in Sudafrica e su chi li aveva messi al mondo, come pure sul primo antenato di mia madre di cui avessimo una traccia documentata, un rabbino che si diceva avesse un'inclinazione per l'alchimia, un tal Lazar Weiskopf, vissuto a Lubecca nel diciassettesimo secolo. È possibile che tutto ciò abbia stimolato il mio amore per la storia in generale, come pure, forse, la tendenza a considerarla in termini familiari. Fu così che gli scienziati, i primi chimici di cui avevo letto nei libri, divennero in un certo senso miei antenati onorari, persone con le quali, nella fantasia, avevo una sorta di legame. Per potermi calare nel loro mondo, dovevo capire i loro meccanismi mentali. La chimica come scienza - così avevo letto - nacque con l'opera di Robert Boyle, a metà del diciassettesimo secolo. Di vent'anni maggiore di Newton, Boyle visse in un'epoca in cui l'alchimia era ancora dominante, e in lui, accanto a idee autenticamente scientifiche, convivevano credenze e pratiche alchemiche. Ad esempio, credeva nella possibilità di creare l'oro, e pensava di aver trovato il modo di farlo (ma Newton, alchimista pure lui, gli consigliò di tacere). La sua curiosità - una «santa curiosità» ebbe a dire Einstein - era senza limiti e lo portò a esplorare una gamma amplissima di fenomeni: ai suoi occhi, tutte le meraviglie della natura rivelavano la gloria divina. | << | < | > | >> |Pagina 146Davy amava fare esperimenti in pubblico e le sue famose conferenze, o conferenze-dimostrazioni, erano emozionanti, eloquenti e spesso letteralmente esplosive. Prendevano spunto dai dettagli più riposti dei suoi esperimenti per arrivare alla speculazione sull'Universo e sulla vita, ed erano tenute con uno stile e una ricchezza di linguaggio ineguagliabili. Ben presto egli divenne il più famoso e influente conferenziere d'Inghilterra, attirando ogni volta un'enorme folla che bloccava il traffico. Perfino Coleridge, il più grande oratore dell'epoca, andava alle conferenze di Davy, non solo per riempire i suoi taccuini di chimica, ma per «rinverdire» la sua «riserva di metafore».Ai primi dell'Ottocento, l'unità delle due culture, umanistica e scientifica, esisteva ancora; quella dissociazione della sensibilità che si sarebbe prodotta di lì a poco era ancora di là da venire - e il periodo che Davy passò a Bristol vide nascere una stretta amicizia fra lui, Coleridge e i poeti romantici. Lo stesso Davy, all'epoca, scriveva - e talvolta pubblicava - poesie; i suoi quaderni contenevano, mescolati, dettagli di esperimenti, poesie e riflessioni filosofiche; nella sua mente, a quanto pare, non c'erano compartimenti stagni. Nei primi tempi della rivoluzione industriale c'era una gran voglia di scienza, e soprattutto di chimica; si credeva che fosse un modo nuovo e potente (ma non arrogante) non solo per comprendere il mondo, ma anche per guidarlo verso una condizione migliore. Lo stesso Davy pareva incarnare questo nuovo ottimismo, capace com'era di cavalcare la cresta di una nuova grande onda di potere scientifico e tecnologico, che prometteva, o minacciava, di trasformare il mondo. Per cominciare, aveva scoperto una dozzina di elementi; poi aveva suggerito nuove tecniche di illuminazione ed elaborato una teoria elettrica della combinazione chimica, della materia e dello stesso Universo - e tutto questo a neppure trent'anni. | << | < | > | >> |Pagina 193Il sionismo ebbe una parte importante in entrambi i rami della mia famiglia. Alida, la sorella di mio padre, lavorò durante la Grande Guerra come assistente di Nahum Sokolov e Chaim Weitzmann, che all'epoca erano i leader del movimento in Inghilterra; visto il suo talento per le lingue, fu incaricata della traduzione della Dichiarazione di Balfour del 1917 in ebraico e in russo; suo figlio Aubrey, ancora ragazzo, era già un sionista erudito ed eloquente (e in seguito, col nome di Abba Eban, fu primo ambasciatore di Israele alle Nazioni Unite). Poiché i miei genitori erano medici e avevano una casa grande, era pacifico che essa diventasse punto d'incontro, e sede ospitale, per riunioni sioniste, e questa sorta di occupazioni, quando io ero bambino, erano piuttosto frequenti. Li sentivo dalla mia camera da letto al piano di sopra - voci che si alzavano, discussioni infinite, pugni che si abbattevano iracondi sul tavolo - e ogni tanto un sionista, infiammato per la collera o l'entusiasmo, irrompeva nella mia stanza, alla ricerca del bagno. Questi incontri sembravano costare moltissimo ai miei genitori, che ogni volta ne uscivano con un'aria pallida e sfinita; tuttavia, si sentivano in dovere di offrire ospitalità. Non li udii mai parlare fra loro della Palestina o del sionìsmo, e ho il sospetto che non avessero convinzioni forti in materia - almeno fino a dopo la guerra, quando l'orrore dell'Olocausto li convinse della necessità di una «casa nazionale ebraica». Credevo che subissero la prepotenza degli organizzatori dei meeting come pure di tutti quei ferventi sostenitori che, come gangster, bussavano alla porta chiedendo ingenti somme di denaro per le yeshivah o «scuole talmudiche». I miei, che in genere avevano le idee chiare ed erano indipendenti, di fronte a quelle richieste sembravano diventare molli e inermi, forse perché si sentivano in obbligo o erano ansiosi. I miei sentimenti personali (di cui non parlai mai con loro) erano appassionatamente negativi: arrivai a detestare il sionismo e ogni forma di predicazione e di politica, che consideravo attività rumorose, invadenti e ispirate all'arroganza. Anelavo alle discussioni tranquille e alla razionalità della scienza. Nella pratica religiosa, i miei genitori erano moderatamente osservanti (sebbene io ricordi ben poche discussioni riguardanti le reali convinzioni di chicchessia); alcuni membri della famiglia, per contro, lo erano in modo estremo. Si raccontava che il padre di mia madre si svegliasse di notte se gli cadeva lo yarmulke, il copricapo tradizionale, e che il padre di mio padre non se lo togliesse nemmeno quando andava a nuotare. Alcune zie portavano gli sheitl - parrucche - che davano loro un aspetto stranamente giovanile, quasi da mannequin: Ida ne aveva una giallo vivo, Gisela una nero corvino, che non cambiarono mai, persino quando, molti anni dopo, i miei capelli cominciarono a ingrigire. Annie, la sorella maggiore di mia madre, era andata in Palestina verso il 1890 e aveva fondato a Gerusalemme una scuola, un istituto per «gentildonne inglesi di fede mosaica». Aveva un'aria autoritaria, dominatrice. Insopportabilmente ortodossa, credeva - immagino - di essere in rapporti personali con la Divinità (proprio come lo era con il Rabbino Capo, il Mandatario, e il Mufti, a Gerusalemme). Tornava periodicamente in Inghilterra con bauli enormi - per trasportarli occorrevano sei facchini - e durante le sue visite portava in casa nostra un'atmosfera di rigore religioso terrificante; i miei genitori, più moderati, erano alquanto intimiditi dal suo sguardo penetrante. Un giorno - era un sabato opprimente, nell'atmosfera tesa dell'estate del 1939 - mi era venuta voglia di andare in triciclo su e giù lungo Exeter Road, vicino a casa, ma all'improvviso ci fu un acquazzone e mi ritrovai bagnato fradicio. Annie mi puntò l'indice contro, e scuotendo gravemente la testa mi fece: «Andare in triciclo di sabato! Non la passerai liscia, a Lui non sfugge nulla, Lui ti osserva sempre!». Da quella volta presi a detestare il Sabato, e anche Dio (quanto meno il Dio vendicativo e punitivo evocato dall'ammonimento di Annie), e sviluppai un sentimento di ansioso e guardingo disagio nei confronti del Sabato (sentimento che persiste, un poco, anche oggi). | << | < | > | >> |Pagina 210Subito dopo, Michael divenne psicotico. Percepiva un mondo magico e maligno che si chiudeva intorno a lui. (Una volta mi raccontò che sul bus 60, diretto ad Aldwych, la scritta era stata «trasformata» così che la parola Aldwych ora appariva scritta in lettere old-witchy, stregonesche, simili a rune). Arrivò a convincersi, di essere «il prediletto di un Dio maniaco della flagellazione», soggetto alle particolari attenzioni di una «Provvidenza sadica». Anche qui, non c'era un riferimento esplicito al sadismo del preside di Braefield, ma non potei fare a meno di pensare che il signor B. fosse lì, amplificato fino a raggiungere dimensioni cosmiche in una Provvidenza o in un Dio mostruosi. Contemporaneamente fecero la loro comparsa fantasie messianiche o deliri - veniva torturato o castigato, perché era (o avrebbe potuto essere) il Messia, quello da noi tanto atteso. Lacerato tra beatitudine e tormento, tra fantasia e realtà, Michael sentiva di essere sul punto di impazzire (o forse sapeva di essere già impazzito) e non riusciva più a dormire o riposare, ma andava avanti e indietro per tutta la casa in preda all'agitazione, visitato dalle allucinazioni, pestando i piedi, con occhi furiosi, urlando.Io ero terrorizzato, da lui e per lui; terrorizzato dall'incubo che per lui stava diventando realtà, e a maggior ragione perché riconoscevo in me stesso pensieri e sentimenti simili, sebbene nascosti e chiusi nel profondo. Che cosa sarebbe successo a Michael? Sarebbe accaduto qualcosa di simile anche a me? Fu in quel periodo che allestii il mio laboratorio di chimica - e poi chiusi le porte, chiusi gli occhi, per proteggermi dalla follia di Michael. Fu in quel periodo che cercai (e a volte raggiunsi) un'intensa concentrazione, un completo assorbimento nel mondo della mineralogia, della chimica e della fisica, nella scienza - mi concentrai su di esse, tenendomi insieme nel caos. Non è che fossi indifferente a Michael; sentivo per lui una fortissima compassione, e un poco sapevo anche che cosa stesse attraversando; ma dovevo anche mantenere le distanze, crearmi un mondo mio ricavato dalla neutralità e dalla bellezza della natura, così da non essere scaraventato nel caos, nella follìa e nella seduzione del suo. | << | < | > | >> |Pagina 227La tavola periodica era incredibilmente bella, la cosa più bella che io avessi mai visto. Non potrei mai analizzare adeguatamente che cosa intendessi, qui, per bellezza: semplicità? coerenza? ritmo? inevitabilità? O era forse la simmetria, la completezza di ogni elemento, ben ancorato al suo posto, senza lacune, senza eccezioni, in un sistema in cui ciascun componente implicava tutti gli altri.Fui turbato quando un chimico di enorme erudizione, J.W. Mellor, nel cui vasto trattato di chimica inorganica avevo appena cominciato a immergermi, parlò della tavola periodica definendola «superficiale» e «illusoria» - non più vera, non più fondamentale di qualsiasi altra classificazione ad hoc. Questo mi gettò in un breve accesso di panico, e rese per me imperativa la necessità di capire se l'idea della periodicità fosse sostenuta in qualsiasi altro modo, al di là delle proprietà chimiche e della valenza. L'esplorazione di questo argomento mi distolse dal laboratorio, facendomi approdare a un nuovo libro che divenne immediatamente la mia bibbia, il CRC Handbook of Physics and Chemistry: un volume spesso, addirittura cubico, di quasi tremila pagine, contenente tavole relative a qualsiasi proprietà chimica e fisica immaginabile, molte delle quali, ossessivamente, mandai a memoria. Imparai le densità, i punti di fusione, i punti di ebollizione, gli indici di rifrazione, le solubilità e le forme cristalline di tutti gli elementi e di centinaia dei loro composti. Divenni bravissimo a rappresentare graficamente tutti quei parametri, a costruire diagrammi che mostrassero qualsiasi proprietà fisica mi venisse in mente, in funzione del peso atomico. Quanto più procedevo nell'esplorazione, tanto più mi entusiasmavo e mi animavo, giacché quasi tutto ciò che osservavo dava prova di periodicità: non solo la densità, il punto di fusione, il punto di ebollizione, ma anche la conducibilità elettrica e termica, la forma cristallina, la durezza, le variazioni di volume conseguenti alla fusione, l'espansione provocata dal calore, i potenziali di elettrodo, eccetera. Non era solo la valenza, quindi: si trattava anche delle proprietà fisiche. La potenza e l'universalità della tavola periodica uscivano amplificate, ai miei occhi, da queste conferme. Le tendenze che emergevano dalla tavola periodica ammettevano anche eccezioni e anomalie, alcune delle quali profonde. Perché, per esempio, il manganese era un pessimo conduttore di elettricità, quando invece gli elementi alla sua sinistra e alla sua destra nella tavola periodica erano discreti conduttori? Perché il forte magnetismo era confinato ai metalli del gruppo del ferro? Ciò nondimeno, ero in qualche modo convinto che queste eccezioni riflettessero ulteriori meccanismi particolari, e non invalidassero assolutamente il sistema generale. | << | < | > | >> |Pagina 306Il mondo organico, con tutta la sua complessità, stava entrando nella mia vita, mi stava trasformando, nelle roccaforti del mio stesso corpo. All'improvviso, cominciai a crescere rapidamente; iniziarono a spuntarmi peli sul volto, sotto le ascelle, intorno ai genitali; e la mia voce - ancora limpida e acuta quando cantavo l' haftorah - ora si rompeva, producendosi in erratici cambiamenti di tono. A scuola, nelle ore di biologia, sviluppai un improvviso, intenso interesse per la sessualità di piante e animali, in particolare quelli «inferiori», gli invertebrati e le gimnosperme. Trovavo affascinante la sessualità delle cicadi e dei ginkgo, quel loro conservare spermatozoi mobili, come le felci, pur sviluppando grossi semi ben protetti. E i cefalopodi, i calamari, erano ancor più interessanti: i maschi infilavano un braccio modificato, che portava le spermatofore, nella cavità del mantello della femmina. Ero ancora molto lontano dalla sessualità umana - dalla mia sessualità - ma la vedevo ormai come un argomento estremamente appassionante; a modo suo, era interessante come la valenza o la periodicità.Per quanto fossimo innamorati della biologia, non riuscivamo a essere monomaniacali come il signor Pask: eravamo soggetti ai richiami della giovinezza, dell'adolescenza; e in noi c'era l'energia di menti desiderose di esplorare in tutte le direzioni, non ancora pronte a vincolarsi. Per quattro anni, le mie inclinazioni erano state prevalentemente scientifiche; una passione per l'ordine e la bellezza formale mi aveva attirato verso la tavola periodica e gli atomi di Dalton. L'atomo quantistico di Bohr mi era parso una cosa celestiale, quasi che fosse stato creato così perfetto in previsione di una durata eterna. A volte provavo una sorta di estasi di fronte all'ordine razionale, alla formale armonia dell'Universo. Ora, con l'affermarsi di altri interessi, avvertivo anche il sentimento opposto, una sorta di vuoto o di aridità interiore, perché ormai la bellezza e l'amore per la scienza non mi bastavano, ed ero affamato di ciò che era umano, personale. | << | < | > | >> |Pagina 344Non fu una cosa improvvisa - non è che una mattina io mi fossi svegliato e avessi scoperto che la chimica, per me, era morta; fu una cosa graduale, che scese su di me un poco alla volta, e da principio, credo, inavvertitamente. A un certo momento, quando avevo quattordici anni, mi resi conto che non mi svegliavo più in preda ai miei entusiasmi improvvisi - «Oggi vado a comprare la soluzione di Clerici!, e poi mi voglio leggere tutto su Humphry Davy e i pesci elettrici ... Finalmente capirò il diamagnetismo, speriamo!». Sembrava che non avessi più queste illuminazioni improvvise, queste epifanie, quegli eccitamenti definiti da Flaubert (che ora stavo leggendo) «erezioni della mente». Erezioni del corpo, quelle sì - erano una componente nuova e stravagante della mia vita; ma quelle improvvise estasi della mente, quegli improvvisi paesaggi di beatitudine e illuminazione, sembravano avermi lasciato, abbandonato. O ero stato io ad abbandonare loro? In effetti, non andavo più nel mio piccolo laboratorio; me ne resi conto solo quando un giorno, girando per casa, scesi giù e trovai tutto coperto da un leggero strato di polvere. Erano mesi che quasi non vedevo zio Abe e zio Dave, e avevo smesso di portarmi dietro lo spettroscopio da tasca.C'erano state volte in cui mi ero seduto nella Science Library, rimanendo incantato per ore, completamente dimentico del trascorrere del tempo. Altre volte mi era parso di vedere le linee di forza, o gli elettroni danzare e librarsi nei loro orbitali; ma ora anche questo potere quasi allucinatorio se n'era andato. Ero meno sognatore, più concentrato, dicevano le mie pagelle: probabilmente era quella l'impressione che davo; ciò che provavo io, però, era completamente diverso; sentivo che tutto un mondo interiore era morto, mi era stato portato via.
Pensavo spesso al racconto di Wells della porta
nella parete, al giardino incantato in cui il bambino
viene ammesso, e dal quale è poi esiliato o espulso.
Al principio egli non si accorge di aver perso qualcosa,
sottoposto com'è alle pressioni della vita e del
mondo esterno, ma successivamente questa consapevolezza
comincia a montare in lui consumandolo e portandolo infine
alla distruzione. Boyle aveva chiamato il suo laboratorio
«Elisio», Hertz aveva parlato della fisica come di «un paese
incantato di fate». Ora sentivo di essere fuori da
quell'Elisio, sentivo che le porte del paese delle fate
s'erano chiuse, che ero stato espulso dal giardino dei
numeri, dal giardino di Mendeleev, dai magici domini del
gioco ai quali avevo avuto accesso una volta.
Con la «nuova» meccanica quantistica, sviluppata a metà degli anni Venti, non era più possibile considerare gli elettroni come piccole particelle orbitanti, adesso andavano concepiti come onde; non si poteva più parlare della posizione di un elettrone, ma solo della sua funzione d'onda, ossia della probabilità che esso si trovasse in un dato punto. Non se ne potevano misurare posizione e velocità simultaneamente. Sembrava, in un certo senso, che un elettrone potesse trovarsi ovunque e in nessun luogo. Tutto questo fece vacillare la mia mente. Avevo sempre guardato alla chimica, alla scienza, come a una fonte da cui ricavare ordine e certezze e ora, improvvisamente, tutto questo svaniva. Era una situazione scioccante; e ormai avevo superato i miei zii. Ero andato oltre, e mi trovavo da solo, in acque profonde. La nuova meccanica quantistica prometteva di spiegare tutta la chimica. E sebbene io provassi entusiasmo per questo, vi percepivo anche una certa minaccia. «La chimica» scriveva Crookes «sarà fondata su basi interamente nuove... Non avremo più bisogno di compiere esperimenti, giacché sapremo a priori quale sarà, inevitabilmente, il risultato di ciascuno di essi». Non ero sicuro che tutto questo mi piacesse. Significava, forse, che i chimici del futuro (sempre che fossero esistiti) non avrebbero più dovuto maneggiare un reagente? Che non avrebbero mai visto i colori dei sali di vanadio, mai annusato un seleniuro di idrogeno né ammirato la forma di un cristallo? Che potessero vivere in un mondo matematico senza colori e senza odori? Mi sembrava una prospettiva terribile perché, almeno per quanto mi riguardava, io avevo bisogno di odorare, toccare e sentire, avevo bisogno di collocare me stesso, i miei sensi, al centro del mondo percettivo.
Avevo sognato di diventare un chimico, ma la chimica che
mi emozionava veramente era quella descrittiva,
naturalistica, diligentemente dettagliata, del
diciannovesimo secolo, non la nuova chimica dell'era
quantistica. La chimica che conoscevo e che amavo era
finita, o stava cambiando natura, lasciandomi indietro (o
comunque, così mi pareva). Sentivo di essere arrivato alla
fine del cammino, quanto meno del mio, e di aver spinto il
mio viaggio nella chimica il più lontano possibile.
|