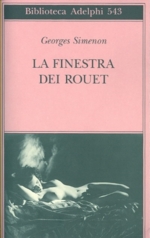
|
|
|
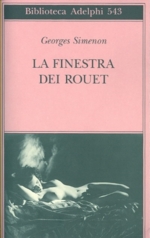
|
|
|
| << | < | > | >> |Pagina 13Da dietro la parete giunse il suono invadente e volgare di una sveglia, e Dominique sobbalzò come se la suoneria – ma che aspettavano a farla smettere! – dovesse svegliare lei, alle tre del pomeriggio. Provò un senso di vergogna. Perché? Quel rumore sgraziato le suscitava solo ricordi dolorosi, spiacevoli, malattie, incombenze che la costringevano ad alzarsi nel cuore della notte o all'alba, ma lei non stava dormendo, non si era nemmeno assopita. Neanche per un momento la sua mano aveva smesso di cucire; a dire il vero, un attimo prima era come un cavallo da circo che, lasciato da solo a eseguire un esercizio, ha continuato a girare in tondo e, sentendo la voce di un intruso, ha un sussulto e si ferma di botto. Nella stanza a fianco, dietro la porta scura, proprio vicino a lei, come possono sopportare quel frastuono insolente? Basterebbe allungare il braccio, senza aprire gli occhi, raggiungere a tentoni l'apparecchio che vibra su un tavolino, ma non lo fanno, non si muovono, sono nudi, ne è sicura, carne contro carne, avvinghiati, con la pelle luccicante di sudore, i capelli incollati alle tempie; si crogiolano in quel calore, in quell'odore di bestia umana; si intuisce che qualcuno si muove, si stiracchia, sbatte palpebre; una voce assonnata, quella della donna, farfuglia, forse cercando, con gesto abituale, il corpo dell'uomo accanto al suo: «Albert... ». Le dita di Dominique non si sono fermate. Ha la testa china sull'abito che sta rammendando sotto la manica, nel punto in cui si consumano tutti i suoi vestiti, soprattutto d'estate, perché suda. Cuce da due ore, a piccolissimi punti, per ricostruire la trama fine di quel tessuto bianco dai disegni viola e, ora che la sveglia degli inquilini l'ha fatta sussultare, non saprebbe dire a che cosa abbia pensato in quelle due ore. Fa caldo. L'aria non è mai stata così pesante. Di pomeriggio il sole batte in pieno su questo lato di faubourg Saint-Honoré. Dominique ha accostato le persiane lasciando una fessura verticale di qualche centimetro da cui può guardare le case di fronte; ai due lati di quell'apertura, che lascia filtrare un sole cocente, tra le stecche di legno brillano le fessure orizzontali, più sottili. Quel disegno luminoso, da cui si diffonde un calore intenso, finisce per restarle impresso negli occhi, nella testa e, se a un tratto si volge altrove, lo proietta insieme allo sguardo, lo trasferisce sulla porta scura, sul muro, sul pavimento. Ogni due minuti passano degli autobus. Li sente irrompere, enormi, dal fondo della strada: hanno un che di malevolo nella loro brutalità, soprattutto quelli diretti verso place des Ternes, che di colpo, davanti al palazzo, dove si accentua la pendenza, cambiano rumorosamente marcia. Dominique ci ha fatto l'abitudine, ma è come per le lame di luce, li percepisce suo malgrado e il rumore le penetra nella testa lasciandovi l'eco di un ronzio. La sveglia, nella stanza accanto, ha smesso di suonare, eppure a lei sembra di sentirla ancora. Forse perché l'aria è così densa da conservare le tracce dei suoni proprio come il fango conserva le impronte dei passi. Dominique non può vedere il pianterreno delle case di fronte. Lo vede solo quando si alza. E tuttavia certe immagini ce le ha davanti agli occhi: la facciata giallo limone della latteria, con il nome, Audebal, in verde sopra la vetrina, la frutta, la verdura, le ceste sul marciapiede; e di tanto in tanto, in mezzo al frastuono della città – il fischietto del vigile all'incrocio con boulevard Haussmann, i clacson dei taxi, le campane di Saint-Philippe-du-Roule –, giunge fino a lei, distinto dagli altri, un suono familiare quasi impercettibile: il fievole campanello della porta della latteria. Ha caldo, sebbene sia quasi nuda. È la prima volta in vita sua che fa una cosa del genere. Si è tolta il vestito per rammendarlo e non ne ha infilato un altro. È rimasta in sottoveste, è turbata, se ne vergogna un po'; almeno un paio di volte è stata sul punto di alzarsi per mettersi addosso qualcosa, soprattutto quando le cade lo sguardo sul suo corpo, quando sente tremare il seno, che intravede bianchissimo, delicato, nella scollatura della sottoveste. Prova un'altra sensazione strana, quasi erotica, quella delle gocce di sudore che, a intervalli più o meno regolari, si aprono un passaggio attraverso la pelle. Ogni volta le sembra che ci voglia un tempo infinito. È colta da un moto di impazienza, ma alla fine la goccia tiepida sgorga dall'ascella e cola giù lenta. «Non ora, Albert... ». Una voce da bambina, nella camera accanto. Lina non ha ancora ventidue anni. È una grossa bambola morbida, dai capelli fulvi, e dalla pelle bianca che qua e là tende a chiazzarsi di rosso; anche la voce è morbida, impastata di felicità animale, e Dominique arrossisce, spezza il filo con il gesto brusco delle sarte; non vorrebbe sentire più niente; sa come andrà a finire, non si può sbagliare: un fruscio già preannuncia il brano che ascoltano al grammofono ogni volta che lo fanno. E non hanno nemmeno chiuso le persiane. Credono di essere al riparo dagli sguardi indiscreti perché il letto si trova in fondo alla stanza, dove il sole non arriva, e anche perché nel mese di agosto la maggior parte degli appartamenti di fronte è vuota; ma lei, Dominique, sa bene che lassù, da una delle mansarde, la vecchia Augustine li sta guardando. Alle tre del pomeriggio! Dormono quando capita, vivono come capita, e non appena tornano a casa si spogliano; non si vergognano di stare nudi, anzi ne sono fieri, mentre Dominique non osa più passare per il salotto comune, il salotto che non ha voluto dare in affitto, ma che loro devono attraversare per andare al gabinetto. Due volte ha incontrato Albert praticamente nudo, con un asciugamano legato in vita alla meno peggio. Ascoltano sempre lo stesso brano, un tango che devono aver sentito in un'occasione memorabile; ma c'è di peggio, un particolare che rende ancora più tangibile la loro presenza, tanto che sembra quasi di vederli muoversi: quando il disco è finito, e si sente solo il fruscio della puntina, c'è come un attimo di esitazione che dura più o meno a lungo, un silenzio terribile, ed è quasi sempre la voce di Lina a balbettare: «Il disco... ». Il grammofono si trova proprio a fianco al letto; dai sussurri e dalle risatine si intuiscono i movimenti che l'uomo fa per arrivarci... La ama. La ama come una bestia. Passa la vita ad amarla e lo farebbe davanti a tutti; fra poco, quando usciranno, sentiranno ancora il bisogno, per strada, di stringersi l'uno all'altro. Il vestito è a posto. Ha un aspetto ancora più povero, adesso, proprio per quel rammendo così preciso, quei punti così piccoli. I1 tessuto è liso a forza di essere lavato e stirato. Da quanto tempo ce l'ha? Il viola è per il mezzo lutto. Quindi dal secondo anno dopo la morte di suo padre. É la quarta estate che lo porta, che lo lava la mattina alle sei per averlo ben asciutto e stirato all'ora di uscire per la spesa. Alza la testa: la vecchia Augustíne è sempre di vedetta, affacciata alla finestra della mansarda, sdegnata, con lo sguardo fisso sulla stanza accanto, e Dominìque, visto che ormai è in piedi, è tentata per un momento di fare qualche passo e di chinarsi a guardare dal buco della serratura. L'ha già fatto altre volte. Le tre e dieci. Fra poco si rimetterà il vestito e ricomincerà a rammendare le calze ammucchiate nella cesta di vimini, una cesta che era già di sua nonna e ha sempre contenuto calze da rammendare, tanto da far pensare che siano sempre le stesse, e che si potrebbe andare avanti a rammendare fino alla fine dei secoli senza mai riuscire a svuotarla. | << | < | > | >> |Pagina 64Camminava in fretta, come se fosse inseguita, o meglio, più si avvicinava a casa, più il suo passo diventava precipitoso, irregolare; era in uno stato di agitazione, come un nuotatore che a un tratto si rende conto della propria imprudenza e nuota disperatamente verso riva finché non tocca. Le succedeva proprio così. Cominciava già a sentirsi in salvo nell'androne, dove era accolta dalla particolare sonorità di quel palazzetto signorile, poi diviso in appartamenti; le suole delle sue scarpe ritrovavano la superficie ruvida delle piastrelle giallastre e sconnesse; Dominique si vedeva riflessa, minuscola e deformata, nel pomello di ottone alla base delle scale e provava una soddisfazione fisica nel far scivolare la mano sulla ringhiera lucida; più su, sempre allo stesso scalino, si fermava un attimo per cercare la chiave nella borsa e in quel momento, ogni volta, provava una breve angoscia, perché non riusciva a trovarla subito e, con un'apprensione non del tutto sincera, si chiedeva se non l'avesse persa. Finalmente a casa. Nel salotto no, non ancora, solo in camera da letto, in quell'unico ambiente in cui si era confinata e che talvolta avrebbe voluto ancora più piccolo per poterlo meglio impregnare di sé. Chiuse la porta a chiave e si fermò, sfinita, senza fiato, nel punto in cui si fermava sempre, davanti allo specchio, cercandovi, ad accoglierla, la propria immagine. Provava per sé, per Dominique, per quella che un tempo chiamavano Nique – ma ormai chi l'avrebbe più chiamata così, se non lei stessa? –, una pietà immensa, e le faceva bene guardarsi in quello specchio che aveva seguito i Salès in tutte le città dove suo padre era stato di guarnigione e che l'aveva vista bambina. No, non era ancora una vecchia zitella. Non aveva rughe sul viso. Benché vivesse chiusa in casa, la sua pelle era rimasta fresca. Non era mai stata molto colorita, ma aveva una pelle straordinariamente fine; le tornava in mente la voce di sua madre che diceva con un tono dolcissimo: «Nique ha la pelle dei Le Bret, ma il portamento della nonna Chaillou». Era rassicurante uscire dalla calca brutale della strada, dove la gente ostentava senza ritegno la propria vitalità, per ritrovare, come divinità familiari, certi nomi che non erano semplici nomi, ma le tracce viventi di un mondo a cui lei apparteneva e che venerava. Le sillabe che li componevano avevano un colore, un profumo, un significato mistico. Quasi tutti, nella stanza in cui Dominique, con ancora in bocca il polveroso, anonimo sapore della strada, si riappropriava di se stessa, erano rappresentati da un oggetto. Per esempio, in quella camera non c'erano sveglie né orologi a muro, ma un orologetto d'oro, messo sulla testata del letto, con la cassa decorata da un fiore di perle e schegge di rubino: era l'orologio della nonna Chaillou, le ricordava una grande casa di campagna nei dintorni di Rennes, che tutti chiamavano il castello. «L'anno in cui fummo costretti vendere il castello...». L'astuccio dell'orologio era una pantofola di seta rossa con ricami verdi, azzurri e gialli, ricami che la stessa Nique aveva fatto a sette o otto anni, quando era in collegio dalle suore dell'Ascensione. Accese il gas, stese giusto un tovagliolo a un capo del tavolo. Nella maggior parte degli appartamenti della strada probabilmente stavano cenando, almeno in quelli i cui abitanti non erano andati in vacanza, ma nelle stanze di Antoinette Rouet non si vedeva nessuno. Per liberarsi dall'ossessione di Antoinette, a cui tornava costantemente con il pensiero, Dominique aveva voglia di fare quel gioco, di giocare a pensare, come diceva un tempo e come, quasi inconsapevolmente, continuava a dire. Quel gioco richiedeva una particolare disposizione d'animo, uno stato dì grazia. Di mattina, per esempio, mentre sbrigava le faccende di casa, era impossibile farlo. Così come era impossibile cominciare di punto in bianco. Era una specie di sogno a occhi aperti, e non si sogna a comando, al massimo si può tentare di calarsi gradualmente in una condizione di spirito favorevole. La parola Chaillou era perfetta per cominciare, una parola chiave, ma ce n'erano altre, per esempio zia Clémentine... Zia Clémentine evocava immediatamente il mattino verso le undici, quando l'aria fresca delle prime ore lasciava il posto al sole più opprimente del mezzogiorno, quando si cominciava ad avvertire l'odore della propria pelle... Una villa a La Seyne, vicino a Tolone... Il marito di zia Clémentine — leì era una Le Bret e aveva sposato uno Chabiron - era ingegnere all'arsenale di Tolone... Dominique era in vacanza da loro per un mese; leggeva in un giardino fiorito di mimose; sentiva l'ansimare delle macchine dei cantieri navali sotto un sole rovente; le bastava sollevarsi un po' per vedere, attraverso un groviglio di gru e di carroponti, uno scorcio di mare di un azzurro intenso; un'immagine stagnante, tanto da formare un insieme così compatto che a mezzogiorno era un sollievo udire il fischio lacerante delle sirene delle fabbriche, cui rispondevano quelle delle navi in rada e, subito dopo, i passi degli operai e delle operaie che attraversavano il passaggio a livello. Zia Clémentine era ancora viva. Suo marito invece era morto da tempo. Lei viveva sempre in quella villa, sola con una vecchia cameriera. Mentalmente, Dominique rimetteva ogni cosa al suo posto, perfino il gatto rosso che di sicuro era morto, ormai; ricreava ogni angolo della casa... Di colpo, poiché aveva fatto quel gioco quando vegliava suo padre malato, trasalì credendo di udire il noto sospiro proveniente dal letto; si stupì di non trovarlo al suo posto, di non vedere il volto ispido dell'ex generale, con quello sguardo sempre carico di un freddo rimprovero. «Allora? La mia pipa?». Fumava a letto, non si rasava più, a malapena si lavava la faccia. Sembrava che lo facesse apposta a essere sporco, a diventare una creatura ripugnante, e arrivava anche a dire, con soddisfazione diabolica: «Comincio a puzzare! Dillo che puzzo! E dillo, visto che è vero! Puzzo, Dio santo!». Nella camera da letto di suo padre in quel momento stavano rientrando i Caille. Dominique non aveva più bisogno di giocare con l'immaginazione, di cercare qualcosa su cui fantasticare. Nell'appartamento di fronte c'erano Antoinette e i suoi suoceri, e lì accanto a lei, separati solo da una porta, quei due giovani che se ne tornavano a casa con la valigia vuota. Che facevano? Cos'era quel trambusto per lei nuovo? Non era la loro solita ora. Avevano avuto appena il tempo di cenare. Perché non andavano al cinema o a teatro o in qualche locale da ballo dove suonavano quei motivetti che Dominique li sentiva canticchiare la mattina? Stavano riempiendo un secchio. Il rubinetto era aperto al massimo. Erano capaci di dimenticarsene e di allagare il pavimento. Con quei due, che non avevano nessun rispetto per le cose, Dominique aveva sempre paura di un disastro. Per loro un oggetto, qualunque esso sia, si può sostituire. Si paga quello che si deve e basta. Mentre lei non si dava pace neanche per una macchia su un tappetino o su una tenda! Parlavano, ma facevano troppo rumore spostando le cose perché lei potesse afferrare le parole. Augustine era alla finestra. Aveva cominciato il suo turno di guardia, perché di questo si trattava: appena finiva di mangiare, andava ad affacciarsi alla finestra della mansarda, appoggiandosi con tutto il suo peso al davanzale; indossava una camicetta nera a disegnini bianchi; l'ombra violetta della sera faceva risaltare il candore dei suoi capelli; se ne stava lì, placida, dominando la strada e i tetti. Solo molto più tardi altre finestre qua e là si popolavano di gente che, a fine giornata, veniva a cercare un po' di fresco. | << | < | > | >> |Pagina 81A che le servirebbe invocare in aiuto i fantasmi del passato, che per lei sono ormai come santi di cui si dubita, in cui già non si crede più e ai quali tuttavia si chiede segretamente perdono? L'aria è fluida, gli oggetti stanno al proprio posto, con i loro colori, la loro densità, i loro riflessi, la loro rassicurante umiltà; sono tutti a portata di mano di Dominique che ha voluto limitare il suo universo alle quattro mura di una stanza. È l'ora in cui anche il mondo visibile nel rettangolo azzurrino della finestra, quel grande spazio di frescura mattutina dove riecheggia ogni minimo rumore, pare appartenere a lei, perché la vecchia Augustine non si è ancora alzata. Dominique è pallida. Ha i lineamenti tirati. Né l'acqua fredda né il sapone sono riusciti a cancellare le tracce delle brutte ore passate nel letto umidiccio che poco fa, alle cinque del mattino, quando nella strada risuonavano i primi passi, ha già ripreso, sotto la severa trapunta, l'aspetto inoffensivo di un oggetto da esposizione. Per anni, per tutta la vita, Dominique si è rifatta il letto appena alzata, affrettandosi, senza sapere esattamente perché, a cancellare tutto ciò che poteva ricordare la vita notturna. Solo stamattina – si è svegliata con un accenno di mal di testa e le tempie che pulsavano —, solo stamattina è rimasta colpita da quella sua mania; ha cercato con lo sguardo un altro oggetto rituale: la cesta di vimini con le calze da rammendare e il grosso uovo di legno verniciato. Per un attimo è stata avvolta da un'aria più morbida, quasi dolce, e ha sentito la presenza di sua madre; forse con uno sforzo sarebbe riuscita a vederne il viso allungato come quello delle Madonne delle immaginette, il sorriso che si sprigionava dalla sua persona senza informare questo o quel tratto in particolare, la mano che, appena si sentiva suonare alla porta, afferrava la cesta delle calze per nasconderla in un armadio. «Non bisogna far vedere agli altri le proprie calze bucate». Non bisogna far vedere neppure delle cose informi come le calze arrotolate, che evocano situazioni troppo intime; mai, durante il giorno, una porta socchiusa avrebbe lasciato vedere un angolo di letto o il marmo di un lavandino livido come un corpo nudo. Per quanto scavasse nella memoria, Dominique non trovava un solo ricordo di sua madre in vestaglia, in sottoveste o semplicemente con i capelli in disordine. Le tornava in mente una frase e solo ora, a quarant'anni, si rendeva conto che quella frase in apparenza tanto semplice aveva condizionato tutta la sua esistenza. Dove era stata pronunciata? Dominique aveva una certa difficoltà a raccapezzarsi tra le case in cui aveva vissuto, perché l'atmosfera era dovunque la stessa; le case dei Salès si assomigliavano come si assomigliano gli alberghi di una certa categoria: grandi case luminose – stranamente in tutte, o quasi, c'era un balcone —, alberi nelle vicinanze, una piazza o un viale, quartieri abitati da medici, da avvocati, e l'eco della tromba di una caserma poco lontana. Era andato a trovarli uno zio che vedevano di rado. In salotto si erano riunite alcune persone. Dominique aveva forse quattordici anni. Non l'avevano ancora mandata a letto. Parlavano dei cani e del loro istinto. «Distinguono le persone unicamente dall'odore. Conosco una vecchia signora cieca che, appena qualcuno le passa davanti, si mette ad annusare l'aria e subito dopo fa un nome, senza mai sbagliarsi...». La signora Salès aveva avuto quel sorriso forzato, quell'impercettibile movimento della testa che le veniva spontaneo quando qualcosa la contrariava. Forse immaginava già la domanda di Dominique: «Mamma, è vero che le persone hanno un odore?». «No, tesoro. Zio Charles non sa quello che dice. Solo le persone che non si lavano hanno un odore...». A che le servirebbe invocare l'ombra dolce e malinconica di quella madre, mentre spia le finestre chiuse dietro le quali Antoinette Rouet si abbandona al sonno con voluttà? Tutti i fantasmi di Dominique sono della stessa specie, come tutte le parole che riaffiorano dal fondo della sua memoria. «I Cottron sono andati a fare una cura a La Bourboule...». Non si dice il nome della malattia, non si evoca il corpo malato. «La cara signora Ralet ha avuto un bambino...». La parola partorire, che suggerirebbe un'immagine più precisa, non viene proferita; tutto si svolge in un universo ovattato, in cui gli esseri umani appaiono sempre lavati, pettinati, sorridenti o malinconici. Perfino i nomi propri sono dei feticci; non vengono pronunciati come parole qualsiasi, come i nomi della gente comune; hanno una loro nobiltà; sono solo una decina, non di più, a essere ammessi in questo vocabolario che riunisce la famiglia di Brest, la famiglia di Tolone, il tenente colonnello e l'ingegnere navale, i Babarit, che si sono imparentati con i Lepreau e sono entrati così nella sacra cerchia, in quanto cugini di secondo grado dei Le Bret. Eppure quelle famiglie - Dominique ci pensa solo oggi - non erano ricche. Generalmente possedevano un piccolo patrimonio. «Quando Aurélie erediterà dalla zia Chaillou...». I Rouet, per esempio, con tutti i loro milioni, non avrebbero avuto accesso alla cerchia fatata: non vi era ammesso nulla di brutale o volgare, nulla di troppo diretto, nulla che sapesse di vita quotidiana. Tanto è vero che, fino a dieci giorni prima, Dominique spiava la gente della casa di fronte con una curiosità piena di disprezzo. Si interessava a loro solo perché aveva quelle finestre sotto gli occhi dalla mattina alla sera, come si interessava alla vecchia Augustine, alla donna con il bambino malato e perfino - e Dio solo sa se non c'era un abisso a separarli - a quegli ignobili Audebal. Ma in realtà le erano indifferenti, privi di mistero. Gente volgare che aveva fatto fortuna nel settore della trafilatura - il vecchio Rouet aveva fondato una delle più importanti trafilerie di rame - e che continuava a vivere come era abituata.
Che una donna come Antoinette fosse entrata in
quella casa non era difficile da capire: un ragazzo di
quarant'anni, debole di costituzione e di carattere,
era stato sedotto da una dattilografa, da una bella
ragazza che ci sapeva fare.
|