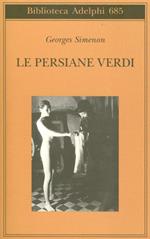
|
|
|
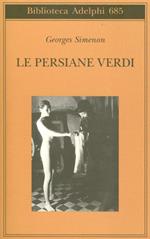
|
|
|
| << | < | > | >> |Pagina 15Era strano: il buio che lo circondava non era il buio immobile, immateriale, negativo, a cui siamo abituati. Gli ricordava piuttosto il buio quasi palpabile di certi incubi della sua infanzia, un buio minaccioso, che a volte di notte lo assaliva a ondate come a volerlo soffocare. «Può rilassarsi ora». Ma non poteva ancora muoversi. Solo respirare, il che era già un sollievo. Stava con la schiena appoggiata a una parete liscia, di cui non avrebbe saputo specificare la materia, e contro il petto nudo sentiva il peso dello schermo, che, con il suo chiarore, gli permetteva di intravedere la faccia del medico. Chissà, forse proprio per via di quella luminescenza il buio nel quale erano immersi sembrava fatto di una nebbia molle e avvolgente. Perché il dottore lo costringeva a restare così a lungo in quella posizione scomoda senza dirgli una parola? Poco prima, sul lettino di pelle nera dello studio, Maugin si sentiva ancora tranquillo, parlava con la sua vera voce, quel vocione burbero che aveva sulla scena e nella vita, e osservava divertito Biguet, il famoso Biguet, che aveva curato e curava tanti personaggi illustri. Era un uomo simile a lui, pressappoco della stessa età, come lui venuto dal niente, un campagnolo, figlio di una donna che un tempo faceva la serva in una fattoria del Massiccio Centrale. Non aveva la voce di Maugin, né la sua statura, la sua stazza e il suo faccione quadrato, ma, tracagnotto e irsuto com'era, conservava le tracce delle sue origini contadine e del suo dialetto. «Riesce a restare immobile in questa posizione per qualche minuto?». Maugin dovette tossire per schiarirsi la gola prima di rispondere di sì. Benché fosse seminudo e a contatto con lo schermo freddo, aveva la pelle coperta di gocce di sudore. «Fuma molto?». Ebbe la sensazione che il professore gli facesse quella domanda senza un vero motivo, senza convinzione, solo per metterlo a suo agio, e si chiese se stesse per fargliene un'altra, più importante, quella che stava aspettando fin dall'inizio della visita. Non era un appuntamento qualsiasi. Erano le sette di sera, e la segretaria del dottore era andata via da tempo. Maugin conosceva già Biguet: lo aveva incontrato due o tre volte in occasione di una prima o a qualche ricevimento. Da mesi pensava di telefonargli e quel pomeriggio, tutt'a un tratto, si era deciso. «Le dispiacerebbe dare un'occhiata al mio cuore?». «Sta lavorando in teatro in questo periodo, giusto?». «Sì, ogni sera, tranne il sabato e la domenica che ho la diurna». «E sta anche girando un film?». «Ho le riprese tutti i giorni al teatro di posa delle Buttes-Chaumont». «Riuscirebbe a passare da me tra le sei e mezzo e le sette?». Come al solito si era fatto accompagnare con la macchina della casa di produzione. Non aveva mai imparato a guidare, per cui faceva inserire in tutti i contratti quella clausola, che gli permetteva di risparmiare le spese di auto e autista. «Al Fouquet's, signor …mile?». Le persone che avevano spesso a che fare con lui ritenevano più opportuno chiamarlo signor …mile, come se il suo cognome, Maugin, fosse troppo altisonante per le loro bocche. E anche alcuni che lo avevano incontrato sì e no un paio di volte, appena sentivano parlare di lui, esclamavano: «Ah, sì, …mile!». Aveva risposto di no. Pioveva. Sprofondato nel sedile imbottito della macchina, osservava con uno sguardo spento le strade bagnate, le luci deformate dal finestrino, le vetrine dei negozi, dapprima quelle povere e squallide dei quartieri popolari - latterie, panifici, botteghe di alimentari e bistrot, soprattutto bistrot -, poi quelle più sfavillanti del centro. «Lasciami all'incrocio tra boulevard Haussmann e me de Courcelles». Neanche a farlo apposta, mentre attraversavano place Saint-Augustin, aveva cominciato a piovere così forte, con gocce così grosse, che il selciato pareva la superficie di un lago. Allora era stato tentato di dire all'autista di fermare la macchina davanti al palazzo del professore: sarebbe stato così semplice. Ma sapeva che non lo avrebbe fatto. Benché alle sei avesse bevuto due bicchieri di rosso nel suo camerino del teatro di posa, il malessere cominciava già a farsi sentire: un senso di vertigine, un'angoscia che gli serrava il petto, come un tempo quando aveva fame. «Scende qui?». L'autista era sorpreso. Lì all'angolo c'era soltanto una sartoria con le imposte chiuse. Ma, poco più avanti, in rue de Courcelles, Maugin scorgeva l'insegna male illuminata di un piccolo bistrot. Per non farsi vedere da Alfred, aveva aspettato qualche istante all'incrocio, in piedi, enorme, mentre l'acqua gli riempiva la falda del cappello e iniziava a gocciolargli sulle spalle. La macchina era ripartita, ma si era fermata quasi subito, proprio di fronte al bistrot, e Alfred vi si era precipitato, a testa bassa e con le spalle curve. Forse aveva sete anche lui o magari aveva finito le sigarette. Nell'aprire la porta si era girato un momento a guardare Maugin, che per darsi un contegno si era incamminato verso il primo portone, come se fosse diretto lì, ma dopo averlo varcato era rimasto acquattato al buio in attesa che la macchina si allontanasse. Solo allora era entrato nel locale, dove di colpo era piombato il silenzio e tutti, ammutoliti, avevano guardato il grande Maugin che, scuro in volto, borbottava con voce roca: «Un bicchiere di rosso!». «Un bordeaux, signor Maugin?». «Ho detto un bicchiere di rosso. Non avete un vino rosso della casa?». Ne aveva bevuti due. Ne beveva sempre due, l'uno dopo l'altro, tutti d'un fiato, e si era dovuto sbottonare il cappotto per prendere i soldi in tasca. Chissà se mentre lo auscultava il dottor Biguet aveva sentito il suo alito! E chissà se anche lui gli avrebbe rivolto la solita domanda! Si rendeva conto che il fatto di stare lì, con il torace schiacciato fra due superfici rigide, cieco per via del buio, poneva Maugin in una condizione di inferiorità? Probabilmente Biguet ci era abituato. In fondo gli altri suoi pazienti, il presidente del Consiglio, i grandi capitani d'industria, gli accademici di Francia, i politici e i principi stranieri che andavano apposta a Parigi per consultarlo non erano certo di minor calibro. «Respiri normalmente senza sforzarsi. Cerchi di non muoversi, soprattutto il petto». | << | < | > | >> |Pagina 44A Maugin pareva di sentire la voce di Juliette che spiegava al ragazzo:«Vedi, quell'uomo è tuo padre. Non è sempre stato ricco e famoso. C'è stato un tempo in cui, non avendo dove andare, si intrufolava ogni sera nella mia stanza come un ladro». Per una settimana, a voler essere precisi. Era vero. «Ero giovane, ingenua e pura...». Era vergine, era vero anche quello, e il suo corpo aveva già un sentore di zitella o di vedova. L'aveva conosciuta sull'imperiale di un omnibus, ai tempi in cui a Parigi c'erano ancora gli omnibus. Quel giorno Maugin portava un vestito a quadretti, un paio di scarpe gialle a punta e una paglietta. Chissà se lei aveva conservato la foto che si erano fatti al luna park di Montmartre! In quel periodo lui cantava in un caffè-concerto in boulevard Rochechouart, dove lo pagavano con birre e panini. Lei invece lavorava da una sarta, in rue Notre-Dame-de-Lorette, e condivideva la stanza con un'amica. «Manda via la tua amica!». Era due volte più alto e più grosso di lei, che per strada gli si aggrappava al braccio con aria languida, imitando le cartoline dell'epoca. Maugin ricordava benissimo la stanza, che si trovava in una specie di pensione familiare: doveva entrare senza farsi vedere e, se non usciva entro le sei del mattino, era costretto a passarci l'intera giornata evitando il minimo rumore. Per fortuna un impresario stava reclutando artisti per una tournée nei Balcani, il genere di tournée che si pianta in asso dopo qualche settimana o qualche mese portandosi via la cassa. Se n'era andato senza dire niente, risparmiandosi gli addii e le lacrime. Quando era tornato, due anni dopo, il suo nome sui cartelloni - scritto per ultimo in caratteri minuscoli - era Alain de Breuille. Gli ci era voluto un bel po' di tempo - e di faccia tosta e di tenacia - per diventare dapprima …mile Maugin e poi semplicemente Maugin, e un bel po' di tempo anche per veder comparire, davanti alla porta del suo camerino in un teatro della zona di place des Ternes, una donnina di quarant'anni vestita a lutto. Lui di anni ne aveva quarantatré e nel frattempo era diventato il primo attore della compagnia. «Non mi riconosce, signor Maugin?». No, non la riconosceva affatto e si accingeva già ad autografarle il programma. «Juliette!» aveva detto allora lei con un sorriso commosso. «Juliette, va bene, sì. E quindi? Mi dica, signora». «Rue Notre-Dame-de-Lorette!». «Sì...». «La pensione della signora Vacher!». Era riuscito giusto in tempo a trattenersi dall'esclamare: «Merda!», perché nell'udire quel nome aveva finalmente avuto l'illuminazione. «Non si preoccupi, signor Maugin. Non sono venuta per me. Ho sofferto molto, ma immagino quanto debba essere complicata la vita di un artista». Aveva sofferto talmente per quella delusione d'amore che, due anni dopo la sua partenza, si era sposata con un certo Cadot, un tale che aveva un buon impiego nella pubblica amministrazione con la pensione assicurata. «L'ho fatto per il bambino, capisce? Cadot è stato generoso. Si è subito offerto di riconoscerlo e di dargli il suo nome». Parlava del figlio come se fosse appena nato, mentre era già un ragazzo di diciotto anni che, diceva lei, era stato di recente assunto in banca e di cui i superiori si mostravano più che soddisfatti. «Vorrei tanto che lei lo incontrasse! » il suo ritratto vivente!». Come se lui, l'originale, fosse morto! Il giorno dopo era seduta in prima fila con il giovanotto accanto e nell'intervallo era andata a presentarglielo. Cadot era morto, lasciando alla moglie la famosa pensione. «Il signor Maugin è un amico d'infanzia, …mile. Non è così, signor Maugin? Non meravigliarti se qualche volta mi capita di dimenticare che adesso è un uomo importante e di chiamarlo …mile. Mi ha conosciuta quando ero ancora una bambina». Che troia! «Sono certa che si interesserà di te e che farà il possibile per aiutarti nella vita». E quel deficiente aveva attaccato con la lezioncina: «Le sono molto grato, signor Maugin, e da parte mia farò in modo di meritare tanta benevolenza». Per prima cosa gli aveva comprato un orologio, perché, sempre secondo la madre, il ragazzo aveva una tale paura di essere in ritardo in ufficio che quasi saltava i pasti. Già! Poi aveva cominciato a fare figli. E avrebbe continuato a sfornarne uno dopo l'altro se i medici non si fossero decisi ad asportare, a breve, le ovaie a Viviane. Chissà come si sganasciavano dalle risate quei due, madre e figlio, quando si ritrovavano da soli nella topaia di rue Caulaincourt con le porte chiuse e le tende tirate! Sì, perché di sicuro tiravano le tende per paura che la gente di fronte li vedesse ridere a crepapelle! Quelli come loro non ridono mai in pubblico. Tutt'al più abbozzano un sorrisetto triste. Non è così, signor figlio? «Bevi!». «Io...». Gli cacciò quasi a forza il bicchiere in mano, guardandolo negli occhi come se volesse ipnotizzarlo. «Cameriere!». «La prego!». «Cameriere, un altro!». Aveva un'espressione minacciosa e lo sapeva, dato che si vedeva nello specchio. Sapeva anche che sarebbe diventato cattivo, perché stava male, perché era stato male tutta la sera. No, non era il cuore. Non era il petto. Eppure il suo era anche un dolore fisico, lo sentiva dappertutto, nel più profondo di se stesso. Che avrebbero detto tutti quanti, tutte quelle larve che aspettavano chissà cosa, sorseggiando la loro consumazione con lo sguardo perso nel vuoto, che avrebbero detto se ora si fosse seduto per terra, lì, in mezzo alla segatura, o sul marciapiede, sotto la pioggia, e si fosse messo a gridare per lo sfinimento come da tanto tempo desiderava fare, o a ragliare come l'asino che era? «Sono stanco. Stan-co, capite?». Stanco da morire. Stanco di essere un uomo. Stanco di reggersi in piedi. Stanco di vedere e sentire individui come Cadot, e di doversene per giunta fare carico. Avevano delle remore, loro, a tormentarlo? Qualcuno aveva mai avuto pietà di lui? Lo avevano mai visto andare a chiedere educatamente aiuto a chicchessia? «Eccellenza, mia moglie è malata!». Anche lui si era sposato, aveva avuto addirittura tre mogli, senza contare quella piattola di Juliette, e l'ultima lo aspettava nel suo letto. Di colpo, mentre fissava il duplice specchio dietro le bottiglie, si stupì al pensiero che c'era una persona nel suo letto, una persona estranea, che dormiva, sudava, respirava tra le sue lenzuola. «Bevi, Cristo santo!». Di solito si fermava molto prima. A teatro, senza rendersene conto, si era scolato una quantità di cognac spropositata. Cominciava a barcollare, ed era consapevole che tutti guardavano con aria di disprezzo - o, peggio ancora, di commiserazione - il grande Maugin sbronzarsi in quel modo. «Ti dirò una cosa, giovanotto...». «Sì, signore». «Sei una lurida carogna, e per me puoi andare a farti fottere. Cameriere, tenga pure il resto». Per strada sentì dei passi alle sue spalle e probabilmente si sarebbe messo a correre se un taxi in cerca di clienti non si fosse fermato al momento giusto. Accadde tutto come in un sogno, come nella scena di un film perfettamente congegnata. Fece giusto in tempo a salire e a sbattere lo sportello in faccia a Cadot, che rimase a guardarlo inebetito. «Dove la porto, signor Maugin?». Il tassista lo conosceva. Tutti lo conoscevano. «Dove vuole. Lontano da qui! Da nessuna parte!». E sul momento quelle parole gli parvero sublimi. «Lontano da qui! Da nessuna parte!». Sprofondato nel sedile umido, se le ripeteva sottovoce, continuava a pronunciarle fra sé, come se potessero chiarire finalmente il doloroso mistero del mondo. | << | < | > | >> |Pagina 81Maugin trasalì, fece un movimento istintivo come per aggrapparsi a qualcosa, aprì gli occhi, che non ricordava di aver chiuso, e nel vedere la stanza vuota si spaventò come un bambino che si ritrova solo.Tutt'a un tratto ebbe paura di morire. Gli sembrava che il sangue non gli pulsasse più normalmente nelle vene, che gli si fosse offuscata la vista, prese a tastarsi il polso, e intanto guardava fuori dalla finestra per assicurarsi che, se avesse chiamato aiuto, qualcuno nel vialetto lo avrebbe sentito. Si vedeva soltanto la pioggia, il lugubre muro di mattoni del teatro di posa, una porta di ferro dipinta di rosso e il tetto lucente di una macchina. Probabilmente si era assopito un istante e aveva avuto un incubo, che ora cercava invano di richiamare alla memoria. Ricordava tutto quello che aveva pensato a proposito di Yvonne, ma poi c'era stato qualcos'altro, qualcosa di terrificante, che si era concluso con una caduta nel vuoto. «Che coglione!». Era la sua voce, un po' alterata perché rimbombava nel camerino vuoto, ma comunque la sua voce. Quella mattina aveva finalmente recitato la famosa scena. Era un dato di fatto. A quell'ora avevano di certo sviluppato la pellicola, e Laniaud stava visionando il girato. Lui non aveva bisogno di vederlo. Sapeva già com'era. Sapeva anche che doveva alzarsi, camminare fino all'armadio e versarsi un bel bicchiere di vino. Era i-ne-vi-ta-bi-le. Ne aveva appena avuto la prova. La prima a dimostrarglielo era stata ancora una volta Yvonne Delobel. Era accaduto una domenica in cui nessuno dei due aveva da lavorare, una di quelle domeniche incolori in cui si ha l'impressione di guardare il mondo attraverso una palla di vetro. Contrariamente alle loro abitudini, erano usciti. Lei aveva voluto prendere una carrozza, una di quelle con cui gli innamorati e i giovani sposi se ne vanno a spasso per il Bois de Boulogne, e aveva dato istruzioni al vetturino a bassa voce. «Dove andiamo?». «Poi vedrai». Era un giorno in cui Yvonne, proprio come lui quella mattina, non aveva bevuto e cercava di smaltire la sbornia dopo una notte di bagordi. Si sentivano entrambi sfatti, indolenziti, avevano la pelle coperta di chiazze rosa, sensibili al contatto con l'aria esterna, e stentavano a tenere gli occhi aperti alla luce del sole. La carrozza aveva attraversato Neuilly e si era diretta lentamente verso Bougival, mentre Yvonne, assorta nei suoi pensieri, restava in silenzio. «A sinistra» aveva ordinato una volta giunti in riva alla Senna. Cercava di capire le reazioni di Maugin dall'espressione dei suoi occhi, ma lui sembrava solo in preda a una sonnolenza quasi dolorosa. Era estate - quasi tutti i teatri erano chiusi, perciò avevano la domenica libera - e alcune coppie si dedicavano al canottaggio. «Si fermi, vetturino». E a lui, sottovoce: «Guarda al di là di quella siepe». Si vedeva una casa bianca, spaziosa, immacolata, con le persiane verdi e il tetto di ardesia, circondata da un giardino con prati ben tenuti e violetti accuratamente rastrellati. «Che ne pensi?». Lui non sapeva che cosa rispondere, si chiedeva dove Yvonne volesse andare a parare. «Ci vive qualcuno che conosci?». «» la casa che ho sempre sognato, che sognavo già da bambina». «» in vendita?». «L'ho comprata». «Ah, sì?». «Poi l'ho rivenduta». E, con quella voce sorda ma struggente, come controllata, che aveva fatto di lei un'impareggiabile Signora delle camelie, gli spiegò, senza scendere dalla carrozza e stringendogli il braccio con la mano, mentre il cavallo fiutava l'erba: «» successo cinque anni prima che ti conoscessi. Sono passata di qui e l'ho vista. Coincideva in tutto e per tutto con il mio ideale di pace, di serena bellezza. Non era in vendita, ma io ho mosso mari e monti per mesi finché non li ho convinti a cedermela, poi ci ho portato tutto quello che doveva esserci nella casa dei miei sogni». A un tratto l'aveva guardato spazientita, forse anche con un'ombra di collera. «Tu non hai mai sognato una casa con le persiane verdi?». «Non mi pare. No». «Neanche quando eri piccolo?». Lui preferì non rispondere. «Già, ma tu sei del tutto privo di sensibilità. Non hai mai desiderato nemmeno una donna dolce con cui avere dei figli». Lui continuava a tacere, scuro in volto. «Forse tu un giorno l'avrai una casa così» sogghignò lei. E, quasi furibonda, aggiunse: «Sono venuta qui. Ho cercato di viverci. La prima settimana stavo impazzendo dalla disperazione. La seconda sono scappata e non ci ho mai più messo piede». Maugin aveva bevuto due bicchieri di vino e non si decideva a ritappare la bottiglia. «Più avanti capirai» aveva sospirato lei, di cattivo umore per quella domenica sprecata. «Parta, vetturino. Torniamo a Parigi!». In mezzo alla folla, alle luci, al caos. Dopo meno di due chilometri si era fermata a bere qualcosa in un bistrot fuori città. Ecco! Di lei avevano detto e dicevano ancora: «l'indimenticabile artista». E di lui: «il grande Maugin». Con sciocca ironia disse rivolto alla bottiglia: «Vieni qui, dolcezza!». E, come se volesse torcerle il collo, si versò di nuovo il liquido violaceo nel bicchiere. | << | < | > | >> |Pagina 91«Non la voglio. Fa' entrare i turisti».Li chiamava così quando era di buonumore. E certe volte faceva anche un discorsetto, come una guida che illustri un monumento storico. «Vedete questo specchio apparentemente insignificante su cui generazioni di mosche hanno prosaicamente defecato? Ebbene, un tempo ci si è specchiato il grande Mounet-Sully. Invece questa tenda di cretonne - che, detto fra noi, ormai è diventata color piscio - ha passato i suoi primi anni nel camerino di Réjane, e quelle che spuntano in basso - perché è lì dietro che mi cambio - sono le mie pantofole». La gente lo trovava spiritoso. «Quanto a Maria, anche lei è quasi un'attrazione nazionale, perché prima di finire in teatro, di finire male, insomma, è stata la cuoca di Paul Painlevé, quel tale noto per la sua sbadataggine». Sul palco si divertiva a mettere in difficoltà i colleghi, cambiando le battute o biascicando commenti fuori luogo. Fece andare nel pallone il suo partner durante una scena difficile, ripetendogli ininterrottamente a bassissima voce per cinque minuti buoni: «Hai la patta aperta!». L'altro, che in quel momento aveva una pila di libri in mano e non poteva verificare - fra parentesi i pantaloni erano perfettamente in ordine -, non sapeva come comportarsi e cercava di mostrarsi alla platea solo di profilo. L'attore in questione era, guarda caso, proprio quello che nel terzo atto strappava una risata al pubblico, e in fondo lo scherzo di Maugin era un po' una vendetta. Mentre si rivestiva, gli telefonò Laniaud. «Hai da fare, …mile?». «No». «Vieni al Maxim's. Sono con delle persone di Hollywood». «Buon per te, io vado a dormire». All'uscita del vicoletto non c'erano taxi, per cui Maugin fece un pezzo di strada a piedi e, passandoci davanti, lanciò un'occhiata torva al caffè della sera prima. Aveva smesso di piovere. Il selciato, ancora umido, luccicava come se ci avessero passato lo smalto. Solo quando arrivò alla Trinité riuscì a trovare un taxi. «Dove la porto, signor Maugin?». «A casa mia». «Abita sempre in avenue George V?». Fu tentato di fare un salto in rue de Presbourg, perché era curioso di sapere che cosa fosse successo esattamente il giorno prima. Cominciava a pensare di non essere stato poi così infelice appollaiato su quello sgabello, all'estremità del bancone, con la schiena appoggiata al muro. C'era movimento. C'era vita. A opprimerlo, in casa sua, in tutte le case in cui aveva vissuto, era il silenzio, l'immobilità dell'aria, una sorta di calma inesorabile, che dava l'impressione che il tempo si fosse fermato per sempre. Provava qualcosa di simile guardando dall'esterno le case degli altri. E non era una novità. Aveva sempre avvertito quel senso di malessere. Quando, per esempio, camminando per strada, vedeva una famiglia seduta intorno a un tavolo, con i volti illuminati come in un quadro di Rembrandt, gli pareva quasi che quella scena fosse cristallizzata, che i vari personaggi, il padre, la madre, i bambini, la domestica in piedi, dovessero restare lì, immobili, fino alla fine dei tempi. I muri, le porte chiuse gli ispiravano una sensazione di insicurezza, di angoscia. Sapeva che Yvonne non intendeva questo parlando della casa con le persiane verdi, ma per lui era così. Aveva il terrore degli album di famiglia, con tutte quelle pagine piene di parenti morti, poi quelle con i parenti vivi, che però, una volta entrati lì dentro, erano già un po' meno vivi. «Questo era tuo zio Marcel». Ma il neonato che compariva verso la fine, adagiato su una pelle di capra, era a sua volta uno zio in potenza e un giorno sarebbe finito anche lui in una delle prime pagine. All'incrocio con gli Champs-…lysées bussò al vetro divisorio, scese ed entrò al Fouquet's, dove fu costretto a fermarsi a quasi tutti i tavoli per stringere le mani che gli venivano tese e dove aleggiava un tanfo di pellicce bagnate. «Un bel bicchiere di rosso, signor …mile?» gli propose il barman. In quel locale lui era l'unico che lo beveva; rimase lì una decina di minuti, in piedi, a guardare la gente e a pensare al Presbourg, indeciso se chiedere un secondo bicchiere. Non lo fece, attraversò sospirando l'androne del suo palazzo e lanciò uno sguardo truce alle colonne di marmo e alla scala solenne, che sembrava pronta a ricevere una folla di invitati. Il primo piano era occupato dagli uffici di una casa di produzione cinematografica che era da anni sull'orlo del fallimento; al secondo c'era una coppia di americani (gente che aveva tre macchine e due autisti); al terzo un conte; al quarto invece gli inquilini cambiavano in continuazione. «Non sei ancora a letto?». «Ho pensato che ti avrebbe fatto piacere trovarmi sveglia». «E se non fossi tornato?». «Avrei continuato a leggere». Senza che lui glielo avesse chiesto, era andata a versargli un bicchiere di vino, e faceva uno strano effetto vedere quel rosso da quattro soldi nel cristallo smerigliato, sembrava diverso anche il sapore. | << | < | > | >> |Pagina 151Benché fosse grande e grosso, benché con la sua mole occupasse tutto il letto, benché trasudasse vino e alcol, quel pomeriggio, nell'intimo del suo essere, là dove la ragione e il ritegno non hanno più valore, si sentiva un bambino debole e indifeso. E, come un bambino, lottava contro il sonno che lo assaliva a ondate e si ostinava a tendere l'orecchio ai rumori della casa, chiedendosi se «lei» sarebbe venuta a dargli un bacio. Alice non aveva l'abitudine di entrare in camera sua quando stava riposando. Del resto, in altre circostanze probabilmente lui non l'avrebbe accolta con gioia. E ora non le aveva detto niente che potesse assomigliare a un invito. Gli pareva di non aver lasciato trapelare nessun segno di tristezza. Solo un breve istante di commozione quando aveva visto le sei candeline che illuminavano il viso di Baba con le loro fiammelle tremolanti. La festa era riuscita bene. Tutti erano stati gentili con lui, e lui si era sforzato di ricambiare quella gentilezza. Avevano preso il caffè sulla terrazza, di fronte al mare, proprio come nelle fotografie delle famiglie famose che si vedono nelle riviste. La medaglietta della signora Lampargent - perché si trattava proprio di una medaglietta - era un San Cristoforo per l'«automobile», e Maugin aveva subito chiamato Arsène per dirgli di metterla sul cruscotto. Jouve aveva ordinato a una ditta di forniture nautiche un tendalino di tela bianca con dei sostegni smontabili per la Girelle, che così armata avrebbe avuto tutta l'aria di una gondola. C'erano perfino delle nappine che pendevano tutt'intorno alla tenda, come nelle ultime carrozze di Nizza. Gli era sembrata una buona idea, e si era dato molto da fare per metterla in pratica. Alice, invece, gli aveva regalato una cosa che lui desiderava da vent'anni e che, per motivi che non avrebbe saputo spiegare, non si sarebbe mai comprato da solo: una penna d'oro massiccio. Doveva essere costata un occhio della testa, e alla fin fine l'aveva comprata con i suoi soldi, i soldi di Maugin, visto che lei non possedeva nulla di suo. Qualche settimana prima lui le aveva raccontato con un pizzico di invidia del direttore di un giornale che, per i suoi cinquant'anni di carriera, aveva ricevuto una penna d'oro, e aveva precisato, leggendo un trafiletto che ne parlava, che l'oggetto era stato realizzato dall'orefice Mauboussin. «A me» aveva brontolato «regalano solo scatole di sigari. Fantastico, considerando che non fumo!». Come ci era riuscita? Lui le dava i soldi per la casa, per i domestici, per i vestiti e le altre spese personali, ma era piuttosto parsimonioso. Quel regalo dimostrava che, tutto sommato, era possibile farci un po' di cresta. Lì per lì aveva preferito non pensarci; quel giorno voleva sforzarsi di non pensare a cose spiacevoli. Quando stava per salire, Jouve aveva detto: «Immagino che della questione Weill preferisca parlarne dopo essersi riposato?». E lui non per quello, non solo per quello, aveva risposto: «Ah, a proposito, devi andare a Nizza con la macchina». Jouve non ci aveva visto niente di strano. Alice, invece, era a disagio come ogni volta che Maugin faceva in modo di allontanare Adrien per evitare che restasse solo in casa con lei. Spesso reagiva in modo così goffo da sembrare colpevole. Prendeva tali e tante precauzioni per non trovarsi a tu per tu con il segretario che finiva per mettersi in una posizione imbarazzante. Jouve aveva una camera nella dépendance, l'ala collegata al corpo principale con il famoso ponte. Da brava padrona di casa, Alice avrebbe dovuto passarci ogni tanto, per sincerarsi che le domestiche la tenessero in ordine e che non mancasse niente. Invece era l'unico posto dove non metteva mai piede e, quando vedeva che Baba, in giardino, andava a giocare da quella parte, si affrettava a richiamarla. Evitava di guardare dalle finestre che davano sulla dépendance. A tavola si sforzava di non chiedere il sale o il pepe a Jouve e, se lui si informava premurosamente se voleva dell'acqua, preferiva dire di no e farne a meno. Girandosi verso la moglie, Maugin aveva detto: «Stasera ti porto a vedere il mio film». Era l'ultimo che aveva girato a Parigi, quello che aveva finito subito prima di partire e che era in programma per due giorni al Palais de la Méditerranée. «Se ti fa piacere, possiamo cenare fuori e poi andare al cinema». «Come mi devo vestire?». Lui aveva voluto essere gentile fino in fondo, visto che aveva deciso che quel giorno sarebbe stato tutto all'insegna della gentilezza. «In abito da sera. Così poi, se ci va, possiamo andare a bere una bottiglia di champagne al casinò». Pazienza, si sarebbe messo lo smoking! Alice aveva così poche occasioni di indossare l'abito da sera! Mandava Jouve a prendere i biglietti, e nessuno ebbe il coraggio di fargli notare che era inutile, che bastava telefonare. L'importante, il solito problema quotidiano, era che Jouve non fosse in casa mentre lui riposava. «Be', io vado! A dopo, ragazzi...». Non era accaduto nient'altro. O meglio, il resto era accaduto solo dentro di lui, e Alice non era tenuta a leggergli nel pensiero. Chissà se sarebbe venuta lo stesso! Lui non si era messo a letto nudo come gli altri pomeriggi e aveva indossato un pigiama pulito. Si era perfino sistemato i capelli che, quando gli si incollavano sulla fronte, gli davano un'aria dura e cocciuta. Baba riposava. La signora Lampargent probabilmente stava leggendo il giornale sul balcone della sua stanza (tutte le stanze in casa ne avevano uno). Era sempre lei ad accaparrarsi i giornali per prima, come se si aspettasse di trovarci chissà quale notizia di capitale importanza. Oliva, quando lui stava per salire, gli si era avvicinata asciugandosi le mani sul grembiule. «Le auguro buon compleanno, signore». «Grazie, mia cara». Aveva dovuto stringere quelle mani umide. Anche Camille gli aveva fatto gli auguri sulle scale.
Era un bestione di sessant'anni e sporgeva il labbro
inferiore in avanti come un bimbetto che sta per piangere perché lo hanno
lasciato solo nella culla!
|