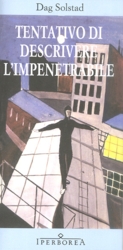
|
|
|
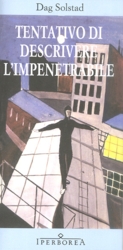
|
|
|
| << | < | > | >> |Pagina 9Questa volta il narratore lo faccio io in persona, e dunque il racconto si apre, che lo crediate o no, con il protagonista che digita il numero di telefono dell'autore (cioè il mio) con l'idea di chiedergli un incontro per discutere il suo (cioè il mio) ultimo romanzo (La relazione del professor Pedersen...), che ha suscitato in lui una profonda (benché erronea) impressione. Il protagonista ha dunque digitato il numero. Il protagonista cerca di mettersi in comunicazione. Tiene la cornetta all'orecchio e sente suonare, una volta, due volte, tre volte. Intanto io, nel mio appartamento, sento il telefono che squilla. Il telefono! Vado al telefono e alzo la cornetta. "Pronto", dico, teso come sempre, e sento il mio nome pronunciato da una voce all'altro capo del filo invisibile che ci ha appena collegati e che, senza che io ancora lo sappia, avrebbe continuato a collegarci fino alla fine di tutta la vicenda. "Con chi parlo?" gridai. "Sono AG", rispose con una risatina imbarazzata. "Cosa??? AG! Sei proprio tu?! Non è possibile!"Invece era proprio AG. Arne Gunnar Larsen. Il mio amico d'infanzia a Sandefjord, con cui ero cresciuto e con cui avevo letteralmente consumato il fondo dei pantaloni, prima addirittura come compagni di banco sui banchi doppi della scuola elementare di Sandefjord, nel 1948-50, poi uno dietro l'altro nei banchi singoli più eleganti e moderni negli ultimi quattro anni di elementari, poi alle medie, al liceo, e infine come studenti universitari a Oslo nei primi anni Sessanta, finché era sparito in silenzio dalla mia vita nel 1965, per non ricomparire più fino appunto a quella telefonata in un giorno qualunque d'inverno, pungente, ventoso e bianco, a Oslo, capitale della Norvegia, poco dopo Capodanno, nel 1983. Possibile? Decisi di crederlo, tanto più che AG andò dritto al sodo, cominciando a elogiare in toni entusiastici il mio recente romanzo, per finire con la proposta di cenare insieme al Theatercafé la sera successiva. La proposta cadeva a dir poco male. Ero in partenza per il Messico. Me ne sarei volato in Messico tre giorni dopo per rimanerci sei mesi. Ero insomma in uno stato di aspettativa, tensione ed eccitazione, dovendo intraprendere il viaggio all'estero più importante e anche più lungo della mia vita. Stato che trovava espressione concreta nelle grandi valigie già aperte sul pavimento del soggiorno, pronte a essere riempite dei bagagli miei e della mia compagna. Restava molto da fare per tradurre in realtà quel viaggio, e solo tre giorni per farlo. Non avevo quindi davvero il tempo di incontrare AG. Per di più era un sabato sera quello che mi proponeva, cosa che la mia compagna di viaggio e di vita non avrebbe certo apprezzato, per lo meno non in quel momento, a tre giorni dalla partenza per il Messico. Tuttavia non dissi di no. Dovevo rivedere AG. Perciò uscii al freddo e rimasi a congelare alla fermata Ullevål Stadio, in attesa del metro da Sognsvann che doveva portarmi in centro, al Theatercafé. La città bianca e fredda, pungente e con le sue luci al neon. Fosse stato solo per incontrare Ame Gunnar Larsen, dubito che sarei andato. E fosse stata una persona qualsiasi a telefonarmi per elogiare il mio ultimo romanzo, non ho dubbi che non sarei andato. Ma la combinazione era irresistibile. Sentirmi elogiare in toni entusiastici dal mio vecchio amico di Sandefjord: era la più grande soddisfazione cui uno scrittore possa aspirare. Date le premesse si può ben dire che varcai letteralmente a passo di danza la porta del Theatercafé, appesi il mio soprabito, proseguii nel grande e accogliente caffè viennese e mi rivolsi al maître, il quale mi indicò il tavolo prenotato a nome dell'architetto Arne Gunnar Larsen. Ero in anticipo, e mi sedetti ad aspettarlo. Stavo dunque aspettando l'architetto MNAL Arne Gunnar Larsen, alias AG, nome che si era dato da sé ai tempi del liceo e che era riuscito a imporre, nonostante l'innegabile tocco di affettazione. Il nome si ispirava agli appellativi dei radioamatori. AG chiama OP passo. Prima si chiamava Arne Gunnar. In questo racconto lo chiamerò sia AG sia Arne Gunnar, né esiterò a fare uso del cognome Larsen, quando sarà necessario. Aspettavo. Non lo vedevo da diciassette anni. da quando ne avevamo entrambi ventiquattro, ed eravamo ormai prossimi ai quarantadue, entrambi. Eravamo nati lo stesso anno, lo stesso mese, e avevamo condiviso lo stesso banco alla scuola elementare di Sandefjord e la stessa boccetta di inchiostro. Sempre insieme, costantemente, anche quando lasciammo Sandefjord per andare entrambi all'università, lui al corso di architettura del Politecnico di Oslo, io alla Facoltà di Storia e Filosofia, dove studiavo storia delle idee, fino all'estate del 1965 quando, senza alcun particolare motivo, le nostre vie si separarono e ci perdemmo del tutto di vista. Dire che mi faceva piacere rivederlo è dir poco; anche senza la combinazione vecchio amico/lusinghe, il senso di aspettativa che provavo era fortissimo, quasi doloroso, al pensiero che tra poco sarebbe comparso sulla soglia del Theatercafé e mi sarebbe venuto incontro. Sapevo come gli erano andate le cose; ogni tanto incontravo gente che frequentava il suo giro, e mi ero sempre informato di lui. In un certo senso era strano che non l'avessi visto in quei diciassette anni: abitavamo pur sempre nella stessa città, che, per quanto sia la capitale, non ha più di mezzo milione di abitanti, e un centro di un'estensione tutt'altro che ragguardevole; le traiettorie che seguivamo nella vita quotidiana non erano così distanti tra loro, non tanto almeno da impedirmi di incrociare qualche volta persone del mio ambiente che conoscevano A.G. Larsen, e che potevano darmi sue notizie. Ma in effetti è così per tanti di quelli che ho conosciuto, specie all'epoca in cui mi erudivo all'università di Oslo e studiavo in segreto da scrittore, nei primi anni sessanta. Non li vedo mai. Ora, in ogni caso, AG Larsen si era fatto vivo, finalmente, ed ero felice di vederlo. A questo punto, però, va anche detto che se in quel preciso istante avessi avuto il minimo sospetto che stavo aspettando il protagonista del mio nuovo romanzo, la mia gioia sarebbe stata un po' offuscata, perché bisogna ammettere che Arne Gunnar Larsen è direttore della pianificazione alla OBOS e uno scrittore avrebbe pur diritto di immaginarsi qualcosa di più allettante nella scelta del protagonista. Se per di più si aggiunge che mi era giunta voce che si era da poco separato da Bente Berg (Larsen), mi sarei sentito – sempre che avessi intuito che si trattava di un personaggio letterario, anzi di uno dei miei personaggi letterari, addirittura del protagonista di questo libro – in un paralizzante conflitto tra aspettativa privata e una sensazione di catastrofe letteraria. Ma eccolo che arriva. Nonostante i diciassette anni passati, l'ho riconosciuto all'istante. L'orchestra attacca dalla balconata. Il Theatercafé saluta agitando le sue tovaglie bianche, applaude con tintinnii e tramestii e fumo di sigarette, che sale serpeggiando come uno sparo a salve. Mi alzo e gli do il benvenuto. Vecchio amico mio! Compagno di tanti anni, antico alleato in un'eterna lotta contro l'esistenza, ora burocrate a Oslo. Architetto e burocrate. Lo guardo: "Che fine hanno fatto i tuoi capelli?" Lui guarda me: "Terje Vigen! Prima eri solo uno stravagante, adesso sei uno stravagante e grigio." | << | < | > | >> |Pagina 20AG e io. Al Theatercafé di Oslo. Due uomini sulla quarantina; mangiamo il nostro filetto di renna e beviamo il nostro vino. Conversiamo. Ancora su La relazione del prof. Pedersen... Be', per farla breve, AG riuscì ancora una volta a lasciarmi di stucco. Adesso parlava di quanto quel romanzo fosse onesto. Una confessione di un'onestà spietata su dieci anni della mia vita, per dirla con le sue parole. Esaltava senza ritegno la mia onestà. Credeva ovviamente di lusingarmi, e invece no. Mi offendeva. Ho vissuto abbastanza per sapere che se uno viene accusato di essere onesto, è in realta considerato stupido, superficiale, piatto. AG mi accusava in altre parole di avere scritto un romanzo limitato, e la cosa non mi garbava affatto. Non volevo che mi si desse dell'«onesto». Ma AG mi dava dell'onesto. Diceva che, senza curarmi delle conseguenze personali, avevo ammesso di aver vissuto dieci anni nella morsa del romanticismo rivoluzionario e del settarismo, come lui la chiamava. Esaltava il mio talento artistico. Solo i grandi talenti artistici hanno l'audacia di scrivere con tanta onestà, disse. Questo mi fece infuriare. Sentivo di dover passare all'azione. E quindi passai all'azione. Mi alzai e URLAI per la seconda volta.L'urlo numero due ebbe luogo un'ora e mezza dopo il primo. Com'è ovvio nel frattempo c'erano stati alcuni avvicendamenti nel locale; qualcuno aveva pagato e se n'era andato, nella tranquilla certezza che ci sarebbe stato un solo urlo quella sera; altri erano arrivati, e vissero quindi l'urlo numero due come se fosse stato il primo, e perciò forse passarono il resto della serata a discutere se le reazioni che aveva scatenato da parte della direzione non fossero state eccessive, e tipicamente norvegesi. Per il resto tutto fu esattamente come la prima volta, perfino l'urlo in sé, che durò esattamente lo stesso tempo. L'unica diversità fu che, quando tornai a sedermi ed enunciai la mia replica nel silenzio, questa non fu più "io non ho senso dell'umorismo", ma "io non sono onesto", parole che comunque si udirono con la stessa chiarezza delle precedenti, e anche il cameriere che sopraggiunse fu lo stesso di prima; ma qui termina appunto l'identità delle scene. | << | < | > | >> |Pagina 39AG mi parlò di questa «voglia», come la chiamava lui, con molto imbarazzo. Ma me ne parlò, pur non avendone nessun obbligo. Così come mi raccontò di quante volte gli era venuta voglia di prendere il treno e tornare a Sandefjord, tutto solo, scendere alla stazione e vagabondare per le strade senza andare a trovare nessuno, senza riconoscere nessuno, e senza essere riconosciuto da nessuno, un perfetto estraneo di ritorno ai luoghi dell'infanzia. Ma non poteva farlo e basta? No, non poteva. Perché quando l'aveva rivelato a Bente, lei era stata presa dall'entusiasmo e aveva detto: "Ottima idea, portati anche i bambini." Pensava che così i figli avrebbero potuto vedere insieme a lui com'era cresciuto loro padre. Ma non era quello che voleva lui. Lui voleva tornare là come uno «sconosciuto», uno «straniero», «un individuo del tutto vuoto», non come un padre realizzato che debba mostrare ai figli la povertà della sua infanzia.A casa aveva provato una voglia violenta di qualcosa di proibito. La voglia di starsene seduto su una sedia a fissare il vuoto, e di lasciarsi vedere così da moglie e figli. Che lo vedessero seduto a fissare il vuoto. Con sgomento, dovevano vederlo. Perché in casa Berg-Larsen non si buttava via il tempo, al contrario, il tempo, la vita si mettevano a frutto. Tutti, dal padre alla madre, a Morten e Kari mettevano a frutto il tempo in attività significative e frequentazioni arricchenti. Si formavano in continuazione, specie i figli, per la più grande soddisfazione dei genitori. Vivevano una vita piena. Ma nel cuore di Arne Gunnar si nascondeva il sogno che i suoi figli entrassero nel soggiorno e vedessero il padre su una sedia, lo sguardo fisso sul muro, per ore e ore. Questo era loro padre. Dimenticatevi tutto il resto, sono solo sfizi e alibi, avrebbe detto loro, e pensava di dire loro nei suoi sogni a occhi aperti. | << | < | > | >> |Pagina 44Adesso vedeva Romsås come una città satellite in cui le idee nuove e radicali si erano affinate attraverso le esigenze della realtà. Oggi guardava alla creazione di Romsås come al fruttuoso incontro tra idee audaci e calcoli ragionevoli, e i limiti della realtà (risorse tecnologiche, strutture delle cabine, natura umana, prezzi reali del cemento, reali tassi di interesse ecc.). A partire da queste condizioni era stata creata una città satellite di cui AG Larsen pensava non ci fosse affatto da vergognarsi. Un monumento alla Norvegia moderna degli anni Settanta. Romsås era la Norvegia moderna. Se si fosse voluto cercare un luogo preciso in grado di rappresentare la Norvegia che AG serviva con tanto orgoglio, non si sarebbe trovato un esempio migliore di Romsås. In questo luogo esemplare dunque si trasferì, perché era ormai davvero ora di ricominciare a vivere.AG venne a vivere qui, e qui i suoi figli conobbero un nuovo padre. Un padre più malinconico, più irascibile, più disperato di quello che avevano conosciuto finora. Un padre capace di urlare come una belva (sua specifica prerogativa), di tenere il broncio come un bambino, di essere vulnerabile, un'ingovernabile mina vagante. Un uomo con esperienza di vita, e che perciò era scisso, confuso e gentile. Forse questo spaventava i due «figli di funzionario», ma era così che voleva che lo vedessero. Tentava di far presente a Morten e Kari che non era vero tutto quello che aveva cercato di inculcare loro in precedenza: che la vita è una cosa che non va sprecata, che è una scuola, non per niente si dice la scuola della vita, i cui esami sull'uso giudizioso del nostro tempo limitato su questa terra si fanno ogni sera. Ora AG cercava di dimostrare che non era vero. Che la vita andava vissuta, nel bene e nel male, un sacco di cose facevano parte della vita, per la miseria, la vita che gli scorreva tra le dita, come la luce, che non aveva bisogno di attestati di promozione, ma apparteneva a ciò che scorre, e che lui non voleva più lasciarsi sfuggire, nonostante tutto. Perciò si sforzava di diventare per loro il padre meno impeccabile che si potesse avere. Dormiva fino a tardi, non si curava di sfruttare al meglio il tempo che trascorreva con i figli. Stava seduto a tavola a leggere il giornale invece di conversare, o di discutere, di coltivare il dialogo, o quel che diavolo fosse. Li mandava fuori perché si arrangiassero per loro conto, mentre lui si limitava a rilassarsi, a rimuginare sulla vita, o a fissare il vuoto. Gli dava dolci invece di carote. Si rovesciava il latte sui pantaloni. Voleva diventare un padre con le macchie sui pantaloni. Un padre malinconico che i figli avrebbero poi ricordato come un esempio di vita. Ma era così solo nei riguardi dei figli, e di se stesso. Per il resto sembrava rimasto quello di sempre. Il direttore della pianificazione un po' grigio, discreto, gentile, piuttosto anonimo. Ma che andava i giro in una Saab grigio metallizzato. Nel garage di Romsås c'era la sua Saab grigio metallizzato, quella con cui AG andava in ufficio ogni mattina. Per il resto aveva conservato quasi tutte le sue abitudini. Come il jogging. Come la maggior parte degli uomini della sua età e condizione sociale, Arne Gunnar Larsen era un appassionato di jogging. Consapevole del meccanismo del ciclo vitale, con i limiti che pone alle nostre più radicate speranze, si prendeva buona cura del suo corpo. Indossava la tuta da jogging e correva per i sentieri di Romsås sotto ai palazzi ogni sera. Un rituale fisso che gli permetteva di ascoltare i battiti del proprio cuore, fin nel profondo dell'anima. Indossata la sua moderna armatura, AG fuggiva ogni sera da malattie e morte sui sentieri ghiacciati di Romsås. | << | < | > | >> |Pagina 77Per mezzo del videoregistratore Bjørn Johnsen era in grado di entrare in contatto con le reali motivazioni di fondo della sua vita, il che condannava tutto il resto alla sua intrinseca debolezza: nient'altro poteva competere. In poltrona, con il Telecomando in mano, Bjørn Johnsen poteva controllare le immagini e guardare. Nei film l'ipocrita e stanca realtà non era solo messa a nudo, ma anche smascherata, e tutte le chiacchiere superflue erano spazzate via. Il vero appariva.Bjørn Johnsen era tutto preso a osservare il vero. Era un fanatico. Nient'altro aveva senso per lui. Per questo AG lo ammirava. Agli occhi di AG, Bjørn Johnsen era un uomo dalle profonde radici esistenziali. Uno che aveva il coraggio di vivere senza illusioni. Uno che non soltanto preferiva vivere senza illusioni, ma che in più era tutto preso da questo. Avere il coraggio di guardare la realtà negli occhi. Attraverso i film Bjørn Johnsen guardava la realtà com'era, dritto negli occhi e senza batter ciglio. Sera dopo sera. Tutto questo aveva fatto di Bjørn Johnsen un uomo solo. Nonostante non trascurasse la minima occasione per manifestare il suo disprezzo per la Norvegia e i norvegesi — che chiamava Ola Dunk come «Berretto da gnomo», o a un ortaggio importato in Norvegia dall'America alla fine del XVIII secolo, diventato un utile contorno, di nome «patata» o, nella dizione dispregiativa di Bjørn Johnsen, «potitt», spesso usato nelle geremiadi contro il nemico numero uno: i Programmi televisivi norvegesi — si poteva ben dire, tuttavia, che Bjørn Johnsen rappresentasse meglio di chiunque altro la solitudine norvegese, che anzi fosse un erede diretto del sognatore solitario delle sperdute fattorie di montagna, chiuso nella natura, nel buio, a miglia e miglia di distanza dal vicino più prossimo, esclusivamente preso a interpretare il vero significato del buio invernale e del proprio destino alla luce di quel dato nero come la pece, ora trapiantato nell'era elettronica del XX secolo, e collocato in un luminoso appartamento di quasi cento metri quadri, in una città satellite poco a nord del centro della capitale della Norvegia. A parte guardare il proprio destino interpretato in innumerevoli varianti, c'era un'unica altra cosa cui Bjørn Johnsen pareva interessato, ed era la famiglia. Ylva e il Bambino. Quello era il suo mondo. Al di fuori di quello Bjørn Johnsen si avventurava ben poco, ed esclusivamente per guadagnarsi da vivere. E questo, come s'è detto, nonostante la sua natura socievole e sveglia. | << | < | > | >> |Pagina 88La società norvegese nell'anno di grazia 1983. Una delle città satellite di Oslo, a una decina di chilometri a nord del centro. Costruita in una zona collinosa, circondata da boschi, montagne e acqua, natura. È inverno. Un inverno relativamente mite, ma pur sempre pungente e freddo, con una neve abbastanza compatta, grigiastra, o infiltrata di strisce nere, gelate. La temperatura si è mantenuta normalmente intorno allo zero quell'inverno, più spesso un paio di gradi sotto. L'azione è la seguente: un burocrate dell'OBOS, l'architetto MNAL A.G. Larsen, si è trasferito in questa città satellite perché — colto dalla famosa crisi dei quarant'anni — si è sentito prendere da un'intensa nostalgia del popolo, e della vita possibile. Si è separato, ha abbandonato l'ambiente colto cui apparteneva, sente di aver bruciato tutti i ponti col passato. Ma è rimasto quello che era. Trova un amico, Bjørn Johnsen, ventinove anni, di mestiere commesso, ex giocatore di hockey su ghiaccio con i Manglerud Star, che giocava/gioca in prima squadra di una delle peggiori leghe di hockey del mondo civilizzato: quella norvegese, lega che Bjørn Johnsen ha dovuto abbandonare per un'incurabile lesione a un ginocchio, all'età di diciannove anni. La grande passione di Bjørn Johnsen è guardare video di sua scelta, e la partecipazione alla visione del neotrasferito AG Larsen fa nascere tra loro una forte amicizia, dal momento che costui viene preso da un senso di rispetto e perfino di ammirazione perché interpreta quelle terrificanti proiezioni di film western, d'azione, di spionaggio e polizieschi come una dichiarazione insolitamente aperta, anzi uno scambio di confidenze, da uomo a uomo. Bjørn Johnsen è sposato con Ylva, di cinque anni più giovane, e hanno un figlio, un bambino di sei anni. Il quarantaduenne burocrate della OBOS si sente subito affascinato da Ylva, sentimento che cerca disperatamente di reprimere...
Così stavano le cose. Era stato terribile per
AG scoprire in sé quel desiderio erotico per Ylva.
Non era giusto nei confronti di Bjørn! Aveva quindi
cercato di reprimerlo. Ma era come avere dentro
una forza demoniaca che lo spingeva, anche a riconoscere la realtà come in
effetti era, e fu perciò un grande sollievo quando alla fine riuscì ad
ammetterla con se stesso. Si era sentito affascinato da lei fin
dal primo giorno. Sì, sì!
|