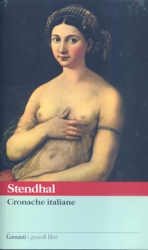
|
|
|
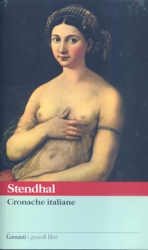
|
|
|
| << | < | > | >> |IndiceStendhal: la vita • profilo storico-critico dell'autore e dell'opera • guida bibliografica VII CRONACHE ITALIANE Vanina Vanini 3 San Francesco a Ripa 29 Vittoria Accoramboni 45 I Cenci 71 La duchessa di Palliano 103 La badessa di Castro 127 Troppo favore uccide 217 Suora Scolastica 251 Appendice 303 |
| << | < | > | >> |Pagina 3Era una sera della primavera del 182... Tutta Roma era in fermento: il duca di B***, il noto banchiere, dava un ballo nel suo nuovo palazzo di Piazza Venezia. Tutto quello che le arti d'Italia e il lusso di Parigi e Londra possono offrire di più splendido era stato riunito per rendere magnifico quel palazzo. L'affluenza di persone era enorme. Le bionde e riservate bellezze della nobile Inghilterra si erano date da fare per avere l'onore di partecipare al ballo, ed ora stavano arrivando a frotte. Le più belle donne di Roma contendevano loro la palma della bellezza. Una ragazza, senz'altro romana per gli occhi ardenti e i capelli d'ebano, entrò accompagnata dal padre, seguita dagli sguardi di tutti. Una singolare fierezza traspariva da ogni suo movimento. Gli stranieri che entravano rimanevano visibilmente colpiti dalla magnificenza di quel ballo. «Nessuna festa di nessun re d'Europa,» dicevano, «può reggere il confronto con questa.» I re non hanno un palazzo in stile romano e sono costretti a invitare le gran dame della corte; il duca di B*** invece invita solo le belle donne. Quella sera era stato particolarmente felice nei suoi inviti, e gli uomini sembravano abbagliati. Tra tante donne notevoli, sorse il problema di decidere quale fosse la più bella: per un po' la scelta rimase incerta; ma alla fine fu proclamata regina del ballo la principessa Vanina Vanini, la ragazza dai capelli neri e dagli occhi di fuoco. Subito gli stranieri e i giovani romani, abbandonando le altre sale, si affollarono in quella dove lei si trovava. Suo padre, il principe Asdrubale Vanini, aveva voluto che prima danzasse con due o tre sovrani tedeschi. Poi lei accettò gli inviti di alcuni inglesi molto belli e molto nobili; ma il loro contegno compassato la annoiò. Sembrò che si divertisse di più a tormentare il giovane Livio Savelli, che pareva proprio innamorato. Era il giovane più brillante di Roma, e per di più anche lui era un principe; ma, se gli avessero dato un romanzo da leggere, dopo venti pagine lo avrebbe gettato via dicendo che gli faceva venire il mal di testa. Agli occhi di Vanina, questo era un grave difetto. Verso la mezzanotte si diffuse per le sale una notizia che fece molta impressione. Un giovane carbonaro prigioniero nel forte di Sant'Angelo era fuggito quella sera stessa, grazie a un travestimento e, per un eccesso di audacia romanzesca, giunto all'ultimo corpo di guardia del carcere, con un pugnale aveva attaccato i soldati; a sua volta era stato ferito, gli sbirri gli stavano dando la caccia per le strade seguendo le tracce del suo sangue, e si sperava di riprenderlo. Mentre raccontavano l'episodio, don Livio Savelli, conquistato dalla grazia e dal successo di Vanina, con cui aveva appena ballato, riaccompagnandola al suo posto le disse, quasi folle d'amore: «Ma, di grazia, chi dunque potrà mai piacervi?» «Quel giovane carbonaro che è appena evaso,» gli rispose Vanina; «almeno ha fatto qualcosa di più che darsi la pena di venire al mondo.» Il principe don Asdrubale si avvicinò alla figlia. È un uomo ricchissimo che da vent'anni non fa i conti con il suo intendente, che gli va prestando le sue stesse rendite a un interesse molto alto. Se lo incontrate per la strada, potrete prenderlo per un vecchio attore; non vi accorgerete che le sue mani sono cariche di cinque o sei anelli enormi, con diamanti giganteschi. I suoi due figli si sono fatti gesuiti, e poi sono morti pazzi. Li ha dimenticati; ma lo infastidisce che la sua unica figlia, Vanina, non voglia sposarsi. Ha già diciannove anni, ed ha rifiutato i migliori partiti. Per quale ragione? La stessa per cui Silla abdicò: il suo disprezzo per i Romani. Il giorno dopo quel ballo, Vanina notò che suo padre, l'uomo più distratto del mondo e che in vita sua non si era mai preoccupato di prendere con sé una chiave, con molta attenzione chiudeva la porta di una scaletta che portava ad un appartamento al terzo piano del palazzo. Alcune finestre dell'appartamento davano su una terrazza adorna di piante d'arancio. Vanina andò a fare qualche visita in città; al suo ritorno, la vettura rientrò attraverso un cortile del retro, perché il portone del palazzo era ingombro per i preparativi di una luminaria. Vanina alzò gli occhi, e con stupore vide che una delle finestre dell'appartamento che suo padre aveva chiuso con tanta cura era aperta. Si liberò della dama di compagnia, salì nelle soffitte del palazzo e finalmente riuscì a trovare una piccola finestra a grata che dava sulla terrazza degli aranci. La finestra aperta che aveva notato era a due passi da lei. Senza dubbio quella camera era abitata; ma da chi? Il giorno dopo, Vanina riuscì a procurarsi la chiave di una porticina che dava sulla terrazza degli aranci. Piano piano si avvicinò alla finestra che era ancora aperta. Si nascose dietro una persiana. In fondo alla stanza c'era un letto, e nel letto c'era qualcuno. Il suo primo impulso fu di ritrarsi; ma scorse un abito femminile gettato su una sedia. Guardando meglio la persona distesa sul letto, vide che era bionda, e molto giovane. Non dubitò più che fosse una donna. Il vestito sulla sedia era insanguinato; c'era sangue anche sulle scarpe da donna appoggiate su un tavolo. La sconosciuta fece un movimento; Vanina vide che era ferita. Un grande panno macchiato di sangue le fasciava il petto, legato solo da nastri, ed era chiaro che quella fasciatura non era opera di un chirurgo. Vanina notò che ogni giorno, verso le quattro, suo padre si chiudeva nel proprio appartamento, e poi andava dalla sconosciuta; ridiscendeva ben presto, e saliva in carrozza per andare dalla contessa Vitelleschi. Appena era uscito, Vanina saliva sulla piccola terrazza da dove poteva scorgere la sconosciuta. La sua sensibilità era eccitata ed attratta da quella giovane donna così sfortunata; cercava di indovinarne la vicenda. Il vestito insanguinato sulla sedia sembrava lacerato da colpi di pugnale. Vanina poteva contarne gli strappi. Un giorno vide la sconosciuta più distintamente; i suoi occhi azzurri erano fissi al cielo; sembrava che stesse pregando. Quei begli occhi si riempirono presto di lacrime; la giovane principessa dovette fare uno sforzo su se stessa per non parlarle. Il giorno dopo Vanina osò nascondersi sulla terrazza prima che arrivasse suo padre. Vide don Asdrubale che entrava dalla sconosciuta: portava un piccolo paniere con delle provviste. Il principe sembrava inquieto e quasi non parlò. Parlava così piano che Vanina non riuscì a sentire le sue parole, sebbene la porta-finestra fosse aperta. Se ne andò quasi subito. «Questa povera donna deve avere dei nemici terribili,» pensò Vanina, «se mio padre, di solito così disattento, non osa confidarsi con nessuno e si preoccupa di salire ogni giorno centoventi scalini.» Una sera, mentre Vanina sporgeva pian piano la testa verso la finestra della sconosciuta, incontrò i suoi occhi, e fu così scoperta. Vanina si gettò in ginocchio ed esclamò: «Vi voglio bene, vi sono amica.» La sconosciuta le fece cenno di entrare. «Vi devo delle scuse,» esclamò Vanina, «la mia stupida curiosità vi ha certo offeso! Vi giuro che manterrò il segreto, e, se lo vorrete, non tornerò mai più.» «E chi potrebbe non essere felice di vedervi?» disse la sconosciuta. «Abitate in questo palazzo?» «Certo,» rispose Vanina. «Ma vedo che non mi conoscete: sono Vanina, figlia di don Asdrubale.» La sconosciuta la guardò stupita, arrossì, e aggiunse: «Degnatevi di farmi sperare che tornerete ogni giorno; ma preferirei che il principe non sapesse delle vostre visite.» Il cuore di Vanina batteva forte; i modi della sconosciuta le sembravano molto distinti. Questa povera giovane aveva certo offeso qualche potente; forse in un momento di gelosia aveva ucciso l'amante? Vanina non riusciva a trovare una causa volgare alla sua disgrazia. La sconosciuta le disse che era stata ferita alla spalla da un colpo di pugnale penetrato fino al petto, che la faceva soffrire molto. Spesso si trovava la bocca piena di sangue. «E non avete un chirurgo!» esclamò Vanina. «Sapete bene che a Roma,» disse la sconosciuta, «i chirurghi sono costretti a fare alla polizia un rapporto esatto su tutte le ferite che curano. Il principe stesso si degna di fasciarmi le ferite con questa benda.» Con una grazia perfetta la sconosciuta evitava di commuoversi per la propria disgrazia; Vanina la amava alla follia. Una cosa tuttavia stupì molto la giovane principessa, e cioè che durante una conversazione tanto seria la sconosciuta trattenesse a fatica un'improvvisa voglia di ridere. «Sarei felice,» le disse Vanina, «di conoscere il vostro nome.» «Mi chiamo Clementina.» «Ebbene, cara Clementina, tornerò a trovarvi domani alle cinque.» L'indomani Vanina trovò la sua nuova amica che stava molto male. «Vado a chiamare un chirurgo,» disse Vanina abbracciandola. «Preferirei morire,» disse la sconosciuta. «Come potrei compromettere i miei benefattori?» «Il chirurgo di monsignor Savelli-Catanzara, il governatore di Roma, è figlio di un nostro domestico,» insisté Vanina; «ci è fedele e per la sua posizione non teme nessuno. Mio padre non tiene conto della sua fedeltà; vado a farlo chiamare.» «Non voglio nessun chirurgo,» gridò la sconosciuta con una vivacità che stupì Vanina. «Venite a trovarmi, e se Dio deve chiamarmi a sé morirò felice tra le vostre braccia.» Il giorno dopo la sconosciuta stava ancora peggio. «Se mi volete bene,» disse Vanina lasciandola, «accettate un chirurgo.» «Se viene, la mia felicità svanisce.» «Vado a farlo chiamare,» ribatté Vanina. Senza dire niente, la sconosciuta la trattenne, e le prese la mano che coprì di baci. Seguì un lungo silenzio, la sconosciuta aveva le lacrime agli occhi. Poi lasciò la mano di Vanina, e con l'aria di chi sta per morire le disse: «Devo farvi una confessione. L'altro ieri ho mentito quando ho detto che mi chiamavo Clementina; sono uno sventurato carbonaro...» Vanina, stupita, spinse indietro la sedia e si alzò. «Sento,» continuò il carbonaro, «che questa confessione mi farà perdere il solo bene che mi tiene attaccato alla vita; ma ingannarvi è indegno di me. Mi chiamo Pietro Missirilli; ho diciannove anni; mio padre è un povero chirurgo di Sant'Angelo in Vado, e io sono carbonaro. Hanno scoperto la nostra vendita; in catene, dalla Romagna sono stato portato a Roma. Sepolto in una segreta illuminata giorno e notte da una lampada, vi ho passato tredici mesi. Un'anima caritatevole ha avuto l'idea di salvarmi. Mi hanno vestito da donna. Mentre stavo uscendo dalla prigione e passavo davanti alle guardie dell'ultimo portone, una di loro ha insultato i carbonari, e io gli ho dato uno schiaffo. Vi assicuro che non è stata una vana bravata, ma solo un gesto impulsivo. Inseguito nella notte per le strade di Roma, dopo questa imprudenza, ferito da colpi di baionetta, ormai quasi privo di forze, salgo in una casa la cui porta era aperta; sento i soldati dietro di me, salto in un giardino; cado a pochi passi da una donna che stava passeggiando.» «La contessa Vitelleschi! l'amica di mio padre,» disse Vanina. «Come! Lei ve lo ha detto?» esclamò Missirilli. «Comunque sia, questa signora, il cui nome non deve essere mai pronunciato, mi salvò la vita. Mentre i soldati entravano in casa sua per prendermi, vostro padre mi faceva uscire nella sua carrozza. Mi sento molto male. Da qualche giorno questo colpo di baionetta alla spalla mi impedisce di respirare. Sto per morire, e disperato, perché non vi vedrò più.» Vanina aveva ascoltato con impazienza; uscì rapidamente: Missirilli non scorse nessuna pietà in quegli occhi così belli, ma solo l'espressione di un carattere altero che era stato ferito. Nella notte giunse un chirurgo; era solo, Missirilli si sentiva disperato; temeva di non rivedere più Vanina. Fece qualche domanda al chirurgo, che lo curò senza rispondere. Lo stesso silenzio nei giorni seguenti. Gli occhi di Pietro non lasciavano la finestra della terrazza da cui Vanina era solita entrare; si sentiva molto infelice. Una volta, verso mezzanotte, gli sembrò di scorgere qualcuno nell'ombra della terrazza: era Vanina? Ogni notte Vanina andava ad appoggiare la guancia contro i vetri della finestra del giovane carbonaro. «Se gli parlo,» si diceva, «sono perduta! no, non devo rivederlo mai più!» Presa questa decisione, ricordava suo malgrado l'affetto per quel giovane, quando così stupidamente lo credeva una donna. Dopo un'intimità così dolce, bisognava dunque dimenticarlo! Nei suoi momenti più ragionevoli, Vanina era spaventata dal cambiamento delle proprie idee. Da quando Missirilli si era rivelato, tutte le cose cui aveva l'abitudine di pensare si erano come ricoperte di un velo ed apparivano solo in lontananza. Una settimana non era ancora passata che Vanina, pallida e tremante, entrò nella stanza del giovane carbonaro insieme con il chirurgo. Veniva a dirgli che era opportuno convincere il principe a farsi sostituire da un domestico. Rimase pochi secondi; ma qualche giorno dopo tornò ancora con il chirurgo, per umanità. Una sera, benché Missirilli stesse molto meglio e Vanina non avesse più da temere per la sua vita, osò andarci sola. Vedendola, Missirilli si sentì al colmo della felicità, ma si preoccupò di nascondere il proprio amore; prima di tutto, non voleva venire meno alla dignità che si conviene a un uomo. Vanina, che era entrata da lui con il volto coperto di rossore, e temendo dichiarazioni d'amore, rimase sconcertata dal tono di amicizia nobile e devota, ma assai poco tenera, con cui lui la accolse. Se ne andò senza che egli cercasse di trattenerla. Qualche giorno dopo, quando ritornò, stesso comportamento, stesse assicurazioni di devozione rispettosa e di riconoscenza eterna. Non dovendosi più preoccupare di porre un freno ai trasporti del giovane carbonaro, Vanina si chiese se non fosse lei sola ad amarlo. Questa ragazza, fino ad allora così superba, sentì con amarezza tutta la forza della propria follia. Ostentò allegria ed anche freddezza, diradò le sue visite, ma non riuscì a non vedere del tutto il giovane malato. Missirilli, ardendo d'amore ma pensando alla propria nascita oscura e alla propria dignità, si era ripromesso di evitare di parlare d'amore, a meno che Vanina non rimanesse otto giorni senza vederlo. L'orgoglio della giovane principessa lottò palmo a palmo. «Ebbene!» si disse infine, «se lo vedo è per me, per il mio piacere, e mai gli confesserò il sentimento che mì ispira.» Faceva lunghe visite a Missirilli, che le parlava come in presenza di venti persone. Una sera, dopo aver passato la giornata a detestarlo ed a ripromettersi di essere con lui ancora più fredda e severa del solito, Vanina gli disse che lo amava. Presto non ebbe più nulla da rifiutargli. Se la sua follia fu grande, bisogna però riconoscere che Vanina si sentì immensamente felice. Missirilli non pensò più a ciò che credeva di dovere alla propria dignità di uomo; amò come si ama per la prima volta a diciannove anni e in Italia. Provò tutti gli scrupoli dell'amore-passione, fino a confessare alla giovane principessa così fiera la tattica che aveva impiegato per farsi amare. Era stupito della propria immensa felicità. Quattro mesi passarono molto in fretta. Un giorno, il chirurgo restituì la libertà al suo malato. «E adesso cosa faccio?» pensò Missirilli; «restare nascosto nella casa di una delle più belle ragazze di Roma? E i vili tiranni che mi hanno tenuto in prigione per tredici mesi senza lasciarmi vedere la luce del giorno crederanno di avermi piegato! O Italia, sei davvero sventurata se i tuoi figli ti abbandonano per così poco!» Vanina non dubitava che la più grande fortuna di Pietro fosse di starle sempre accanto; lo vedeva troppo felice; ma una frase del generale Bonaparte risuonava amaramente nell'animo del giovane, e influiva su tutta la sua condotta nei confronti delle donne. Nel 1796, mentre il generale Bonaparte stava lasciando Brescia, le autorità municipali che lo accompagnavano alla porta della città gli dissero che i bresciani amavano la libertà più di tutti gli altri italiani. «Sì,» rispose lui, «amano parlarne alle loro amanti.» Assai imbarazzato, Missirilli disse a Vanina: «Appena sarà notte, dovrò uscire.» «Cerca dì rientrare nel palazzo prima dell'alba; ti aspetterò.» «All'alba sarò a molte miglia da Roma.» «Benissimo,» disse Vanina con freddezza, «e dove andrai?» «In Romagna, a vendicarmi.» «Poiché sono ricca,» continuò Vanina con estrema calma, «spero che accetterai da me armi e denaro.» Missirilli la guardò per qualche istante senza battere ciglio; poi, gettandosi nelle sue braccia: «Anima della mia vita,» le disse, «mi farai dimenticare tutto, anche il mio dovere. Ma più il tuo animo è nobile e più devi capirmi.» Vanina pianse molto, e rimasero d'accordo che lui avrebbe lasciato Roma solo due giorni dopo. «Pietro,» gli disse l'indomani, «mi hai detto spesso che un uomo molto noto, un principe romano per esempio, che potesse disporre di molto denaro, sarebbe in grado di rendere i più grandi servigi alla causa della libertà, qualora l'Austria si trovasse impegnata lontano da noi, in qualche grande guerra.» «Certamente,» disse Pietro, stupito. «Bene! sei un uomo coraggioso; ti manca soltanto un'alta posizione; ti offro la mia mano e duecentomila lire di rendita. Ci penso io ad ottenere il consenso di mio padre.» Pietro si gettò ai suoi piedi; Vanina era raggiante di gioia. «Ti amo appassionatamente,» le disse, «ma io sono un povero servitore della mia patria; e più l'Italia è sventurata, più devo rimanerle fedele. Per ottenere il consenso di don Asdrubale, dovrei recitare per molti anni una commedia vergognosa. Non posso accettare, Vanina.» Missirilli si affrettò ad impegnarsi con queste parole. Il coraggio gli stava venendo meno. «La mia sventura,» esclamò, «è che ti amo più della vita, e per me lasciare Roma è il peggiore dei supplizi. Ah! Perché l'Italia non è libera dai barbari! Con quale gioia mi imbarcherei con te per andare a vivere in America.» Vanina era raggelata. Il rifiuto della sua mano aveva sorpreso il suo orgoglio; ma presto si gettò nelle braccia di Missirilli. «Non mi sei mai piaciuto tanto,» esclamò. «Sì, mio piccolo chirurgo di campagna, sarò tua per sempre. Sei un grande uomo, come i nostri antichi Romani.» | << | < | > | >> |Pagina 71Il don Giovanni di Molière è senza dubbio galante, ma innanzi tutto uomo di mondo; prima di abbandonarsi all'inclinazione irresistibile che lo spinge verso le belle donne, tiene a conformarsi a un certo modello ideale, vuol essere fra tutti il più ammirato alla corte di un giovane re galante e spiritoso. Il don Giovanni di Mozart è già più vicino alla natura, e meno francese, pensa di meno all' opinione altrui; non si preoccupa, prima di tutto, di parestre, di far bella figura, come dice il barone di Foeneste del d'Aubigné. Abbiamo solo due ritratti del don Giovanni italiano, quale dovette mostrarsi in quel bel paese nel XVI secolo, all'alba della rinascente civiltà. Di questi due ritratti, ce n'è uno che non posso assolutamente far conoscere, il nostro secolo è troppo formalista; gioverà ricordare le famose parole che ho sentito ripetere tante volte da lord Byron: This age of cant. Quest'ipocrisia così noiosa e che non inganna nessuno ha l'immenso vantaggio di offrire qualche argomento di conversazione agli sciocchi: si scandalizzano perché si è osato dire la tal cosa; perché si è osato ridere della talaltra, ecc. Il suo svantaggio è di restrigere infinitamente il campo della storia. Se, il lettore ha la bontà di permettermelo, gli presenterò, in tutta umiltà, una notizia storica sul secondo dei don Giovanni di cui è possibile parlare nel 1837; si chiamava Francesco Cenci. Perché il don Giovanni possa esistere, bisogna che nel mondo vi sia l'ipocrisia.. Don Giovanni sarebbe stato un effetto senza causa nell'antichità; la religione era una festa, esortava gli uomini al piacere; come avrebbe potuto condannare degli esseri dediti unicamente ad un certo piacere? Solo il governo invitava ad astenersi; proibiva quanto poteva nuocere alla patria, cioè al beninteso interesse di tutti, e non quel che può nuocere all'individuo che agisce. Ad Atene, chiunque avesse la passione delle donne e molto denaro poteva quindi essere un don Giovanni, nessuno ci trovava da ridire; nessuno pensava che questa vita è una valle di lacrime, e che è cosa meritoria infliggersi delle sofferenze. Non credo che il don Giovanni ateniese potesse arrivare fino al delitto così rapidamente come il don Giovanni delle monarchie moderne; gran parte del suo piacere consiste nello sfidare l'opinione pubblica, mentre, da giovane, ha esordito immaginando di sfidare soltanto l'ipocrisia. Violare le leggi, nella monarchia tipo Luigi XV, tirare una fucilata a un carpentiere e farlo ruzzolare giù dal tetto, non è forse una dimostrazione che si vive nella familiarità del principe, che si ha un'ottima educazione, e ci si burla altamente del giudice? Burlarsi del giudice non è forse il primo passo, la prima prova del piccolo don Giovanni al suo debutto? Da noi, le donne non sono più di moda, per questo i don Giovanni sono rari; ma quando ce n'erano, cominciavano sempre col cercar piaceri molto naturali, pur vantandosi di sfidare quelle che, nella religione dei contemporanei, sembravano loro delle idee non fondate sulla ragione. Soltanto più tardi, quando comincia a pervertirsi, il don Giovanni trova una squisita voluttà nello sfidare le opinioni che sembrano anche a lui giuste e ragionevoli. Questo passaggio doveva essere molto difficile nell'antichità, e solo ai tempi degli imperatori romani, dopo Tiberio e Capri, si trovano dei libertini che amano la corruzione per se stessa, cioè per il piacere di sfidare le ragionevoli opinioni dei loro contemporanei. Sicché è alla religione cristiana che va attribuita, a mio avviso, la possibilità del personaggio satanico di don Giovanni. Fu senza dubbio questa religione a insegnare al mondo che un povero schiavo, un gladiatore, aveva un'anima assolutamente eguale, in potenza, a quella dello stesso Cesare; si deve ad essa, perciò, la comparsa dei sentimenti più delicati; io non dubito, del resto, che presto o tardi questi sentimenti si sarebbero fatti strada in seno ai popoli. L' Eneide è già molto più tenera dell' Iliade. La dottrina di Gesù era quella dei filosofi arabi suoi contemporanei; l'unica novità che sia comparsa nel mondo in seguito ai principi predicati da san Paolo, è un corpo sacerdotale assolutamente separato dal resto dei cittadini, anzi con opposti interessi. Questo corpo si dedicò in modo esclusivo a coltivare e rafforzare il sentimento religioso; inventò illusioni e abitudini per commuovere gli spiriti d'ogni classe sociale, dal rozzo pastore al vecchio cortigiano navigato; seppe legare il suo ricordo alle dolci impressioni della prima infanzia; non lasciò passare la più piccola epidemia o la più piccola catastrofe senza approfittarne per raddoppiare la paura e il sentimento religioso, o almeno per costruire una bella chiesa, come la Salute a Venezia. L'esistenza di questo corpo produsse un mirabile evento: san Leone papa, che resistette senza forza fisica al feroce Attila e alle sue schiere di barbari che avevano già atterrito la Cina, la Persia e le Gallie. Così, la religione, come quel potere assoluto temperato da canzonette che si chiamava «monarchia francese», ha prodotto fenomeni singolari che il mondo, forse, non avrebbe mai veduto se fosse stato privato di queste due istituzioni. Fra questi fenomeni buoni o cattivi, ma sempre singolari e curiosi, e che avrebbero stupito Aristotele, Polibio, Augusto e gli altri grandi ingegni dell'antichità, pongo senza esitare il carattere tipicamente moderno di don Giovanni. È, secondo me, un prodotto delle istituzioni ascetiche dei papi venuti dopo Lutero; perché Leone X e la sua corte (1506) seguivano press'a poco gli stessi principi della religione ateniese. Il Don Giovanni di Molière fu rappresentato all'inizio del regno di Luigi XIV, il 15 febbraio 1665; questo sovrano non era ancora bigotto, e tuttavia la censura ecclesiastica fece sopprimere la scena del povero nella foresta. La censura, per rafforzarsi un po', voleva persuadere il giovane re, così prodigiosamente ignorante, che la parola giansenista era sinonimo di repubblicano. L'originale è di uno Spagnolo, Tirso de Molina; una compagnia italiana ne recitava un'imitazione a Parigi verso il 1664, e faceva furore. È probabilmente la commedia più rappresentata nel mondo. Il fatto è che vi compaiono il diavolo e l'amore, l'inferno e l'esaltata passione per una donna, cioè quanto vi è di più terribile e di più dolce per tutti gli uomini che siano appena un po' al di sopra dello stato selvaggio. Non sorprende che la figura di don Giovanni sia stata introdotta nella letteratura da un poeta spagnolo. L'amore occupa un gran posto nella vita di quel popolo; laggiù, è una passione vera, che si fa sacrificare, d'imperio, tutte le altre, e perfino, chi l'avrebbe detto? la vanità! Lo stesso avviene in Germania e in Italia. A ben vedere, solo la Francia si è completamente liberata da tale passione, che fa commettere tante follie agli stranieri: per esempio, sposare una ragazza povera, col pretesto che è bella e se ne è innamorati. In Francia le ragazze prive di bellezza non sono prive di ammiratori; siamo gente avveduta. Altrove, sono ridotte a farsi monache, e per questo i conventi sono indispensabili in Spagna. Le ragazze non hanno dote in quel paese, legge che ha mantenuto il trionfo dell'amore. In Francia, l'amore non si è forse rifugiato al quinto piano, cioè tra le ragazze che non si sposano con la mediazione del notaio di famiglia? Non è il caso di parlare del don Giovanni di lord Byron, è soltanto un Faublas, un bel giovane insignificante sul quale piovono inverosimili fortune di tutti i generi. È in Italia, quindi, e solo nel XVI secolo, che dovette apparire, per la prima volta, questo carattere singolare. In Italia, dove nel XVI secolo una principessa diceva, assaporando con delizia un gelato, la sera di una giornata molto calda: Peccato che non sia un peccato! Questo sentimento costituisce, secondo me, la base del carattere di don Giovanni, e, come si vede, la religione cristiana gli è necessaria. A questo proposito un autore napoletano esclama: «È forse una cosa da nulla sfidare il cielo, e credere che in quello stesso momento il cielo può ridurvi in cenere? Da qui l'estrema voluttà, a quanto si dice, di avere un'amante religiosa, di una religiosità ardente, che sa benissimo di far male, e chiede perdono a Dio con passione, così come pecca con passione». Immaginiamo un cristiano estremamente perverso, nato a Roma nel momento in cui il severo Pio V aveva appena ripristinato o inventato una serie di pratiche minuziose assolutamente estranee alla semplice morale che chiama virtù solo ciò che è utile agli uomini. Un'inquisizione inesorabile, talmente inesorabile che in Italia durò poco, e dovette rifugiarsi in Spagna, era stata proprio allora rafforzata e faceva paura a tutti. Per qualche anno, si comminarono gravissime pene per l'inosservanza o il vilipendio pubblico di quelle piccole pratiche minuziose, innalzate al rango dei doveri più sacri della religione; quel perverso Romano avrà alzato le spalle vedendo la massa dei cittadini tremare davanti alle terribili leggi dell'inquisizione. «Ebbene!» si sarà detto, «sono l'uomo più ricco di Roma, capitale del mondo; sarò anche il più coraggioso; sbeffeggerò pubblicamente tutto ciò che la gente rispetta, e che è così lontano da quel che si deve rispettare.» Perché un don Giovanni, per essere tale, dev'essere uomo di coraggio e possedere lo spirito lucido e vivo che fa veder chiaro nei moventi delle azioni umane. Francesco Cenci si sarà detto: «Con quali azioni eloquenti, io Romano, nato a Roma nel 1527, proprio nei sei mesi in cui i soldati luterani del conestabile di Borbone vi commisero, contro le cose sante, le più atroci profanazioni; con quali azioni potrei far risaltare il mio coraggio, e procurarmi, nel modo più completo, il piacere di sfidare l'opinione pubblica? Come potrei stupire i miei sciocchi contemporanei? Come potrei procurarmi il vivissimo piacere di sentirmi diverso da tutto questo volgo?» Non era neppur concepibile per un Romano, e un Romano del medioevo, limitarsi a semplici parole. In nessun paese le fanfaronate sono più disprezzate che in Italia. L'uomo che poteva parlar così a se stesso si chiamava Francesco Cenci: fu ucciso sotto gli occhi di sua figlia e di sua moglie, il 15 settembre 1598. Nulla di amabile ci resta di questo don Giovanni, il suo carattere non fu affatto addolcito e sminuito dal proposito di essere, prima di tutto, uomo di mondo, come il don Giovanni di Molière. Pensava agli altri uomini solo per affermare la sua superiorità su di essi, servirsene per i suoi disegni o odiarli. Il don Giovanni non ricava mai piacere dalle simpatie, dalle dolci fantasticherie o illusioni di un cuore tenero. Ha bisogno, prima di tutto, di piaceri che siano trionfi, che possano esser veduti dagli altri, che non possano essere negati; gli ci vuole la lista spiegata dall'insolente Leporello davanti agli occhi della triste Elvira. Il don Giovanni romano si è ben guardato dall'insigne goffaggine di fornire la chiave del suo carattere, e di far confidenze a un lacchè, come il don Giovanni di Molière; è vissuto senza confidenti, e ha pronunciato soltanto le parole utili per la realizzazione dei suoi progetti. Nessuno poté vedere in lui quei momenti di autentica tenerezza e di seducente allegria che ci fanno perdonare al don Giovanni di Mozart; in una parola, il ritratto che ora vi presenterò è atroce. Per mia scelta, non avrei descritto questo carattere: mi sarei accontentato di studiarlo, perché è più orribile che bizzarro; ma confesso che mi è stato chiesto da certi compagni di viaggio ai quali non potevo rifiutare nulla. Nel 1823, ebbi la fortuna di visitare l'Italia con persone amabili, e che non dimenticherò mai; come loro fui affascinato dal meraviglioso ritratto di Beatrice Cenci, che si vede a Roma, a palazzo Barberini. | << | < | > | >> |Pagina 103Palermo, 22 luglio 1838 Non sono un naturalista, e la mia conoscenza del greco è assai mediocre; lo scopo principale del mio viaggio in Sicilia non era quello di osservare i fenomeni dell'Etna, né di far luce, per me o per gli altri, su' tutto ciò che gli antichi autori greci hanno detto dell'isola. Cercavo innanzi tutto il piacere degli occhi, che è grande in questo singolare paese. Dicono che somigli all'Africa; ma, per me, è certo che somiglia all'Italia solo per le sue divoranti passioni. Dei Siciliani si può ben dire che la parola impossibile non esiste per loro, non appena sono infiammati dall'amore o dall'odio, e l'odio, in questo bel paese, non sorge mai da motivi d'interesse. Ho notato che in Inghilterra, e soprattutto in Francia, si parla spesso della passione italiana, della passione sfrenata che esisteva in Italia nei secoli XVI e XVII. Ai giorni nostri questa bella passione è morta, definitivamente, nelle classi che hanno subito l'influenza delle usanze francesi e delle mode di Parigi o di Londra. Si potrebbe osservare che, dall'epoca di Carlo V (1530), Napoli, Firenze, e anche Roma, imitarono un po' i costumi spagnoli; ma quelle abitudini sociali così nobili non erano forse fondate sul profondo rispetto che ogni uomo degno di questo nome deve ai propri sentimenti? Lungi dal bandire l'energia, esse l'accentuavano, mentre la prima regola dei fatui imitatori del duca di Richelieu, verso il 1760, era di non sembrar commossi di nulla. La massima dei dandies inglesi, che oggi vengono copiati a Napoli a preferenza dei damerini francesi, non è quella di sembrare annoiati di tutto, superiori a tutto? Sicché la passione italiana, da un secolo a questa parte, non esiste più nella buona società di quel paese. Per farmi un'idea di questa passione italiana, di cui i nostri romanzieri parlano con tanta sicurezza, sono stato obbligato a interrogare la storia; ma la grande storia, scritta da uomini di talento, e spesso troppo maestosa, non dice quasi nulla di questi dettagli. Essa non si degna di annotare certe follie, a meno che siano commesse da re o da principi. Ho dovuto ricorrere alla storia locale di ogni città; ma sono rimasto spaventato dall'abbondanza dei materiali. Certe piccole città vi presentano con fierezza la loro storia in tre o quattro volumi stampati in 4°, e in sette o otto volumi manoscritti; questi, quasi indecifrabili, costellati di abbreviazioni, con caratteri di forma strana, nei momenti più interessanti sono pieni di modi dire dialettali, inintelligibili venti leghe più in là. Perché in tutta questa bella Italia, dove l'amore ha disseminato tanti avvenimenti tragici, solo in tre città, Firenze, Siena e Roma, si parla press'a poco come si scrive; dappertutto altrove la lingua scritta è a mille miglia dalla lingua parlata. La cosiddetta passione italiana, cioè la passione che cerca di soddisfarsi, e non già di dare al vicino un'idea magnifica della nostra persona, comincia con la rinascita della società, nel XII secolo, e si estingue, almeno nelle classi più elevate, verso il 1734. A quell'epoca, i Borboni vengono a regnare a Napoli nella persona di don Carlos, figlio di una Farnese, sposata, in seconde nozze, a Filippo v, il triste nipote di Luigi XIV, così intrepido sul campo di battaglia, così annoiato, e così appassionato di musica. È noto che per ventiquattro anni il sublime castrato Farinelli gli cantò tutti i giorni le sue tre arie predilette, sempre le stesse. Uno spirito filosofico potrebbe trovare curiosi i particolari di una passione vissuta a Roma o a Napoli, ma confesserò che nulla mi pare più assurdo di quei romanzi che danno nomi italiani ai loro personaggi. Non è convenuto che le passioni mutano ogni volta che ci si avvicina di cento leghe al Nord? L'amore è forse lo stesso a Marsiglia e a Parigi? Tutt'al più si può dire che i paesi soggetti da lungo tempo allo stesso governo, mostrano nelle abitudini sociali una specie di somiglianza esteriore. I paesaggi, come le passioni, come la musica, cambiano anch'essi appena ci si spinge di tre o quattro gradi verso il Nord. Un paesaggio napoletano sembrerebbe assurdo a Venezia, se non fosse cosa convenuta, anche in Italia, ammirare le bellezze naturali di Napoli. A Parigi, facciamo di meglio: crediamo che l'aspetto delle foreste e delle pianure coltivate sia lo stesso a Napoli e a Venezia, e vorremmo che il Canaletto, per esempio, adoprasse assolutamente gli stessi colori di Salvator Rosa. Il colmo del ridicolo non è forse una dama inglese dotata di tutte le perfezioni della sua isola, ma considerata incapace di dipingere l' odio e l' amore di quell'isola stessa: la signora Ann Radcliffe, che dà nomi italiani e grandi passioni ai personaggi del suo celebre romanzo Il confessionale dei penitenti neri? Non cercherò affatto di abbellire la semplicità, la rudezza talora urtanti del racconto fin troppo realistico che sottopongo all'indulgenza del lettore; per esempio, tradurrò esattamente la risposta della duchessa di Palliano alla dichiarazione d'amore di suo cugino Marcello Capece. Questa monografia della famiglia si trova, non so perché, alla fine del secondo volume di una storia manoscritta di Palermo, sulla quale non posso dare nessuna precisazione. Il racconto, che ho molto abbreviato, a malincuore (ho soppresso una quantità di particolari caratteristici), comprende le ultime vicende della disgraziata famiglia Carafa, più che la storia avvincente di una sola passione. La vanità letteraria mi dice che forse non mi sarebbe stato impossibile accrescere l'interesse di varie situazioni, sviluppando di più, cioè indovinando e raccontando al lettore, nei particolari, i sentimenti dei personaggi. Ma io, giovane Francese, nato a nord di Parigi, sono ben certo d'indovinare ciò che sentivano quelle anime italiane dell'anno 1559? Tutt'al più posso sperare d'indovinare quel che può apparire elegante e piccante ai lettori francesi del 1838. Questo modo appassionato di sentire che regnava in Italia verso il 1559 voleva azioni e non parole. Si troveranno quindi pochissimi dialoghi nei racconti che seguono. È uno svantaggio per questa traduzione, abituati come siamo alle lunghe conversazioni dei nostri personaggi romanzeschi; per loro una conversazione è una battaglia. La storia per cui reclamo tutta l'indulgenza del lettore mostra una singolare particolarità introdotta dagli Spagnoli nei costumi italiani. Non sono mai uscito dal mio ruolo di traduttore. Il calco fedele dei modi di sentire del XVI secolo, e anche dei modi di raccontare dello storico che, secondo ogni apparenza, era un gentiluomo appartenente al seguito della sventurata duchessa di Palliano, rappresenta, a mio avviso, il pregio principale di questa storia tragica, se mai essa ne ha uno.
La più rigida etichetta spagnola regnava alla
corte
del duca di Palliano. Notate che ogni cardinale, ogni principe romano
aveva una corte simile, e potrete farvi un'idea dello spettacolo che presentava
nel 1559 l'alta società della città di Roma.
Non dimenticate che era il tempo in cui il re Filippo II,
avendo bisogno per un suo intrigo del suffragio di due cardinali, diede a
ciascuno di essi 200.000 franchi di rendita in benefici ecclesiastici. Roma,
benché priva di un esercito temibile, era la capitale del mondo. Parigi, nel
1559, era una città di barbari abbastanza inciviliti.
Giampietro Carafa, sebbene appartenente a una delle più nobili famiglie del regno di Napoli, era di modi aspri, rudi, violenti e in tutto degni di un pecoraio. Prese l' abito lungo (talare) e in giovane età se ne andò a Roma, dove godette del favore di suo cugino Oliviero Carafa, cardinale e arcivescovo di Napoli. Alessandro VI, quel grand'uomo, che sapeva tutto e poteva tutto, lo fece suo cameriere (press'a poco quel che noi chiameremmo, nel linguaggio attuale. un ufficiale d'ordinanza). Giulio II lo nominò arcivescovo di Chieti; papa Paolo lo fece cardinale, e infine, il 23 maggio 1555, dopo contese e dispute tremende fra i cardinali rinchiusi in condave, fu creato papa col nome di Paolo IV: aveva allora settantotto anni. Gli stessi che l'avevano appena chiamato al trono di san Pietro fremettero ben presto, pensando alla durezza e alla fede indomita, inesorabile, del padrone che si erano dati. La notizia di questa elezione inattesa rivoluzionò Napoli e Palermo. In pochi giorni Roma vide arrivare un gran numero di membri dell'illustre famiglia Carafa. Tutti furono sistemati; ma, com'è naturale, il papa favorì in modo particolare i suoi tre nipoti, figli del conte di Montorio, suo fratello. Don Juan, il primogenito, già sposato, fu fatto duca di Palliano. Questo ducato, strappato a Marcantonio Colonna, cui apparteneva, comprendeva molti villaggi e cittadine. Don Carlos, il secondo dei nipoti di Sua Santità, era cavaliere di Malta e aveva fatto la guerra; fu creato cardinale, legato di Bologna e primo ministro. Era un uomo molto risoluto; fedele alle tradizioni della sua famiglia, osò odiare il re più potente del mondo (Filippo II, re di Spagna e delle Indie), e gli diede prova del suo odio. In quanto al terzo nipote del nuovo papa, don Antonio Carafa, siccome era sposato, il papa lo fece marchese di Montebello. Infine, volle dare in moglie a Francesco, delfino di Francia e figlio del re Enrico II, una figlia avuta da suo fratello in seconde nozze; Paolo IV pretendeva di assegnarle in dote il regno di Napoli, togliendolo a Filippo II, re di Spagna. La famiglia Carafa odiava quel potente sovrano, il quale, approfittando dei suoi errori, riuscì a sterminarla, come vedrete.
Da quando era salito al trono di san Pietro, il più potente
del mondo, che a quell'epoca eclissava perfino l'illustre monarca della Spagna,
Paolo IV, come si è visto poi anche nella maggior parte dei suoi successori,
dava l'esempio di tutte le virtù. Fu un gran papa e un gran santo; si sforzò di
riformare gli abusi nella Chiesa e di evitare in tal modo il concilio generale,
che da ogni parte veniva richiesto alla corte di Roma, e
che una saggia politica non consentiva di accordare.
|