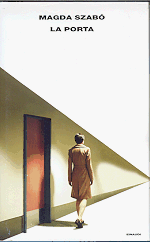
|
|
|
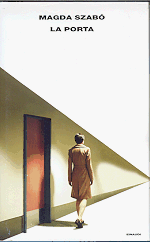
|
|
|
| << | < | > | >> |Pagina 3La portaSogno raramente. E se capita, mi risveglio di soprassalto in un bagno di sudore. In questi casi, poi, mi abbandono nel letto e medito sul potere magico e inesorabile delle notti aspettando che il cuore si calmi. Da bambina, o da ragazza, non facevo sogni, né belli né brutti, è la vecchiaia che mi trasporta senza sosta un orrore impastato di detriti del passato, che mi travolge con la sua massa via via sempre piú compatta, sempre piú opprimente, un orrore piú tragico di ogni esperienza reale perché le cose che vedo nell'incubo non le ho mai vissute sul serio. E mi risveglio urlando. I miei sogni sono assolutamente uguali, tessuti di visioni ricorrenti. Sogno sempre la stessa cosa, sono in piedi, in fondo alle nostre scale, nell'androne, mi trovo sul lato interno del portone con il telaio d'acciaio, il vetro infrangibile rinforzato di tessuto metallico, e cerco di aprirlo. Fuori, in strada, si è fermata un'ambulanza, attraverso il vetro intravedo le silhouette iridescenti degli infermieri, hanno volti gonfi, innaturalmente grandi, contornati da un alone come la luna. La chiave gira nella serratura, ma i miei sforzi sono vani, non riesco ad aprire il portone, eppure so che devo far entrare gli infermieri altrimenti arriveranno troppo tardi dal mio malato. La serratura è bloccata, la porta non si muove, come se fosse saldata al telaio d'acciaio. Grido, invoco aiuto, ma nessuno degli inquilini che abitano sui tre piani della casa mi ascolta, non possono farlo perché - me ne rendo conto - boccheggio a vuoto come un pesce, e quando capisco che non solo non riesco ad aprire il portone ai soccorritori, ma sono anche diventata muta, il terrore del sogno raggiunge il culmine. A questo punto vengo risvegliata dalle mie stesse urla, accendo la luce, provo a dominare il senso di soffocamento che mi assale sempre dopo il sogno, intorno ci sono i mobili conosciuti della nostra stanza da letto, sopra il letto l'iconostasi di famiglia, i miei avi parricidi che indossano i dolman con gli alamari secondo la moda del barocco ungherese o del biedermeier, vedono tutto, capiscono tutto, sono gli unici testimoni delle mie notti, sanno quante volte sono corsa ad aprire la porta agli infermieri, all'ambulanza, quante volte ho provato a immaginare, mentre udivo filtrare dal portone aperto il passo felpato di un gatto, o lo stormire delle fronde, invece dei noti rumori diurni delle strade ora ammutolite, che cosa succederebbe se un giorno lottassi invano e la chiave non girasse nella serratura. I ritratti sanno tutto, in special modo ciò che mi sforzo di dimenticare, che ormai non è piú sogno. Una sola volta nella mia vita, nella realtà e non nell'anemia cerebrale del sonno, una porta si spalancò davanti a me, la porta di una persona che voleva difendere a ogni costo la propria solitudine e la propria misera impotenza, che non avrebbe mai aperto nemmeno se le fosse crollato addosso il tetto in fiamme. Solo io avevo il potere di vincere quella serratura: la donna che girò la chiave aveva piú fede in me che in Dio, e io stessa, in quell'istante fatale, credetti di essere saggia, riflessiva, buona, razionale, come Dio. Ci sbagliammo entrambe, lei che si fidò di me, io che confidai troppo in me stessa. Ma ormai poco importa, perché ciò che è accaduto non si può rimediare. Vengano dunque, di tanto in tanto, queste Erinni che indossano calzature sanitarie rialzate come coturni e copricapi da infermieri sulle maschere tragiche, si dispongano intorno al mio letto, brandiscano i miei sogni come fossero spade sguainate. Ogni sera spengo la luce, e le aspetto, mi preparo a sentire nel sonno lo squillo improvviso del campanello, il suono che annuncia un orrore indicibile e comincia a trascinarmi verso il portone che non si apre. Nella mia fede non esiste la confessione individuale, noi riconosciamo di essere peccatori per bocca del pastore e di meritare il castigo perché abbiamo infranto in ogni modo possibile i comandamenti. E riceviamo il perdono senza che Dio esiga da noi spiegazioni o particolari. Io invece li fornirò. Non ho scritto questo libro per Dio, che mi conosce fin nelle viscere, né per quelle ombre testimoni di ogni cosa che osservano le ore delle mie veglie e del mio sonno, bensí per gli esseri umani. Finora ho vissuto coraggiosamente, spero di morire allo stesso modo, con coraggio e senza menzogna, ma questo può accadere a una sola condizione: devo ammettere che Emerenc l'ho uccisa io. Volevo salvarla, non distruggerla, ma non posso tornare indietro e cambiare le cose. | << | < | > | >> |Pagina 23In quell'istante non mi ricordai del vin brulé, né pensai che dopo tutto fosse rimasta al mio fianco per vegliarmi, percepii soltanto la sua ironia: mi stava di nuovo punzecchiando. Non bastava che la domenica mi recassi al tempio percorrendo vie traverse pur di evitare i suoi commenti? Come facevo a spiegarle, visto che non le interessava capire, che cosa significasse per me la funzione, quante presenze percepissi là nei banchi intorno a me, la folla invisibile delle persone che nel corso dei secoli avevano recitato le mie stesse preghiere, i sessanta minuti della cerimonia erano gli unici in cui sentivo con certezza di poter incontrare mio padre e mia madre morti. Emerenc non lo capiva, non lo accettava, sventolava, come fosse il capo di una tribú primitiva, il suo stendardo di guerra, un abito da sera con lustrini, contro l'armata degli agnelli della fede.La vecchia combatteva la Chiesa con un ardore degno del sedicesimo secolo, non solo i sacerdoti, ma anche Dio e tutti i personaggi della Bibbia, con la sola eccezione di san Giuseppe che teneva in grande considerazione in virtú della sua professione - perché il padre di Emerenc era stato un carpentiere. Quando vidi la sua casa natale, che splendeva d'una radiosa dignità dietro una siepe, con il tetto a doppio spiovente sopra le massicce colonne del porticato, e ricordava un po' una casa contadina in stile barocco, un po' una pagoda dell'Estremo Oriente, percepii qualcosa del gusto, della personalità della buon'anima di József Szeredàs che aveva disegnato personalmente su un foglio di carta lo schizzo dell'edificio. Gli «alberi-mucca», come Emerenc chiamava i grossi platani intorno all'edificio, che stendevano i loro rami giganteschi, il giardino fiorito che circondava la casa... quando la vidi, ormai trasformata in una cooperativa di carpentieri e falegnami, era ancora la piú bella casa di Nàdori. L'atteggiamento voltairiano di Emerenc non era dettato da una logica, per molto tempo non ne capii le ragioni, mi lasciava semplicemente perplessa, finché riuscii a mettere insieme i particolari - stavolta con l'aiuto della fruttivendola Sutu, un'altra brava persona - e l'intera favola prese forma. Il suo dissenso non veniva da un lungo assedio, non era l'assalto finale di una battaglia o il primo passo della pace, non era il risultato di una filosofia elaborata sulle macerie fumanti di un mondo in rovina, bensí una vendetta rozza, primordiale, scatenata da una spedizione inviata dalla Svezia. I fedeli della comunità di Emerenc avevano ricevuto dei pacchi regalo da una chiesa scandinava, ed Emerenc fino a quel momento non aveva mai svelato la propria religione - non la si vedeva al tempio perché era sempre impegnata con il lavoro, soprattutto nei primi tempi, quando prendeva in continuazione biancheria da lavare e faceva la maggior parte del bucato di domenica. Mentre gli altri si recavano nel tempio lei accendeva il fuoco sotto il piccolo calderone e sfregava i panni col sapone. La notizia che lontani correligionari avevano spedito un regalo alla comunità, naturalmente, giunse anche alle sue orecchie: l'amica Polett accorse a portarle la notizia e quando cominciò la spartizione nel salone delle preghiere, Emerenc, che non si faceva mai vedere al tempio, apparve all'improvviso con indosso l'abito nero della festa, aspettando di essere chiamata. Tutti la conoscevano nel quartiere ma a nessuno era venuto in mente di calcolarla: le dame incaricate della distribuzione, che facevano da interpreti alla missione svedese, guardarono imbarazzate quella figura magra che aspettava con il volto impassibile. Si resero conto che, pur non avendo mai frequentato il tempio, bisognava considerarla un membro della comunita; purtroppo, però, gli indumenti di lana o di tela erano già stati distribuiti, in fondo alle ceste rimanevano soltanto gli abiti da sera che una caritatevole signora svedese aveva deciso di far fuori insieme a molte altre cose inutili, senza evidentemente preoccuparsi troppo della situazione qui in Ungheria. Non volevano congedarla a mani vuote, speravano, come si scoprí in seguito, che avrebbe potuto vendere quel dono a un teatro, o a qualche casa della cultura, o magari scambiarlo con del cibo - non avevano insomma alcuna intenzione di deriderla, contrariamente a ciò che percepí Emerenc quando gettò stizzita l'abito da sera ai piedi della presidentessa delle dame di carità. Da quel giorno non mise piú piede nel tempio, nemmeno se le capitava, eccezionalmente, di avere un'ora libera, perché ormai non era piú colpa del lavoro ma si trattava di una deliberata scelta personale. Nella sua mente le dame di carità, Dio e la Chiesa diventarono una cosa sola: non perdeva l'occasione di spargere veleno sulla casta dei credenti, me compresa, se vedeva che nei giorni di festa, esattamente mezz'ora prima che la funzione religiosa cominciasse, uscivo dal portone con il libro delle preghiere in mano. | << | < | > | >> |Pagina 91A suo dire, quindi, sapeva che cosa stava escogitando Polett. Mi sentii costretta a chiederglielo. Come avrei potuto non saperlo? Rispose Emerenc, rimescolando i piselli con la mano, anzi, cercando di calcolare se bastavano per tutte noi. Insieme, avevano deciso anche che non avrebbe mai preso il veleno. Quando era a servizio da un capo ispettore di polizia, il padrone, che faceva sempre sopralluoghi nei casi di suicidio, le raccontava che trovava la maggior parte di quelli che s'avvelenavano vicino alla soglia di casa, davanti alla porta, come se all'ultimo momento, sentendosi soffocare, ci avessero ripensato e avessero cercato di scappare fuori. La morte col veleno è dolorosa, a meno che l'aspirante suicida non sia ricco, in questo caso riesce a procurarsi sostanze diverse da quelle che può prescrivere il medico del circondario. Non c'è niente di meglio che impiccarsi, è una faccenda semplice semplice, ne aveva viste a sufficienza lí a Pest quando i bianchi presero il potere: erano i bianchi che impiccavano, poi quando arrivarono i rossi furono loro a farlo, le parole che usavano per insultare i prigionieri prima dell'esecuzione si somigliavano, e quelli appesi per il collo scalciavano tutti alla stessa maniera, qualunque fosse il colore per cui venivano impiccati. La corda non è male, è piú gradevole di una fucilazione, perché le fucilazioni non sempre riescono al primo tentativo, basta vedere quante volte prendono la mira sul condannato, alla fine c'è sempre qualcuno che deve avvicinarsi per finirlo di botte, o per sparargli un colpo alla nuca, se non è crepato subito. Conosceva anche quel tipo di esecuzioni, ne aveva viste quante bastavano.A Micene, davanti alla tomba di Agamennone, avevo provato una sensazione simile a quel giorno di giugno, mentre i piselli rotolavano tra le dita ossute di Emerenc, corsi con i pensieri a ritroso nel tempo, ma anche nello spazio e nella storia: non vidi solo Emerenc bambina accanto al pozzo, in un tragico girotondo con il padre scomparso prematuramente, la madre bella come una fata, il patrigno caduto in Galizia, i due gemelli carbonizzati, la vidi anche ragazza, a servizio nella casa di un poliziotto, forse anche piú d'uno, perché quel padrone che faceva impiccare i rossi non poteva essere lo stesso che faceva arrestare i bianchi. Domandai a Emerenc se non avesse provato a trattenere Polett, visto che sapeva che cosa le frullava per la testa. - Non me lo sono nemmeno sognato, - disse Emerenc. - Vuole accomodarsi? Si sieda, per favore, mi aiuti a pulire i piselli, questi sono pochi per noi quattro. Se uno vuole andarsene, che se ne vada pure, perché avrebbe dovuto restare qui? Le assicuravamo il necessario per vivere, nella casa non c'era nessuno che la seccava, la lasciavano alloggiare in quella capanna senza niente in cambio, io le avevo anche procurato della compagnia, ma evidentemente non le bastavamo, né Sutu, né Adél, né io, eppure ascoltavamo di buon grado tutte le sue fissazioni, anche quelle che non capivamo perché le diceva in francese. La maggior parte delle volte che chiocciava nella sua lingua straniera conoscevamo il perché: parlava della sua solitudine. Ma chi non è solo, mi piacerebbe proprio saperlo. È solo anche chi ha qualcuno e non se ne accorge. Le avevo portato un gattino, nella sua casa, agli inquilini, non dava fastidio: si arrabbiò, disse che quella non era compagnia, non capisco davvero chi avrebbe potuto fare al caso suo, poiché non le andava bene niente, né noi né la bestiola. Il gatto aveva un occhio blu e l'altro verde, quegli occhi di colore diverso erano talmente espressivi che non aveva bisogno di miagolare, si capiva subito quel che voleva. Ma a Polett non bastava, perché non era un essere umano, come se non fossimo animali tutti quanti, solo che noi siamo peggiori delle bestie, loro non sanno denunciare né calunniare, e quando rubano hanno un buon motivo per farlo perché non possono entrare in un negozio o al ristorante. Le chiesi di accoglierlo in casa sua, anche se non bastava ad alleviare la sua solitudine, era una povera bestiola senza padrone, qualche mascalzone l'aveva abbandonata, e da sola, senza casa, sarebbe morta, era ancora cosí piccola, no, no, no, aveva bisogno di una persona. Bene, se la comprasse al mercato, perché li nel quartiere non c'era nessun altro, solo noi e il gatto. Adesso non è piú sola, ha i vermi che le tengono compagnia. Ma è Sutu che l'ha mandata qui, o quel cervello di gallina di Adél? Che stupide sono quelle due lí, nessuna di loro si è accorta che Polett si preparava a togliersi di mezzo, è vero, non gliel'aveva detto, non l'aveva detto neanche a me e a Viola, ma noi non ne abbiamo avuto bisogno, ce lo sentivamo che era sul piede di partenza. | << | < | > | >> |Pagina 158In effetti aveva ragione, solo che la cosa non mi piaceva affatto. La cortesia che mi aveva chiesto, sterminare il suo zoo dopo la sua morte, l'avrei fatta a chiunque, d'altronde speravo in fondo al cuore che, una volta giunto il momento, quel serraglio fosse assottigliato o sparito del tutto, e che non fosse cosí pazza da accogliere nuovi animali perché già nove erano una cifra pazzesca. Non era affatto facile, ma non potevo fare nulla per cambiare la situazione: dovevo prendere atto che era lei a dettare le norme, a regolare il termostato del nostro rapporto con parsimonia e saggezza. Con le coppie delle ambasciate intrattenevamo relazioni di questo genere, ricevendo e offrendo cordialità, ripetendoci, prima di ogni incontro, i protocolli non scritti delle missioni all'estero: bisogna frenare i sentimenti, i diplomatici vengono trasferiti ogni tre anni, non possono permettersi di stabilire legami durevoli con le persone del luogo; anche noi dovevamo dosare accortamente l'espansività, ma finché c'erano potevamo goderci la loro presenza visto che era cosí piacevole stare in loro compagnia.Noi tre avevamo accettato le leggi della diplomazia, ma il quarto membro della famiglia, Viola, no. Una volta, per la rabbia, morsicò la vecchia e pagò caro il gesto, ricevette un colpo di badile cosí violento che si ruppe una costola. Viola si lasciò visitare dal veterinario ululando, la vecchia lo tenne fermo durante la medicazione e gli spiegò: - Ben ti sta, e non giustificarti dicendo che è il periodo del calore, donnaiolo che non sei altro, smettila di piangere, mascalzone, hai ricevuto quello che meritavi. Apri quella boccaccia -. Il dolciume di ricompensa scomparve in un baleno tra i denti scintillanti e fieri. Emerenc aveva stabilito la clausola che nelle vite di chi la amava doveva essere lei a rivestire il ruolo principale, e tra tutti gli esseri che riteneva importanti il cane era l'unico a considerare naturale quella regola, in fondo, l'aveva rispettata anche nel momento in cui l'aveva morsicata. Mio marito e io, per altro, raggiungevamo la massima armonia quando uno stava male, e in quegli anni poco sani sotto tutti i punti di vista le malattie non ci furono risparmiate, c'era sempre uno dei due che crollava, o perché il corpo non riusciva a resistere all'attacco del male, o perché il sistema nervoso avvertiva che i giochi contro la nostra persona venivano condotti con sistemi sleali. Nei periodi critici Emerenc ci aiutava con straordinaria sensibilità, le sue dita deformate ci arrecavano sollievo, guarivano, non c'era beatitudine maggiore di quando, dopo una grave malattia, ci lavava, ci massaggiava, ci cospargeva con uno di quegli unguenti profumati che riceveva per posta da Evike Grossmann. Mio marito sosteneva che per rendere Emerenc tranquilla e soddisfatta, avremmo dovuto trovarci in perenne agonia, o rischiare di affogare in acque profonde, perché in questo modo sentiva di poterci salvare; se invece ci arrideva il successo stabile e duraturo o se le nostre vite raggiungevano un grado di relativa sicurezza perdeva interesse nei nostri confronti; appena non poteva piú aiutare qualcuno sentiva che la sua ragion d'essere era cessata. Non aveva mai letto una sola riga, eppure - e questo era davvero singolare -, le giungevano tutte le funeste notizie letterarie che periodicamente sconvolgevano le nostre vite: in questi momenti diceva di essere al corrente della questione, ci rassicurava che stava facendo la sua parte, aveva spiegato alle persone influenti che abitavano nella nostra via, nel caso non se ne fossero accorte da sole, che certi cospiratori erano di nuovo all'opera e pretendeva la condanna dei nostri nemici come manifestazione di solidarietà dal suo personale entourage.
Mentre gli anni passavano, il nostro legame si cementò, Emerenc era parte di
noi, naturalmente entro i limiti che fissava lei: continuò a ricevermi fuori
dalla porta, nell'atrio, come ogni altro sconosciuto, e non mi permise piú di
entrare nel suo appartamento. Nemmeno le altre abitudini mutarono, continuò ad
accollarsi tutti i lavori di un tempo e benché non avesse piú l'antica energia
non rinunciava nemmeno a scopare la neve. Talvolta cercavo di quantificare
l'ammontare della sua reale fortuna, avevo il sospetto che il figlio del
fratello Józsi, oltre alla tomba, avrebbe potuto erigere un intero condominio
d'appartamenti per la famiglia da ricostituire. Emerenc ricompensava ognuno di
noi in maniera diversa: per il tenente colonnello nutriva grande rispetto, Viola
le aveva rubato il cuore, a mio marito offriva il proprio irreprensibile lavoro -
lui per altro apprezzava molto la riservatezza di Emerenc che arginava entro
limiti convenienti la mia inclinazione, da provinciale, alla socievolezza -, a
me aveva affidato un compito da svolgere nel momento cruciale, futuro, della sua
vita, e mi aveva trasmesso la pretesa che nell'arte non fossero le macchine, la
tecnica, a scuotere i rami degli alberi bensí la passione autentica - questo era
molto, era il dono piú importante di Emerenc, eppure sentivo che non bastava
ancora, desideravo altro, avrei voluto per esempio poterla abbracciare di tanto
in tanto, come un tempo facevo con mia madre, dirle cose che non avevo mai
confidato a nessuno, cose che nemmeno mia madre sarebbe stata in grado di capire
con il suo buon senso e la sua cultura, ma avrebbe percepito grazie ai delicati
sensori dell'amore. Ma lei non aveva bisogno di me, per lo meno, credevo che
non ne avesse. Un giorno - lei era morta ormai da tanto, e della sua casa d'un
tempo non era rimasta piú traccia -, la moglie dell'artigiano tuttofare, vedendo
che avevo in mano un mazzo di fiori raccolti in giardino, mi si buttò con le
braccia al collo, sapeva che mi stavo recando al cimitero. - Voi eravate la luce
dei suoi occhi, la sua figlia, - disse la moglie dell'artigiano, - domandatelo a
chiunque nel quartiere, vi chiamava proprio cosí, «la figlia». Di chi credete
parlasse fino alla nausea, quella poveretta, quando si sedeva a riposarsi? Di
voi. Ma voi vedevate una cosa sola, vedevate soltanto che vi aveva rubato il
cane, e non vi siete mai accorta che per lei voi eravate diventata Viola.
|