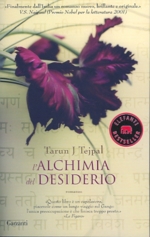
|
|
|
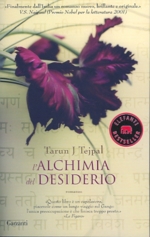
|
|
|
| << | < | > | >> |IndiceLIBRO PRIMO - Prema: Amore 7 Una doccia fredda mattutina 9 Bufere 21 Gli Eredi 57 LIBRO SECONDO - Karma: Azione 117 Alla corte di re Coffa 119 L'avvitabulloni 159 Bibi Lahori 193 LIBRO TERZO - Artha: Denaro 219 La casa in montagna 221 Sulla strada 247 Il limite della ragione 277 LIBRO QUARTO - Kama: Desiderio 307 Un americano atipico 309 Il nababbo filosofo 343 Creatori e distruttori 377 LIBRO QUINTO - Satya: Verità 417 Il buco della storia 419 Un cantastorie 467 Le Origini 489 Ringraziamenti 503 Glossario 505 |
| << | < | > | >> |Pagina 9Non è l'amore il collante più forte tra due persone, ma il sesso. Le leggi della fisica vi diranno che è più difficile separare due corpi uniti al centro che due collegati tra loro in qualche punto vicino alla cima o al fondo. Ero ancora pazzamente innamorato di lei quando l'ho lasciata, ma il desiderio si era spento, e tutti gli anni di interessi in comune, premure, scoperte e viaggi non potevano impedirmi di fuggire. Forse ricordo male. A voler essere precisi, non sono stato io ad andarmene, ma Fizz. La verità è che, come sempre, lei faceva quello che volevo io, quello che avevo deciso per lei. E io facevo quello che facevo perché ormai il mio corpo le si era rivoltato contro; e chiunque abbia scandagliato i recessi della mente e del corpo potrà dirvi che quest'ultimo, con i suoi molti, pressanti bisogni, è il vero motore della vita. La mente si limita a indicargli la strada, o a consolarlo con omelie altisonanti quando non c'è alcuna strada da seguire. Le farneticazioni dei puritani e dei moralisti sono le urla angustiate di coloro i cui corpi non sono riusciti a trovare la strada per la beatitudine. Quando guardo i preti – indù, musulmani o cristiani – che inveiscono contro gli istinti, vedo uomini perduti, arrabbiati e frustrati. Incapaci di sperimentare le prove del corpo, di individuare la strada per il piacere supremo, si adoperano per confondere le idee agli altri. Incapaci di trovare la loro sinapsi sessuale, dichiarano guerra a tutti gli altri. Anch'io credo che esistano i veri asceti, come esiste il rinoceronte con un corno solo, ma sono pochi e rari e facilmente riconoscibili. Per il resto di noi, il corpo è un tempio. La verità è una divinità tangibile. Se ne sente l'odore. La si può toccare, penetrare.
La mattina che mi svegliai senza avvertire il bisogno di scivolare
dentro il suo corpo e inspirare il suo odore di muschio, mi resi
conto di essere nei guai.
Come sempre, stavamo dormendo nella piccola stanza sopra la vallata di Jeolikote, sul letto di pino che i ragazzi pelle e ossa di Bideshi Lal ci avevano fabbricato e consegnato in giornata. Assi di un giallo sbiadito. Linee dritte. Nessun ghirigoro. Solido, essenziale, senza alcuna autoindulgenza. Dopo aver dormito per anni su letti di compensato, amavamo il senso di solidità che emanava da quel giaciglio. Sdraiati lì, non ci sentivamo più degli eccentrici di città. Il nostro era quello che i falegnami avevano definito un letto a una piazza e mezza. Ne avremmo preferito uno più grande, con più spazio per girarci, ma la stanza era minuscola e poiché dormivamo sempre vicini, attaccati, una piazza e mezza era più che sufficiente. Come ogni mattina, le tende gialle erano tirate e la prima luce del giorno penetrava dolcemente nella stanza. Solo in montagna, con tutte le finestre pronte ad accogliere il tenue chiarore dell'alba, all'interno e all'esterno la luce è esattamente la stessa e regna la quiete perfetta di un globo di vetro per pesci rossi quando i pesci non si muovono. In quel momento della giornata il mondo è di un solo colore. Allo stesso tempo vivo e inerte. Sulla quercia scolorita e nodosa fuori dalla finestra, i piccoli passeri dalle guance bianche stavano cominciando a svolazzare qua e là. Mi tirai su poggiando la schiena sul cuscino, contro la parete di pietra, e guardai le montagne sinuose fuori dalle grandi finestre. Nel punto in cui due anni prima una frana aveva squarciato la parete rocciosa, stava ricrescendo una sottile pelle d'erba. Se la osservavi con il pesante binocolo Minolta – mettendolo a fuoco con lente rotazioni delle dita – quella ferita appariva in tutta la sua bruttezza. Felci, erbacce e arbusti stavano rivendicando timidamente i loro diritti. Non c'erano strati, né profondità. Erano come nuovi edifici, nuovi mobili, nuovi vestiti e nuovi amanti, in attesa che il tempo e la storia lavorassero per conferire loro valore. Ma la recente pelle erbosa consentiva di osservare la montagna senza dover distogliere lo sguardo. L'anno prima lo squarcio nella roccia attirava e respingeva lo sguardo come la ferita aperta di un accattone. Due stagioni di piogge battenti avevano sortito il loro effetto. Con la coda dell'occhio scorsi fili di fumo grigio che salivano arricciandosi dal fondovalle come le righe tremolanti di un paesaggio montuoso disegnato da un bambino. E voltandomi appena, vidi che Fizz stava dormendo, rannicchiata nella sua solita posizione fetale, lontano da me. Addosso aveva solo una T-shirt girocollo con sulla schiena uno slogan sugli alberi da salvare. Sotto la scritta c'era l'immagine di un albero dalla sagoma seghettata che si trasformava in teschio. Una di quelle trovate grafiche geniali. Lo slogan dichiarava: «Uccidi un Albero, Uccidi un Uomo». Talvolta, quando la montavo lentamente e la maglietta le si arrotolava intorno al petto, le parole cominciavano a confondersi finché leggevo soltanto «Uccidi Uccidi»: un'esortazione a perdere la testa, che aggiungeva un po' di pepe a quegli istanti. La maglietta le si era arricciata sotto il seno, e sollevando la spessa coperta blu ammirai le sue forme generose. L'ampia rotondità sotto la vita stretta, il punto più formoso del suo corpo, capace di eccitarmi all'istante. La osservai per un po', reggendo la coperta con la mano sinistra. Lei non si svegliò. Era abituata ai miei exploit voyeuristici a ogni ora del giorno e della notte. Come un cane che abbia smesso di ascoltare i passi dei domestici, la sua pelle aveva smesso di formicolarle sotto il mio sguardo. In realtà, c'erano state volte in cui nel cuore della notte mi ero dedicato al suo corpo in tutti i modi possibili e lei aveva continuato a dormire, restando all'oscuro di tutto. Quando, la mattina dopo, le avevo rivelato il mio segreto, la consapevolezza che avevo fatto qualcosa a sua insaputa l'aveva turbata. I suoi capelli ricci giacevano in nere masse spiraliformi sul lenzuolo bianco – non usava mai il cuscino, per via dell'inclinazione del collo e del suo terrore per il doppio mento. Aveva capelli bellissimi e un tempo mi bastava affondarvi il viso per eccitarmi. Molto tempo prima, quando non aveva ancora diciotto anni, qualche minuto dopo aver perso la verginità si era messa davanti allo specchio sopra il lavandino del mio minuscolo bagno di Chandigarh a contemplare i segni di un irreversibile rito di passaggio e io, alle sue spalle, avevo affondato il viso nei suoi ricci, inspirando l'odore dello shampo profumato e della pelle bagnata. Mi ero eccitato all'istante, e in un attimo ci eravamo ritrovati di nuovo sul materasso, in mezzo alla flottiglia di libri alla deriva sul pavimento a mosaico. La seconda volta era durata per tutto l'atto. La prima, ero appena riuscito a entrare. Molto tempo dopo, quando potevamo parlare di queste cose, lei l'aveva denominata un «doppio passo». Era successo mentre stavo guardando una partita di basket in televisione e le stavo spiegando le regole. Lei aveva estrapolato quell'espressione dalla mia telecronaca e l'aveva subito fatta sua. Aveva detto: «Ricordi il tuo primo grande doppio passo?» Da quel momento, la usò per prendermi in giro. E a volte, quando io giacevo sfinito e lei era ancora euforica, reggendosi la testa con le mani, diceva: «Non ti andrebbe un doppio passo?» Naturalmente mi andava sempre. Ma ora la guardavo e non provavo niente. Quasi tutte le mattine della mia vita con lei mi ero svegliato con il desiderio di averla. Il ricordo dei suoi odori accompagnava tutte le ore della mia giornata, e li cercavo fin dall'istante in cui aprivo gli occhi. Esploravo il suo corpo in lungo e in largo, annusandola ancora e ancora, in cerca della sorgente segreta, mentre il battito del mio cuore aumentava sempre più, in un crescendo esplosivo; poi ci sarebbe stata la pace del lento ansimare, e la giornata a venire. Quel giorno non provai niente. Niente tranne una vaga tenerezza nell'osservarle le due fossette sulla parte bassa della schiena, che ora era completamente allungata per via della posizione. Piccole depressioni su entrambi i lati della spina dorsale, un'invitante via d'accesso alle sue sinuosità. Non ero mai riuscito a guardare Fizz spassionatamente. All'inizio, per molto tempo, c'era stato un amore doloroso, incontenibile. Un amore cieco. E poi, dopo il pomeriggio del doppio passo sul pavimento della stanza dove alloggiavo, c'era stato uno struggimento sempre più ardente, un bisogno sempre più impellente. Un desiderio cieco. Come lei, sotto la T-shirt ero nudo. Il lunghi che portavo attorno ai fianchi mi si era srotolato nella notte. Mi toccai, ma non trovai nulla. La notte si era di nuovo presa la rivincita su di me. Ero appagato, prosciugato di qualsiasi energia o desiderio. In tutta la mia vita, avevo conosciuto quella sensazione solo negli istanti successivi a rapporti sessuali epici. Dopo essere stato consumato ancora e ancora, finché in me non rimaneva più nulla. Fizz aveva un'espressione per quelle performance estreme quando, arrivato al culmine, ricadevi su un fianco e perdevi i sensi. Onnisazietà. L'oblio del massimo piacere. | << | < | > | >> |Pagina 23La mattina seguente, prima dell'alba, avevo lasciato la bicicletta nel parcheggio della fermata d'autobus. L'avevo sognata a occhi aperti e avevo scritto di lei per tutto il tragitto – in quei giorni non facevo altro. Senza lei al mio fianco, le tortuose stradine di campagna mancavano di magia. Avevo percorso la salita e una volta arrivato in cima, dove la collina si riempiva di abitazioni, mi ero seduto nella casa da tè all'angolo della strada, avevo ordinato un'omelette e avevo chiesto qualche informazione sulla casa dello zio di lei al rozzo proprietario che stava facendo bollire il tè in una pentola incredibilmente nera.Minuscolo come un passero, stava salmodiando: «Har Govinda Har Gopal! Har Govinda Har Gopal!» «Il grasso ingegnere?» aveva chiesto, tra una strofa e l'altra, «be', se vuoi conoscere il grasso ingegnere e la sua grassa moglie dovrai aspettare perché sono scesi al mandi per comprare le verdure più economiche. Sai, sono quel genere di impiegati pubblici che vogliono tutto gratis. Ma che non vogliono fare niente se prima non si dà loro una mancia.» «Ho una cosa da consegnargli», avevo detto mostrandogli la copia di Addio alle armi che stavo leggendo. «Sul cancello c'è un cartello con il disegno di un cane rabbioso. Vacci pure. Il cane è come loro, grasso e pigro, e ti morderà solo se è pagato per farlo.» Avevo posato tre rupie sul tavolo di legno crepato e gli avevo chiesto: «Non le piace la gente grassa?» «No, sahib, dovrebbe essere tutto proporzionato. La tua casa non dovrebbe essere più grande del tuo cuore; il tuo letto non dovrebbe esserlo più del tuo sonno; e il cibo che ingurgiti più del tuo stomaco», aveva risposto lui. Era saltato giù dal suo sgabello accanto alla stufa sibilante, aveva raccolto i soldi e aveva continuato dicendo: «Gli uomini non dovrebbero mettere un etto di troppo sulla madre terra. La terra è già sovraccarica. Sovraccarica di carne, di avidità e di dolore. Quando i piatti della bilancia si rovesceranno, si scatenerà l'apocalisse. Il mondo è quello che è perché gli uomini hanno dimenticato la differenza tra il bene e il male». Aveva detto questo senza guardarmi, continuando a lavare i piccoli bicchieri allineati e i piatti di plastica rigati, e aggiungendo un altro po' d'acqua, latte e zucchero nella pentola del tè. «Perciò cammina leggero, amico mio», aveva proseguito, «e ascolta il tuo cuore, non la tua mente. Il mondo è stato rovinato perché l'uomo presta troppa attenzione alla mente. Har Govinda Har Gopal!» Avevo trovato la casa senza difficoltà e, tutto baldanzoso, avevo aperto il cancello che sfoggiava la brutta placca di metallo con l'effigie di un alsaziano. Il vecchio aveva ragione. C'era un grasso Labrador che dormiva sotto un tavolo di vimini sulla veranda, la testa appoggiata sulle zampe anteriori. Mi aveva guardato con occhi inquisitori e non aveva mosso un muscolo. Avevo suonato il campanello, che riproduceva il motivo di Jingle Bells, e mi aveva aperto un marmocchio. Indossava un paio di pantaloncini di nylon rossi e una felpa sbiadita con la faccia di Bruce Lee e la scritta King of Kung Fu. «Che cosa vuoi?» aveva detto, tirando la gomma da masticare che aveva in bocca e allungandola ben oltre il suo grasso naso. «Voglio vedere Fiza.» «Perché?» aveva chiesto, con i denti serrati, allungando la gomma un altro po'. «Devo darle un libro.» Gliel'avevo mostrato. Sulla copertina c'era Catherine Barkley in uniforme da infermiera. E sullo sfondo una piccola ambulanza. «È un romanzo?» Gli avevo indicato l'ambulanza. «Che cos'è?» «Parla di un marmocchio che ingoia la gomma che sta masticando e di quello che i dottori devono fargli.» Ora mi stava squadrando, immobile. «Fammi vedere l'ombelico», avevo detto. Lui si era sollevato la felpa di Bruce Lee con la mano sinistra e si era ricacciato la gomma in bocca con la destra. Era un brutto ombelico sporgente. «Tra sei mesi», avevo detto, «dovranno aprirti in due il sedere e grattarti via la gomma.» Aveva fatto una smorfia. «Va' a chiamarla subito e ti insegnerò un trucco che potrebbe salvarti.» Fizz era radiosa. «Ti ho portato il tuo libro», avevo detto mostrandole il volume di Hemingway. Sul suo viso era spuntato un sorriso capace di illuminare il mondo. Il suo sorriso era sempre genuino, una reazione immediata a un qualche stimolo. Non celava mai significati nascosti, cospirazioni silenziose, istruzioni segrete. Quando qualcosa la rendeva felice, lei sorrideva, e il mondo si illuminava. «Sei pazzo», aveva detto. «Pazzo in che senso? Positivo o negativo?» avevo chiesto io. «Positivo, naturalmente!» aveva replicato lei ridendo. Era la seconda volta che la vedevo così: con indosso il pigiama bianco con il quale dormiva, i capelli sciolti sulle spalle, la pelle luminosa. Sembrava uscita da uno di quei libri di fiabe che leggevamo da bambini — il morbido abito bianco sostituito dal pigiama. Era bella oltre ogni dire. «Dove?» avevo detto. «La casa è piena di gente», aveva risposto lei. «Cominceranno a svegliarsi e a scendere di sotto.» Era stranamente calma. Questa era un'altra cosa di lei che avrei imparato con gli anni. Pur non essendo trasgressiva o controcorrente, aveva un modo tutto suo di fregarsene delle convenzioni e delle opinioni altrui. «Deve pur esserci una stanza vuota», avevo detto. E dando un'occhiata al ragazzo avevo aggiunto: «Dove posso spiegarti il libro». «E lui?» aveva chiesto lei. «Bruce Lee, vieni qui», avevo detto. L'avevo portato in un angolo della stanza. «OK, ecco il trucco. Ora vai a sederti sul vaso da notte, ti infili un dito in ciascun orecchio, e dici "Leeeeeee" ad alta voce. Lo ripeti cento e una volta. Poi controlli. Se la gomma non è uscita, lo ripeti altre cento e una volta.» Il ragazzo se n'era andato, ricacciandosi la gomma in bocca. «Dove lo hai mandato?» aveva chiesto lei. «A fare pratica di kung-fu.» Mi ero guardato attorno. La stanza era piena delle cianfrusaglie tipiche di ogni salotto indiano borghese: fiori di plastica, statuine di ceramica raffiguranti divinità indù, elefanti di sandalo che marciavano in fila, mobili sciatti abbelliti ad arte, fotografie di famiglia dentro cornici rudimentali. Mi ero guardato attorno in cerca delle uscite. C'erano fin troppe porte. Era la stanza centrale della casa. Dovevamo uscire di lì. Morivo dalla voglia di abbracciarla, annusarla sotto l'orecchio. «Dov'è la camera da letto di tua zia?» avevo chiesto. Lei era arrossita. Il momento del disagio era ormai prossimo. Era così che funzionava quando eravamo uno vicino all'altra. Riuscivamo a malapena a parlare. Il bisogno di stabilire un contatto fisico soffocava tutto il resto. «Laggiù», aveva detto, indicando il muro opposto con un cenno del capo. Una volta dentro, avevo chiuso la porta a chiave e avevo stretto Fizz a me. La stanza era buia e la mia bocca era dappertutto e il cotone bianco che aveva addosso era crespo e sottile e io ero pazzo d'amore e lei era bagnata e incredibilmente bella e le nostre mani erano quelle di un vasaio e la nostra carne argilla; e poi avevamo sentito delle voci fuori dalla stanza, con lei seduta sul bordo del letto e io che potevo annusare e gustare e udire il suo amore, e mi ero ritrovato nel luogo a cui appartenevo, il luogo dove volevo vivere e dove volevo morire, e il mondo era una striscia di pelle, due strisce di pelle, il mondo era liquido e il mondo era teso e il mondo era una fornace e il mondo si stava muovendo e il mondo stava scivolando ed esplodendo e il mondo stava finendo e il mondo era finito. Quando eravamo stati nuovamente in grado di udire, sentimmo che qualcuno stava chiamando Fiza dal salotto. Erano passati solo pochi minuti. «Esci di qua», aveva detto lei, aprendo una finestra con un ampio davanzale. Io ero saltato fuori ed ero atterrato in un'aiuola di rose rosse incolte. Con passo sicuro, senza guardarmi indietro, mi ero avviato al cancello. Mentre lo aprivo, da un angolo della casa mi aveva raggiunto un risoluto «Leeeeeeee»... Sulla via del ritorno avevo incrociato il grasso ingegnere e la sua grassa moglie che arrancavano su per la salita. Trasportavano cestini pieni d'ortaggi le cui orecchie verdi sbattevano di qua e di là. Loro non mi avevano notato mentre scendevo giù per la strada, cavalcando l'onda della felicità più pura. | << | < | > | >> |Pagina 57Al mondo ci sono poche città antiche come Delhi. Per millenni avventurieri, predoni, pellegrini, re, studiosi, sufi e mendicanti hanno varcato le sue porte inseguendo sogni diversi. Alla vecchia Delhi si sovrappone in continuazione una Delhi nuova. Il disordine del potere è l'unica costante. Ci trasferimmo a Delhi nell'inverno del 1987. Così, di punto in bianco. Per abitarci, per mettere radici. Avevamo fatto un'incursione preliminare, con la valigia in mano, in cerca di un posto dove stare. E quasi subito avevamo trovato casa – un barsati – e ci eravamo trasferiti definitivamente. Eravamo arrivati a Delhi quando le ultime piogge monsoniche erano cessate, e nei due mesi che impiegammo a cercare casa avevamo visto le foglie cadere, l'autunno trascorrere, le giornate accorciarsi. Il traffico si era fatto meno intenso, e dopo la mezzanotte il rombo dei motori e i fasci di luce delle auto diminuivano fin quasi a scomparire. La sera e la mattina aveva cominciato a formarsi la rugiada, e presto ci saremmo trovati nell'abbraccio possente della nebbia. Ci stavamo trasferendo nell'epicentro dell'India, e l'India non era più innocente. Negli anni Ottanta il terrorismo aveva demolito il nostro autocompiacimento e tre decenni d'orgoglio nazionale per aver cacciato gli inglesi dal nostro paese. In capo a pochi anni sarebbe sparito tutto: tazze e piattini e servizi da tè, madri superiori di conventi intitolati a Maria, Giovanni, angeli e arcangeli cantanti, vicedirettori di quotidiani dall'accento oxbridge, gandhiani col copricapo bianco, ladri gentiluomini che rubavano solo ai ricchi, l'onore nel cricket e l'acqua tonica nel gin, le convenienze di casta e la Costituzione, la responsabilità morale e materiale, il karma e il dharma. Presto l'uomo al potere si sarebbe sollevato il dhoti e ci avrebbe mostrato il culo; l'uomo della strada si sarebbe abbassato il pigiama e ci avrebbe mostrato il culo; e noi della classe media ci saremmo chinati davanti allo specchio, avremmo calato le brache e il sedere l'avremmo mostrato a noi stessi. Ci sarebbero state disquisizioni accademiche e analisi mediatiche sulle forze subalterne, ricostruzioni postcoloniali, la stasi rurale, l'entropia del Terzo Mondo, l'alba dei dalit, il nazionalismo culturale e così via. Ma alla fine avremmo finito per mostrarci il culo. Alla fine ci sarebbe stata solo una confederazione di culi.
Come diceva sempre il padre di mia madre riguardo ai suoi figli
spreconi che dilapidavano tutti i soldi inseguendo progetti chimerici – tipo
vendere confezioni di
datun
da venti centimetri che avrebbero soppiantato gli spazzolini da denti o
pantaloni con una cerniera sul didietro per cacare senza doverli abbassare, o
ancora imbottire le galline di steroidi così da avere uova ogni otto ore (finché
i poveri pennuti non si gonfiavano come palloncini ed esplodevano) – come diceva
sempre il padre di mia madre, osservando il fallimento dell'ennesima iniziativa,
con il suo
hoohah
di legno e ottone che ribolliva dalla rabbia: «Al buio anche un culo può passare
per una faccia».
Nell'inverno del 1987 l'India era invasa da progetti governativi andati a monte. Progetti agricoli, politici, economici, didattici, religiosi, sanitari, scientifici, sportivi, contro il mercato nero, per il turismo, per la potabilità dell'acqua, per la protezione degli animali, per gli aiuti alle donne, per l'istruzione dei ragazzi, contro la programmazione delle nascite, contro l'ecografia delle donne incinte, per la nazionalizzazione, per la privatizzazione, per un'India più pulita, per la Vecchia India e per quella Nuova. Avevamo imparato l'arte della classificazione dall'uomo bianco. Etichette grandiose potevano nascondere cose imperdonabili. In tutto il paese, uomini dall'aria arcigna e donne vestite sciattamente sedevano in comitati e uffici partorendo dalla loro flaccida immaginazione un altisonante progetto dopo l'altro. Poi venivano dati in pasto alle fauci fameliche del governo, come bastoncini di canna da zucchero nei macinatori delle bancarelle agli angoli delle strade. Il succo veniva messo da parte e si utilizzavano solo gli scarti. La gente guardava il succo e mangiava il resto. Come diceva spesso un mio amico: «L'India è un club sportivo al quale sono iscritti solo i politici e i burocrati». Mio nonno si limitava a dire: «Al buio anche un culo può passare per una faccia». Nell'inverno del 1987 Indira Gandhi morì. In realtà, era morta da tre anni; mio padre aveva pianto quando era stata crivellata di proiettili. Io l'avevo guardato con disprezzo. Quella donna doveva rispondere di un mucchio di cose e alla fine qualcuno gliel'aveva fatta pagare. Rajiv Gandhi era vivo, ma stava rapidamente perdendo colpi. Ci aveva detto di avere un sogno. Al momento, però, continuava a venire metodicamente macellato nei mattatoi della sua innocenza. La colpa di sua madre era stata l'arroganza; la sua, l'innocenza. Sarebbe finita male, tragicamente. Quando fosse arrivata la sua ora, avrebbe avuto domande da fare e forse qualcuno lassù avrebbe dato loro risposta. La Destra indù non aveva ancora dato sfogo al suo genio folle. Ci vuole tempo perché un popolo scenda da quelle nobili altezze. Il 1947 ci aveva lasciati in un luogo desolato e difficile. Il periodo della Destra estremista era cominciato quando gli ideali di modernizzazione e democrazia inculcatici da quegli splendidi guerrieri che combatterono il colonialismo avevano lentamente iniziato a sbiadire e ci eravamo riconvertiti alla piccolezza della casta, della comunità e della religione. Il genio della Destra estremista era stato quello di capire che un culo al buio può anche passare per una faccia, ma resta pur sempre un culo. Rivolgersi a un culo per quello che è significa far scattare un dialogo di accettazione. È un tale sollievo smettere di fingere di essere una faccia. Come posare coltello e forchetta, e attaccare a mangiare con le mani. È un tale sollievo calare le brache e mostrare il culo. È un tale sollievo essere una confederazione di culi. La colpa di Indira Gandhi fu l'arroganza. Quella di Rajiv Gandhi l'innocenza. E quella della Destra estremista la meschinità. Nell'inverno del 1987 Indira Gandhi era morta, Rajiv era vivo e la Destra estremista era un mero embrione. Ma nessuno, morto, vivo o embrionale che fosse, ci impedì di venire a Delhi. Quella di trasferirci nella capitale era stata una decisione improvvisa, ma era nell'aria da tempo. Eravamo fatti così. Parlavamo di una cosa all'infinito, senza alzare un dito perché si realizzasse. Poi, improvvisamente, avevamo un'illuminazione, un certo stato d'animo s'impadroniva di noi, e ancora prima di rendercene conto, partivamo in quarta. In questo caso, l'illuminazione era arrivata prima per il mio lavoro, poi per il trasferimento. | << | < | > | >> |Pagina 81Come sempre, mi fermai alla curva di Timber Trail; lì, otto anni prima, ai tempi dell'università, avevo perso due amici. Stavano salendo da Shimla sotto una fine pioggerella, su di giri per la birra e la giovinezza, e la loro Yezdi era slittata scaraventandoli al centro della strada. Bilia, che stava sul sellino posteriore, era rimasto aggrappato a Timmy mentre rotolavano sull'asfalto, e un camion che andava a tutta velocità li aveva travolti. Quando le doppie ruote li avevano investiti, Billa si trovava sopra Timmy, e dalla vita in giù i due erano rimasti aggrovigliati in un ammasso indistinto di ossa, carne e sangue. Quando qualche minuto dopo li avevamo raggiunti, stavano ancora parlando, le teste vicine, inconsapevoli del fatto che dall'ombelico in giù non esistevano più.Billa, che aveva bellissimi occhi verdi, stava dicendo: «L'avevo detto a 'sto deficiente che stavamo per slittare». Timmy, senza turbante, i lunghi capelli sciolti sull'asfalto, aveva ribattuto: «L'avevo detto a questo stronzo: non stringermi così forte, non riesco a sterzare». Bilia aveva risposto: «La prossima volta, bastardo, fa' guidare me». «Cazzo! Mio padre mi ucciderà! La moto è fottuta?» aveva chiesto Timmy. «No», aveva risposto Miler, inginocchiandosi, con il suo modo di fare calmo, autoritario. «No, è a posto. È tutto a posto.» «Assicurati che non lo venga a sapere, si incazzerà!» gli aveva raccomandato Timmy. Sarebbero morti in pochi minuti. Era stato strano; un attimo prima stavano parlando e quello dopo non c'erano più. Erano così maciullati che avevano dovuto caricarli su una sola barella e, più tardi, persino cremarli su una pira comune. Per tutti noi era stato il primo, importante rito di passaggio. Eravamo stati toccati dalla mortalità. Ora sapevamo che non era riservata solo ai vecchi. Per intere settimane avevamo continuato a percepire la vita come qualcosa di miracoloso. Poi il dolore era passato, i ricordi erano diventati belli e avevamo finito per rattristarci solo da sbronzi. Su un grosso albero sotto la curva, avevamo inciso un epitaffio: «Timmy e Billa, 26 luglio 1979; Dormitorio Himalach, stanza 102, grandi amici e maestri del gioco di polso, ora per sempre compagni di stanza, e che si fotta qualunque guardiano cerchi di separarli». Avevamo stretto il patto solenne di incidere una tacca sull'albero ogni volta che uno di noi passava di lì. Dopo essere sceso per il sentiero fronzuto e scivoloso che portava all'albero, contai le tacche sulla corteccia. Ce n'erano ventisette. Quattro erano mie. Presi una pietra e incisi la quinta. Quando arrivammo alla curva successiva, la nostalgia era passata e Fizz stava parlando della colazione. Ci fermammo in un chiosco e mangiammo due omelette unte con fette di pane tostato direttamente sulla fiamma, trangugiando diversi bicchieri di tè. Il sole era sorto, ma la sua luce non era ancora scesa fino alla strada. Lasciando la strada principale all'altezza di Dharampur e imboccando l'ultimo e pittoresco tratto fino a Kasauli, fummo investiti da un'esplosione d'aria fresca e di gioia. In quei tredici chilometri, la strada – simile a un nastro che ondeggiava in aria – si stringeva e il traffico diminuiva fino a scomparire, mentre gli alberi si facevano più vicini e magnifiche gazze rosse e blu svolazzavano incuranti sopra i corsi d'acqua, giocando a rincorrersi a coppie. Comparvero magiche radure e noi fermammo la moto per rifugiarci in una di esse, usando il tronco largo e scabroso di un vecchio pino imbottito di aghi come giaciglio per bere di nuovo il folle cocktail di desiderio e amore. Lei indossava un ampio pullover rosso. Glielo sollevai – con tutto ciò che c'era sotto – tirandoglielo su fino al collo. Lei inarcò la schiena ed era più bella di tutti gli alberi, gli uccelli e le montagne messi assieme. Sulla pelle le spuntarono due piccole capocchie le cui punte rosa acceso mi ponevano domande a cui ero nato per rispondere. Risposi a una con la bocca, e all'altra con il palmo della mano. Il suo viso assunse il colore dell'aurora e, prendendomi la testa tra le mani, la guidò lungo il suo corpo finché le mie labbra non brillarono della prima rugiada del mattino. E quando riversai il mio amore dentro di lei, ansimando il suo nome, il vento lo sussurrò con me. Fizzzzzz. Ci fermammo in un alberghetto sul Lower Mall. La camera, con una consunta moquette verde e le tende polverose, sapeva di muffa. Il materasso era spesso, ma il letto cigolava, la porta del bagno, una volta chiusa, rimaneva bloccata e bisognava aprirla a calci dall'esterno. Passammo le quattro ore successive a gridare a turno: «Dalle un calcio, amore!» «OK! Levati!» E bam! La spalancavamo con una pedata. Era come essere in un film d'azione. Naturalmente, il bagno aveva sanitari moderni, che però non funzionavano; la vaschetta immacolata dello sciacquone e il lucente scaldabagno bianco erano entrambi defunti. Uno mandava un gorgoglìo secco; l'altro non apriva mai il suo occhio rosso. Nella migliore tradizione indiana, l'acqua fredda arrivava al vaso dal secchio, e l'acqua calda per lavarsi arrivava dall' hammam con il secchio, trasportata dal portiere pelle e ossa che vacillava pericolosamente sotto il suo peso. Eravamo al settimo cielo. Niente avrebbe potuto farci diventare di cattivo umore. Fizz aprì le porte e le finestre e, chiamati a raccolta il portiere e la moglie, fece spolverare e aerare la stanza. Due ore dopo ci fece sedere sulle sedie a sdraio nella veranda, che dominava le colline lussureggianti, e fece portare delle focaccine dal mercato. Ne aveva ordinata qualcuna in più per il portiere, la moglie e i tre figli. Loro si innamorarono subito di lei, e quando con le focaccine arrivò il tè, era nero, bollente e zuccheratissimo. Slurp! Andava bevuto col risucchio. Erano le dieci passate. Il sole era luminoso, ma appena tiepido. Il freddo del mattino, però, era cessato, ed era piacevole starsene seduti sulla veranda in maniche corte. Lì non c'era il frastuono del traffico – solo un cinguettio continuo proveniente dal sottobosco. Una gioiosa combriccola di usignoli dalle guance rosa aveva preso d'assedio il prato, compiendo amichevoli scorrerie fin sulla veranda. Stavano parlando con una varietà di note. Doveva essere una festa. «Potrei vivere qui per sempre», disse lei. Sembrava la donna di un romantico quadro bucolico – i capelli ondulati sciolti sulle spalle, i piedi poggiati sul vecchio tavolo di legno, la pelle luminosa, le mani chiuse attorno a una tazza di porcellana bianca, lo sguardo perso davanti a sé. «Anch'io», dissi. «Tu potresti scrivere e io potrei allevare polli, o occuparmi di erbe di montagna», continuò lei. «Te ne intendi?» «Non ce n'è bisogno», rispose. «Serve solo un terreno a due o tre terrazze. E magari il bramino e i suoi discendenti potrebbero farci diventare ricchi.» «Già, lo diremo all'editore: tenetevi il libro e dateci un terreno a due terrazze. Anche tre, una per il bramino, una per Pratap e una per Abhay.» «Ecco! Su una ci costruiremo un cottage con due stanze, uno studio e un camino. E sulle altre due coltiveremo erbe esotiche.» «E io scriverò Gli Erbivori, uno studio su una coppia solitaria che vive in un luogo sperduto e usa erbe erotiche per strane pratiche.» «Ho detto erbe esotiche, non erotiche.» «Licenza poetica.» «Non permetterò che le mie erbe vengano usate per scopi così bassi.» «Per la letteratura, per la letteratura!» «Non per il sesso?» «Assolutamente no. Gli Erbivori è un avvincente romanzo sulle piante e sulla passione che possono scatenare. Con una prosa commovente, esplora l'eterna dicotomia tra la carne e la clorofilla attraverso la strana storia di una coppia che si destreggia tra piante malinconiche ed erezioni intempestive.» «In questo caso, ti permetterò di usare le mie erbe.» «La letteratura sarà sempre in debito con te», dissi io. | << | < | > | >> |Pagina 146La mattina ci svegliammo con una sorpresa. Il veicolo recuperato dal mio amico per trasportare le nostre cose fino a Delhi era un camion della seconda guerra mondiale convertito in autobus. Veniva usato dalla scuola di un paese vicino come scuolabus. Aveva il cofano leggermente aperto, come se faticasse a respirare. Grossi pneumatici privi di cerchioni. E due file di doppi sedili che correvano lungo uno stretto corridoio. La verniciatura recente, di colore blu, non riusciva a nascondere il suo cattivo stato.Il colonnello lo esaminò come avrebbe fatto con un cavallo, girandogli attorno, tastando le fiancate. Verificò persino il funzionamento delle porte, aprendole e chiudendole. «Avevamo un paio di questi affari al reggimento, negli anni Cinquanta. Roba resistente. Hanno servito bene Monty ad Alamein», disse. «Possono circolare?» chiesi. «Dovrebbero stare in un museo», rispose lui. Ma sappiamo che in India tutto quello che dovrebbe stare in un museo si trova in strada. E viene sfruttato fino alla fine. Dalle idee agli edifici, passando per i manufatti. Anche la gente, a dire il vero. «Colonnello sahib», dissi, «ce la farà ad arrivare fino a Delhi?» «Dovrebbe. Ha attraversato il deserto nordafricano, no?» disse sollevando il cofano con aria meditabonda. L'autobus, come avremmo scoperto, era il meno. Il problema erano i due tizi che ce lo portarono. In apparenza sembravano persone normali. Sikh di mezz'età con due lunghe barbe. Uno, l'autista, era più canuto dell'altro. Portavano entrambi il turbante e parlavano il dialetto del Punjab. Erano amichevoli, ci diedero una mano a caricare la roba. Sollevando il primo scatolone, l'autista disse: «State trasportando pietre o cosa?» «No, libri», risposi sorridendo. «Perché? A Delhi non ce ne sono abbastanza?» «Questi sono i nostri libri», dissi indicando lo scatolone. «I libri sono una perdita di tempo. Mio padre diceva sempre che si impara molto di più ad arare un campo che a leggere cento libri. Mi aveva fatto lasciare la scuola in quinta. Diceva sempre: "Se si possono trovare le risposte nei libri perché questo paese va a rotoli?" Tutti i nostri leader, da Gandhi a Nehru, hanno letto migliaia di libri.» «Questo è vero», dissi io. «I libri non sono tutti riusciti.» «Ce n'è solo uno», disse lui. «Il Guru Granth Sahib. E non c'è bisogno di leggerlo, basta ascoltarlo.» Quello più giovane, l'aiutante, disse: «Non sono una perdita di tempo. Sono una malattia. Quelli che leggono i libri credono di poter capire qualcosa della vita. Dimmi, sahib, se leggessi un centinaio di libri sul pollo tandoori, ne sentiresti il sapore?» L'autista gli diede una pacca sulle spalle e starnazzò: «Ben detto! Infili il pollo dappertutto!»
«Era solo un esempio», disse l'aiutante.
|