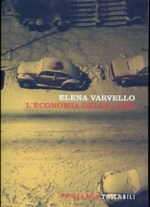
|
|
|
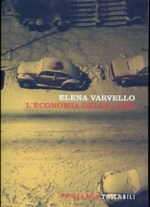
|
|
|
| << | < | > | >> |IndiceIsole 9 La pistola 23 La corsa 36 Vieni con me 40 L'economia delle cose 70 La neve dietro la porta 84 L'invasione 118 Fratelli 132 Cosa manca? 143 |
| << | < | > | >> |Pagina 9Isole
Pensava d'averlo sognato. Era convinta che fosse lui.
Camminava sulla neve, lasciandosi alle spalle una linea d'alberi,
una massa scura e compatta schiacciata sullo sfondo. Eppure
c'era qualcosa che non riusciva a capire. L'eccessiva trasparenza
dell'aria, ad esempio, e il fatto che lui sembrasse più giovane. Le
camminava incontro lasciando impronte fresche sulla neve. Non
faceva nient'altro che camminare, e lei temeva che avesse freddo,
perché portava solo una camicia. E anche questo era strano:
una camicia, d'inverno. Avrebbe voluto chiedergli dove stava
andando. Avrebbe voluto dirgli di tornare a casa. Ecco
cos'avrebbe voluto.
Sara non poteva sapere quello che sarebbe successo. Non a quel punto. Appoggiata col gomito all'anta aperta del frigo, guardava le cose sistemate sui ripiani, e un poco di ghiaccio che s'era formato sulla parete in fondo. Stava pensando alla cena: lasagne, arrosto e torta alle mandorle. Aveva letto la ricetta della torta su una rivista; accanto al testo, c'era una foto: la pasta soffice, il bordo spumoso color miele e una copertura di glassa bianca. Aveva strappato la pagina e l'aveva attaccata con una calamita alla lavagna magnetica accanto al frigo, fra le bollette da pagare e un biglietto d'auguri a forma di palloncino ricevuto dalla madre per il suo ultimo compleanno, firmato da lei — la calligrafia rotonda e precisa della madre - e dall'uomo che stava per sposare. Chiuse il frigo accompagnando l'anta col piede e scrisse su un pezzo di carta tutto quello che occorreva, battendosi ogni tanto la punta della matita sulle labbra. Aveva addosso una vestaglia di spugna sopra la camicia da notte, un paio di calzettoni di lana e i capelli raccolti con la pinza. Scrisse tutto, poi versò un po' di caffè in una tazza e ci aggiunse un cucchiaino raso di zucchero. "Ti porto il caffè", disse ad alta voce nella cucina vuota. Giorgio era ancora a letto, però aveva già acceso la luce sul comodino. Dalle coperte spuntava solo la testa: il viso affilato, gli occhi azzurro chiaro e i capelli castani che stavano ingrigendo. Aveva qualche anno più di lei ma il fatto d'aver superato da un pezzo i quaranta lo lasciava del tutto indifferente — era lei a farsene un problema, a sentire il tempo che passava sedimentarsi sulle ossa, le giunture, i muscoli del collo e della schiena. Era lei a contarsi le rughe nuove. Si sedette sul bordo del letto e gli diede la tazza. "Non è troppo caldo, puoi berlo subito", disse, poi guardò fuori, attraverso le stecche di legno delle imposte. Potrebbe essere notte, pensò. L'oscurità scivolava sui muri della casa, portandosi dietro una musica, pezzi di una canzone spuntati fuori chissà come in tutto quel silenzio. "Ho in testa una canzone", gli disse, "ma non riesco a ricordarmi cos'è." Giorgio non disse niente, fece soltanto un respiro profondo, sbadigliò e si mise a sedere, appoggiando la schiena alla testata del letto. "Guarda che fai tardi", disse lei. Lui bevve un sorso di caffè, poi fissò la forma dei propri piedi sotto le coperte. "Oggi non ci vado, al lavoro", disse, e con la mano libera si sistemò i capelli, li tirò indietro. "Telefona tu e dì che non sto bene, che non me la sento." Aveva una ditta che si occupava di riparazione e assemblaggio di computer. Qualche volta lei gli andava a dare una mano: contabilità, fatture da evadere e cose del genere. "C'è qualcosa che non va?" Lui la guardò e fece una piccola smorfia di disappunto. "Perché dev'esserci per forza qualcosa che non va? No, non c'è niente. È solo che non penso ci siano problemi, se per una volta sto a casa. O no?" "Sì, sì, va bene, chiedevo solo. Però potevi dirmelo ieri, almeno non mettevo la sveglia. Potevamo dormire di più." "Ieri non lo sapevo. È adesso che mi sento così. Può capitare." "Ok, va bene. Nessun problema, ho detto. Bevi il caffè, che s'è già freddato. Telefono io", disse lei, tornando a guardar fuori. Nel buio, le sembrava che un vento leggero muovesse le poche foglie rimaste sui rami in attesa d'essere spazzate via. "A proposito, devo andare a fare la spesa. Mia sorella non viene mai e voglio prepararle qualcosa di buono. Anche se lo so che vuole soltanto parlare di mamma. Ehi", disse, distendendo le labbra in un sorriso, "potresti uscire con me, se ti va. Potremmo andarci insieme." A vederla così, si sarebbe detto che fosse felice, con quel sorriso lungo, acceso, come se lui le avesse proposto di prendere l'auto e andarsene in giro, come se stessero organizzando una gita dopo tanto tempo. Giorgio bevve quel po' di caffè ch'era rimasto, poi appoggiò la tazza sul comodino e rimase seduto sul letto, nel suo pigiama grigio coi polsini lisi. Incrociò le braccia. "Non me lo ricordavo, che venisse qualcuno", disse. Sara cercò di continuare a sorridere. Era come se il suo viso si fosse ridotto a quello. Tutto bocca. "Non è qualcuno. È mia sorella. Non la vedo mai. E te l'ho detto l'altra sera. Che fai, inizi a dimenticarti le cose?" "Be', neanche i miei li vediamo mai. È solo una scocciatura. E poi non sono ancora arrivato a quel punto." "Lasciamo perdere, non roviniamoci la giornata, d'accordo? Io vado a fare la spesa. Se non hai voglia, non devi venire per forza. Però potresti dare un'occhiata al rubinetto del bagno, visto che sei a casa. Stanotte l'ho sentito gocciolare", disse lei, poi si aprì la vestaglia e si passò una mano sopra il seno, lungo il bordo della camicia da notte. Giorgio la guardò, poi si mise a fissare l'armadio. "Va bene, vengo. Non c'è niente di peggio che parlare sempre delle stesse cose." "E il rubinetto?" "Ne dobbiamo discutere adesso?", disse lui. "E comunque io l'acqua non l'ho sentita. Ma tu che fai, non dormi, la notte?" Sara appoggiò entrambe le mani sul letto e distese la schiena. C'era qualcosa di strano, fuori, un'ombra fra gli alberi in quell'abbozzo d'inverno. "Be', ogni tanto mi sveglio", disse. Le capitava spesso, negli ultimi tempi; spalancava gli occhi, andava in bagno senza neppure accendere la luce e quando tornava a letto si metteva a pensare a sua madre, al fatto che si fosse tinta i capelli di una specie d'azzurro e che dicesse di volersi risposare perché si sentiva troppo sola, dopo la morte del marito, e pensava all'uomo che aveva deciso di sposare, uno che aveva conosciuto al circolo, più basso di lei, sempre infilato in giacche dai colori improbabili, un campione di bocce, diceva sua madre, e una specie di malinconia le chiudeva la gola, le pungeva la lingua, impedendole di riaddormentarsi.
"Non me lo ricordavo, di tua sorella", disse lui, poi si sdraiò
di nuovo sotto le coperte e si girò su un fianco.
Il parcheggio era quasi deserto. La porta scorrevole rifletteva una manciata d'auto e un albero rinsecchito vicino alla zona carrelli. Giorgio si fermò lì accanto e scesero entrambi. "Tu entra, io t'aspetto qui", le disse, appoggiandosi al cofano, le mani infilate nelle tasche del giaccone. Un ragazzo uscì dalla porta scorrevole portando fra le braccia una grossa scatola di cartone. Aveva un berretto su cui era stampato il nome del supermercato. Sara lo guardò camminare fino ai cassoni dell'immondizia, poi si girò verso il marito. "Perché non entri? Fa freddo. Puoi aspettarmi al bar e bere un caffé", gli disse, anche se era convinta che non la stesse nemmeno ascoltando. Non gli piacevano i supermercati e quei parcheggi costeggiati da aiuole che nessuno si preoccupava mai di curare. Sono desolati, diceva. L'aveva ripetuto anche durante il viaggio, poco prima d'arrivare. Desolati. Cumuli di vetro e cemento, tutto qui, in cui non si fa altro che comprare e comprare. Sara non sapeva che dire, quando lui attaccava con quei discorsi: a lei posti del genere non dispiacevano. Ci trovava quancosa di buono, soprattutto nelle mattine serene d'inverno, quando il cielo si rifletteva sui vetri a specchio e l'asfalto sembrava così lucido, così pulito. E poi si sentiva una stupida, a sentirlo parlare in quel modo: le faceva venire il dubbio che, per qualche motivo, potesse avere ragione, che fosse lei quella che non capiva, che non fosse sveglia abbastanza da vedere oltre il suo naso. "Va be', allora aspettami qui. Faccio in fretta. Però abbottonati la giacca", gli disse, prima d'andare a prendere il carrello, mentre lui s'accendeva una sigaretta. | << | < | > | >> |Pagina 36La corsaMaria alzò appena lo sguardo, quanto bastava per vedere suo figlio scivolare verso il fondo della discesa, la macchia rossa del bob sul bianco della neve. S'era chinata per allacciarsi lo scarponcino, solo un momento, una manciata di secondi, anche se più di quanto avesse previsto, mentre il bambino prendeva velocità, poi aveva sentito la frenata e il rumore delle gomme che slittano. Un colpo sordo, senza eco, attutito dalla massa di neve. Aveva le mani intirizzite. Non si era infilata i guanti, sottovalutando la temperatura, l'aria pungente che soffiava a raffiche forti e improvvise, e il sole che stava tramontando dietro la cima delle montagne. E poi suo figlio le saltellava intorno e la tirava per la maglia e correva da una parte all'altra dell'appartamento, impaziente di uscire per non perdersi niente di quello spettacolo. Bisognava infilargli la tuta, assicurarsi che la neve non entrasse dal bordo dei Moon boot, tirargli su le calze – che invece lui voleva arrotolate intorno alle caviglie – cercare di convincerlo ad annodarsi la sciarpa intorno al collo. A ogni imposizione diventava più insofferente, piagnucolava e ostacolava i movimenti della madre. E così Maria aveva dimenticato i guanti, o meglio, aveva deciso di non prenderli. Pensava che fosse un particolare trascurabile, una cosa di cui avrebbe potuto fare a meno. Erano usciti in fretta, e i guanti erano rimasti li, sul tavolo, i guanti di camoscio che suo marito le aveva regalato a Natale. Quando vide i lacci dello scarponcino appoggiati come serpenti sulla neve, mentre erano ancora tutt'e due in cima alla pista e il bambino s'era appena seduto sul bob, lasciò andare la corda con cui lo stava tenendo, si chinò e fu allora che scoprì di fare fatica a muovere le dita. Questa fu la prima cosa. Le dita erano rigide, insensibili, arrossate, perciò impiegò tanto tempo per allacciarsi lo scarponcino, anzi per iniziare ad allacciarselo, anche se poi non era tanto, il tempo, effettivamente, ma troppo, alla fine. Ed era stato allora, quando s'era chinata, quando aveva lasciato la corda, che il bob era partito, come spinto da una mano invisibile, e aveva iniziato la sua corsa, prendendo velocità man mano che scendeva. Era stato allora che Maria aveva alzato lo sguardo e aveva visto. Non si era alzata. Era rimasta accucciata, il corpo paralizzato, i muscoli bloccati. E dunque la scena si era composta così: lei ferma, piegata sulle ginocchia, la testa alzata, il collo teso, il mento leggermente spinto in avanti, e il bob lanciato verso il fondo della pista, verso la curva nascosta dagli alberi, come se lo spazio si fosse diviso in due, una parte statica – un fermo immagine, una foto – l'altra in movimento. Ma comunque la sua immobilità era stata solo apparente. Era ciò che si offriva alla vista, allo sguardo degli altri. Se ci fosse stato qualcuno ad assistere alla scena. Perché in realtà, dentro di lei, tutto si muoveva, con una rapidità che non aveva mai sperimentato prima. Il pensiero, soprattutto: una sequenza di ipotesi e soluzioni possibili. Fra cui: mettersi a correre dietro il bob, cercando di raggiungerlo per poi fermarlo in qualche modo. Oppure: urlare – Tira i freni, Buttati per terra e altre indicazioni efficaci, comprensibili. O ancora: fare entrambe le cose, correre e urlare nello stesso tempo, così da sommare le alternative e assicurasi la riuscita migliore. Invece era rimasta ferma. Aveva assunto un ruolo imprevisto, non calcolato, con cui avrebbe dovuto fare i conti in seguito, in ospedale innanzi tutto, e poi a casa, circondata dai parenti, mentre il marito stava seduto sul divano a fiori con la testa fra le mani e lei sapeva che non sarebbe riuscita a trovare risposte soddisfacenti per nessuno. Era diventata una spettatrice – è così che succede? – era rimasta ad aspettare, mentre impulsi elettrici partivano dal cervello e si diramavano lungo il corpo, attraverso il sistema nervoso, imponendo ordini che si ostacolavano gli uni con gli altri. In qualche modo si era affidata al destino, senza volerlo, certamente, ma senza riuscire a fare altro. Come quando uno dice: vediamo un po' cosa succederà. Stiamo a vedere. Non poteva escludere di aver pensato perfino che la discesa, magicamente, si sarebbe appianata. Che sarebbe intervenuta qualche forza esterna a cambiare le cose. Anche se non lo avrebbe chiamato miracolo, certo che no, ma solo un disegno nuovo della realtà. Un altro dei mondi possibili. Tutto questo aveva occupato una manciata di secondi. Secondi persi per sempre, soffiati via come polvere, che avrebbero fatto la differenza fra una cosa e l'altra, fra una fine e l'altra. Poi aveva sentito la frenata, e aveva visto l'auto, e l'auto e il bob si erano confusi in un'unica macchia indistinta. Allora, in quel momento esatto, si era alzata e aveva iniziato a correre giù per la discesa, scivolando, cadendo per terra, rialzandosi, gridando il nome di suo figlio. La portiera si era aperta ed era scesa una persona – uomo, donna, non lo sapeva, non le interessava saperlo. Non rientrava nel suo campo visivo, adesso, focalizzato su un punto preciso della macchia, immobile, un punto rosso sul davanti dell'auto. Era un uomo, in realtà, ma questo lo avrebbe capito dopo, e non per averlo visto, ma per averne sentito la voce, bassa, inutile, dispersa dal vento, mentre lei si chinava sul bambino. E quindi i ruoli si erano invertiti: adesso era lei a essere in movimento, mentre la corsa di suo figlio s'era fermata, o meglio, era stata fermata dall'auto. Maria stava facendo adesso quel che avrebbe dovuto fare prima, se il corpo glielo avesse permesso, se ne fosse stato capace. E mentre correva, spingendo sui muscoli delle gambe, sentendo il sangue che pulsava di nuovo, veloce, a ondate lunghe e calde, dando ai muscoli ciò di cui avevano bisogno – ossigeno, zuccheri, energia – non pensava più a niente, come se la corsa avesse zittito il cervello, ne avesse bloccato i meccanismi, i processi. Solo, le sembrava di essere troppo lenta, troppo goffa. Impacciata. Non guardava dove metteva i piedi – per questo scivolò, perdendo ancora tempo. Guardava il punto in cui l'automobile e il bob si erano fermati, guardava quel punto rosso luminoso circondato dal bianco sporco della neve. L'unica cosa importante adesso era la corsa. Come quand'era ragazzina, e d'inverno usciva dopo la prima nevicata, in quella luce azzurra e strana, incurante del freddo, e correva nella neve, affondando i piedi, bagnandosi tutta, e correva, correva cadendo sulle ginocchia, correva e si rialzava, la neve appiccicata ai pantaloni come schizzi di fango, correva, e i rami degli alberi erano merletti che decoravano il cielo, correva fin quando sentiva la voce di sua madre venire da un punto alle sue spalle. "Entra subito", le diceva la voce che scavalcava la distanza e i fiocchi di neve che cadevano ondeggiando. "Entra che se no ti bagni", ma lei voleva bagnarsi, in effetti, senza pensare alle conseguenze, perché allora non c'era nient'altro che il momento presente, tagliato fuori dalla corrente del tempo, senza prima né dopo, come non sarebbe stato mai più. La sensazione di essere solo un corpo in movimento, un corpo che faceva ciò che sapeva fare meglio, ciò per cui era nato, e la certezza che il movimento fosse fine a se stesso. Magnifico, perfetto. Una cosa perfetta in una luce azzurra. | << | < | > | >> |Pagina 70L'economia delle coseUna sera – era autunno inoltrato – mio zio è arrivato da noi senz'avvertire. Si è seduto in cucina – avevamo appena finito di mangiare – ha spostato il cestino della frutta e ha tirato fuori un pacchetto di sigarette sgualcito, allungando le gambe sotto il tavolo. Gli ho chiesto come mai fosse venuto da solo, perché l'ultima volta aveva portato una ragazza carina che rideva spalancando la bocca e battendosi le mani aperte sulle ginocchia. Non ricordo quale fosse il suo nome, però mi ricordo che aveva i capelli neri e lucidi come le piume di un merlo. Gliel'avevo detto, e lei s'era messa a ridere guardando lo zio, poi, fra una risata e l'altra, aveva fatto cip cip agitando le braccia nell'aria, come se fosse veramente un uccello. Anche lui s'era messo a ridere. Aveva l'alito che sapeva di vino e teneva una sigaretta spenta fra le dita. "A volte i grandi hanno bisogno di star soli", ha detto lui, "devono pensare a cose importanti." Mia madre ha sorriso appena. Stava appoggiata allo stipite della porta e teneva le braccia incrociate. "E cioè?", gli ha chiesto. A guardarli bene, non s'assomigliavano per niente, pur essendo fratello e sorella; però avevano proprio lo stesso modo di sorridere. "Che ne so... costruire la macchina del tempo, oppure inventarsi qualcos'altro... pensare agli extraterrestri. A proposito, avete visto ET?" Io ho fatto di sì con la testa, certo che l'ho visto, e ne abbiamo parlato per un po'. L'avevano dato in quel cinema che poi avrebbe preso fuoco, riducendosi a un ammasso contorto di poltroncine, travi di legno, brandelli d'imbottitura e pezzi carbonizzati di moquette. Ci sarebbero morte delle persone, là dentro, anche il cugino di uno che veniva a scuola con me. Ma a quel punto non era ancora successo niente. La domenica pomeriggio quel posto si riempiva di ragazzini e c'erano montagne di cappotti e berretti che sapevano di pioggia e lana umida. A volte era persino difficile capire le battute del film, tanto rumore c'era in sala; tutti a piangere e a tirare su col naso mentre ET se ne sta sdraiato sotto una calotta di plastica, col cuore rosso fuoco che smette lentamente di battere. Mi piaceva parlare di certe cose, erano tutte importanti. La macchina del tempo, come nei film di fantascienza. I viaggi nello spazio. Un extraterrestre vestito da vecchia signora che spunta fuori da un armadio nella stanza di un ragazzino. Alla fine mio padre m'ha guardato e ha detto: "Capito lo zio? È molto occupato, se deve pensare a cose del genere. Beato lui. Adesso però devi andare a dormire", e io ho protestato e mi sono agitato un po' sulla sedia perché volevo stare ancora lì, e ho detto e ripetuto che non avevo sonno, che era presto, finché mia madre ha detto, niente storie, domani c'è scuola, e si è staccata lentamente dallo stipite della porta, come se facesse una gran fatica, mi ha appoggiato la mano sul braccio e l'ha stretta e io ho sentito il suo calore attraverso la manica e anche un leggero odore di cipolla e cose fritte. Lo zio si è allungato verso di me, mi ha dato una pacca sulla spalla e ha fatto l'occhiolino. "È ora", ha detto. "Coraggio." Mia madre m'ha accompagnato in camera ed è rimasta a guardarmi mentre mi spogliavo e mi mettevo il pigiama. Teneva ancora le braccia incrociate sul petto e la testa piegata di lato – mi sembra d'averla sempre vista in quel modo. Canticchiava una canzone. Mi dava un gran fastidio che non mi lasciasse fare da solo – in fondo ero abbastanza grande, ormai, eccome – e mi dava pure fastidio che a volte entrasse in bagno senza bussare e poi dicesse cose del tipo, chissà cosa sta facendo questo bambino, così mi sono girato verso il muro per togliermi le mutande e infilare i pantaloni del pigiama, mentre lei accennava qualche parola di quella sua canzone, poi sono scivolato nel bianco freddo e umido delle lenzuola. Lei ha aspettato che mi sistemassi per bene poi, quando ho appoggiato la testa sul cuscino, ha spento la luce. "Vado di là", ha detto. S'era trasformata in un'ombra in quel po' di chiarore che veniva dal corridoio. "Vado a parlare con lo zio. Buonanotte. Dormi bene." Ho socchiuso gli occhi per riuscire a vederla meglio, in penombra, alta, pesante, immobile; aveva appoggiato una mano sulla sbarra del letto e ha ripetuto, buonanotte, come per assicurarsi che mi addormentassi davvero, che ne fossi convinto anch'io. "Adesso che fate?", le ho chiesto. "Niente. Parliamo un po', poi me ne vado a dormire. Sono stanchissima. Notte", e se n'è andata. Ho sentito i suoi passi lungo il corridoio. Era come se potessi vederla camminare. "Eccomi qui. A posto", ha detto, una volta in cucina, tutta contenta come se fosse appena arrivata a una festa. Aveva la voce squillante dei suoi momenti migliori, la voce di una ragazza alla quale è appena stato fatto un complimento. "Allora, che ci racconti?", ha chiesto, e mio zio ha detto, niente, tutto bene, fermati un attimo, siediti, e subito dopo ho sentito mio padre – la sua voce bassa e scura da ex fumatore – che parlava con quel modo lento che aveva di dire le cose che gli sembravano importanti. Ha detto: "Stavamo parlando della fabbrica". Per un attimo c'è stato solo silenzio, poi papà ha detto: "Gli stavo dicendo che fa veramente schifo. Dovrebbe venire a vederla. A volte mi chiedo perché uno si sbatta tanto per finire a lavorare in un posto così", e poi ha raccontato una cosa ch'era successa a un operaio, un ragazzo di appena vent'anni – uno piccolo e magro con la faccia da bambino – che s'era schiacciato una mano sotto la pressa, un po' di tempo prima. Urlava così tanto da coprire il rumore delle macchine. La pressa si era bloccata e c'era voluto un sacco prima di riuscire a far alzare la parte superiore. E dopo c'era stata l'ambulanza, e la corsa all'ospedale, e un mucchio di sangue da pulire. "Non riesco nemmeno a parlarne", ha detto. Sembrava che respirasse forte, come se avesse appena fatto una corsa. "È una cosa pazzesca. Come si fa a lavorare ancora dopo una cosa così?" Qualcuno ha spostato una sedia. Non sentivo più la voce dello zio, però sapevo che stava fumando. L'odore del fumo era arrivato fino in camera mia. "Dio santo, che roba", ha detto mia madre. Non so come, ma sapevo che stava scuotendo la testa. Era il suo modo per esprimere stupore di fronte alle cose strane e inspiegabili che le capitava di sentire. "Va be', che vuoi farci? È andata così. Speriamo che si rimetta, poveraccio. E allora. Tu come stai? Tutto bene?" "Abbastanza", ha, detto lo zio. "E, le donne?" "Alla grande." "Benissimo, allora tutto a posto. E vai", ha detto lei, e ha fatto qualcosa come una mezza risata, una cosa piccola piena di promesse. "Certo che a te non te ne importa di niente. Guarda che sei un bel tipo", ha detto mio padre. "Non è questo", ha detto lei. "Solo che non mi sembra il caso di parlarne adesso. Tanto non possiamo mica cambiare le cose. È andata così, meno male che non è successo a te." "Ah, sicuro", ha detto lui. "La cosa importante è quella. Per il resto, uno deve abbassare la testa e buttare giù." "Non ho detto questo. Che c'entra? Ne abbiamo già parlato. Almeno è un lavoro. Cioè, è qualcosa. Finché io non riesco a trovare. A proposito, sono stata a un colloquio. Hanno detto che mi fanno sapere. Ho una sensazione positiva. Lo dice anche l'oroscopo. Sarà un anno fantastico." Era una divoratrice d'oroscopi. Qualche volta faceva persino le carte. Aveva preteso di farle anche a mio padre, solo che poi gli aveva detto che non riusciva a leggerle bene perché lui non la prendeva sul serio. Mi diceva sempre che ero nato sotto il segno del Leone, e che quindi ero uno di carattere e avrei avuto una gran vita davanti. "Ah", ha detto mio zio. "Hai fatto bene. Un colloquio per cosa?" "Cercano una segretaria, nello studio di un dentista. Eh, che ne pensi?, dovrò comprarmi un po' di vestiti nuovi?" "Be', direi. Ti conviene andare in uno di quei negozi in centro", ha detto lo zio. Poi sono rimasti tutti zitti per un po'. C'era solo il rumore delle automobili lungo la strada e il cane dei vicini che abbaiava. Quel cane mi faceva una gran pena, perché veniva tenuto legato nella parte non asfaltata di un cortile, e quando pioveva era costretto ad accucciarsi per terra e il pelo gli diventava tutto sporco e chiazzato di fango. Qualche volta, senza che nessuno mi vedesse, gli tiravo dei pezzi di pane dalla finestra. Poi lo zio ha detto: "Chissà, staremo a vedere", e c'era qualcosa, nel modo in cui l'aveva detto – la voce stentata di chi ha appena smesso di piangere o sta per iniziare – che non mi piaceva affatto, come se gli fosse capitata una cosa brutta e lui non avesse il coraggio di dirlo. Anche se ero sicuro che a me l'avrebbe detto. Magari c'entrava con quello a cui stava pensando in quel periodo, o con il fatto che fosse venuto da solo, senza nemmeno avvertire. "Be', almeno tu fai un lavoro che ti piace", ha detto mio padre. "E questo che c'entra?", gli ha chiesto lui. "Guarda che è importante. Non è mica da scherzarci. Alla fine della fiera, passi tutto il tuo tempo a lavorare, questo è il fatto."
Per un po', mio padre s'era occupato di politica; in quel
periodo parlava sempre di cose misteriose come riunioni sindacali e scioperi e
minimo salariale – ne parlava a cena e qualche
volta alzava la voce, mentre mia madre faceva avanti e indietro
dalla cucina e io dividevo le cose nel piatto secondo una scala
cromatica che avevo adottato all'epoca – ma da un po' di tempo
sembrava che non gliene importasse più nulla. Adesso diceva
solo che era stanco, e che non c'era niente da fare, che le cose si
stavano mettendo al peggio, per tutti loro.
|