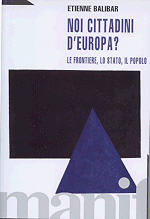
|
|
|
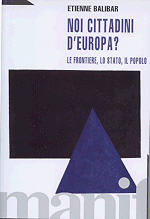
|
|
|
| << | < | > | >> |IndiceIntroduzione di Anna Simone e Beppe Foglio 7 Nota dell'autore 13 Prefazione. Dalle frontiere dell'Europa 23 PARTE PRIMA LA CRISI DEL COMUNITARISMO NAZIONALE 37 1. Homo nationalis. Annotazioni antropologiche sulla forma nazione 39 2. Il «droit de cité» o l'apartheid? 65 3. Una cittadinanza senza comunità? 91 PARTE SECONDA VIOLENZA DELLE FRONTIERE, VIOLENZA SENZA FRONTIERE 125 4. Violenza e mondializzazione: una politica della civiltà è possibile? 127 5. Verso una cittadinanza imperfetta 151 PARTE TERZA IL POTERE DEL POPOLO E L'AVVENIRE DELLA CITTADINANZA IN EUROPA 161 6. Prolegomeni alla sovranità 163 7. Europa difficile: i cantieri della democrazia 191 Note 223 |
| << | < | > | >> |Pagina 25Io parlo delle «frontiere d'Europa» dalla Grecia, in uno dei paesi che, per configurazione geografica, appare come «periferico», nonostante porti con sé il passato di una mitologia importante e di una serie di eventi storici ormai stratificati oltre che di estrema importanza. La stessa Salonicco è situata su un confine di questo paese di frontiera, in un luogo in cui si rimette periodicamente in gioco la dialettica e il confronto con lo straniero (trasformato in un nemico ereditario) e la comunicazione tra le civiltà, senza la quale non ci sarebbe stato progresso alcuno dell'umanità. Mi trovo, quindi, più che mai immerso nel bel mezzo del mio oggetto di studio, con tutte le difficoltà che ciò comporta. La parola «frontiera» è estremamente polisemica. A partire da ciò costruirò la mia ipotesi di lavoro anche se la frontiera stessa sta cambiando radicalmente il suo senso originario. Le frontiere delle nuove entità politico-economiche, nelle quali si tenta di preservare le funzioni della sovranità degli Stati, non sono più necessariamente collocate sui confini dei territori: esse sono sparse un po' ovunque, laddove avviene e si controlla il movimento delle informazioni, delle persone e delle cose, per esempio nelle metropoli. Ma è anche una mia tesi quella secondo cui le zone cosiddette periferiche, presso cui si incrociano e si confrontano le culture laiche e religiose, dove si acuiscono e si innervano le differenze economiche, costituiscono il fulcro della formazione del popolo (demos), senza il quale non vi può essere cittadinanza (politeia) nel senso acquisito da questo termine dall'antichità sino alla tradizione democratica contemporanea. Da questo punto di vista, i paesi, le zone e le città di frontiera non sono marginali rispetto alla costituzione di uno spazio pubblico, ma, al contrario, ne rappresentano il pieno centro. Se è vero che l'Europa è, innanzitutto, un problema politico non risolto è altresì vero che la Grecia, per esempio, è uno dei suoi centri. Non solo perché rappresenta le origini mitiche della nostra stessa civiltà simbolizzate dall'Acropoli di Atene, ma anche e soprattutto per i problemi dell'oggi. O, più esattamente, la nozione di centro ci mette dinanzi ad una scelta. Essa può avere una significazione classica come nella tradizione del concetto di Stato, per cui: concentramento dei poteri e localizzazione dei dirigenti apparenti o reali che siano. Da questo punto di vista, il centro dell'Europa potrebbe essere Bruxelles o Strasburgo o, ancora, la City di Londra e la Borsa di Francoforte, oppure Berlino, la capitale più importante degli Stati che dominano la costruzione dell'Unione Europea, come Parigi e la stessa Londra. Ma la nozione di centro può anche avere un altro significato, più importante e più difficile da cogliere. Tale significato designa i luoghi di costituzione del popolo attraverso la presa di coscienza civica e la risoluzione collettiva delle contraddizioni che la attraversano. Esiste, quindi, un «popolo europeo», anche se solo in via di definizione? Niente è meno sicuro. Se, tuttavia, non ci sarà un popolo europeo, un popolo di tipo nuovo, la cui definizione è ancora a venire, non ci sarà neanche una sfera pubblica o uno Stato europei, aldilà delle apparenze burocratiche. Si può dire, come ho fatto qualche anno fa parafrasando una celebre formula di Hegel: Es gibt keinen Staat in Europa. L'importante è porre la questione e parla nella sua «centralità», proprio nei luoghi di frontiera. | << | < | > | >> |Pagina 41Per questo saggio avevo pensato a due titoli: Ambiguità dell'universale o Antropologia della forma nazione. In ogni caso avrei peccato di troppa ambizione, nel primo caso avrei dovuto sviluppare una tesi ermeneutica con tutte le sue conseguenze, nel secondo caso avrei dovuto delineare un modello esplicativo completo. Mi accontenterò, invece, di mettere un po' d'ordine in un insieme di questioni suscitate dal dibattito teorico che ci viene proposto sulla nazione, tenendo conto anche della prospettiva ermeneutica legata al tema delle ambiguità dell'universale e del progetto di uno studio antropologico di alcune questioni poste dalla storia, dal sociale e dall'evoluzione stessa della forma nazione. Spetta a voi, comunque, decidere o pensare se queste aperture e problematizzazioni possono confluire in una problematica unica. Più specificatamente, vorrei procedere ad un esame critico del rapporto che intercorre tra «nazione», «forma nazione» (o formazione sociale nazionale) e «nazionalismo», tenendo conto di tre grandi questioni: la storicità delle nazioni e del nazionalismo, la questione delle identità nazionali e infine il problema della violenza strutturale connessa ad esse. I tre aspetti del problema non vanno confusi ma interconnessi. Li metto insieme perché sono convinto che siamo in una situazione critica la quale attraversa, contemporaneamente, la stabilità delle istituzioni dello Stato-nazione e l'egemonia della forma nazione sulle grandi strutture sociali, dall'educazione sino alla politica economica. Questa situazione ci costringe a rimettere in discussione il concetto di nazionalità e di nazionalismo, la nostra concezione delle identità collettive, dei processi di soggettivazione, della violenza implicata in essi (in particolare la guerra) e dei contrasti che tali processi impongono alla politica. Inoltre tale situazione ci costringe, a causa della sua stessa incertezza, a domandarci in che modo le categorie di storicità, d'identità, di violenza, di azione politica siano strettamente dipendenti dal concetto stesso di nazione. O, per dirla altrimenti, questa situazione costringe ognuno di noi a chiedersi se è un «essere sociale» (animale sociale), un «soggetto economico» (homo úconomicus) o un «essere nazionale» (homo nationalis). » certo che noi non siamo racchiudibili in quest'ultima definizione, ma è anche vero che non facciamo molto per fuggire da questa categoria che pervade il nostro modo di pensare e di agire. Non abbiamo ancora opposto con forza un punto di vista rovesciato, per esempio una concezione del mondo «internazionalista» o «cosmopolita» (termini che evocano, del resto, la pregnanza del riferimento alla nazione). » dal nostro interno che occorre cominciare a discutere i limiti e i particolarismi esistenti nella nostra concezione universale della storia, dell'identità, della violenza o della politica. Questi concetti, oggi, sono ancora in rapporto alla nazione. [...] Parlare del ritorno alla forma nazione o direttamente del postnazionalismo non fornisce né alternative, né alcun contributo utile per chiarire meglio la situazione in cui siamo. La situazione, infatti, è assai più complessa. Essa ci impedisce di ricorrere a delle parole d'ordine semplici, universali, sia per quel che riguarda la difesa della nazione (cittadinanza nazionale, cultura nazionale, politiche sociali solo nel quadro della nazione se non addirittura solo per i «nazionali»), sia per quel che riguarda l'oltrepassamento della nazione (istituzioni sovranazionali o procedure transnazionali) andando ad appoggiare tendenze assai diverse come la «nuova economia» mondializzata, la coscienza ecologica, l'internazionalizzazione dei modelli culturali. Ma questa complessità, scomoda sul piano pratico e ideologico, può diventare una chance per la teoria: può essere l'occasione per cominciare a pensare, senza semplificare, i problemi reali del nostro tempo. | << | < | > | >> |Pagina 149CONCLUSIONEPiuttosto che giungere a conclusioni definitive, vorrei semplicemente suggerire alcune riflessioni per rilanciare la discussione: 1) L'esistenza di una violenza istituzionale generalizzata ripropone, inevitabilmente, la questione della contro-violenza: alla contro-rivoluzione preventiva non bisognerebbe forse opporre, simmetricamente, la rivoluzione? Alla contro-insurrezione, l'insurrezione? Questa logica, per un verso, ha spinto a considerare il XX secolo «il secolo degli estremi», secondo il titolo del libro di Hobsbawm, divenuto immediatamente un classico... Per quanto sia sempre necessario trasformare strutture di dominazione sociale e rapporti di potere che ormai eccedono la loro «misura» interna o hanno annullato ogni contro-potere, credo che bisogna rispondere negativamente, o meglio bisogna dislocare e complicare la questione. Fare questo ci riporta all'articolazione della cittadinanza (sempre fondata, in ultima analisi, sulle «insurrezioni costituenti» del diritto ai diritti) con le politiche di civiltà. La dissimmetria politica fra dominanti e dominati deve, cioè, essere esplicitamente iscritta nella differenza delle logiche spaziali (riarticolando, in particolare, i rapporti fra «globale» e «locale» e la legittimità dei poteri istituiti) e nei metodi per garantire la pace e la sicurezza (rivalorizzando, per esempio, le procedure che prevedono la partecipazione popolare al posto delle rappresaglie o delle misure tese, semplicemente, ad arginare la violenza). Ancora, è necessario - pensiamo al contro-esempio della Jugoslavia - che la partecipazione apra delle vie d'uscita e non diventi, a sua volta, oggetto di ricatto e di ingiunzioni minacciose. 2) Una politica della civiltà richiede, dunque, uno sforzo per trasformare radicalmente le strutture di dominio, per democratizzare e incivilire lo Stato, nonché per incivilire la rivoluzione, la rivolta e l'insurrezione. L'una non può darsi senza l'altra. Contrariamente, infatti, alla rappresentazione che i marxisti degli anni 30-50 avevano del fascismo come «strumento dei trusts» e dell'imperialismo, o a quella più recente (con beneficio d'inventario) che gli zapatisti messicani hanno della «difesa dell'umanità contro il neo-liberismo», gli atteggiamenti violenti e xenofobi, o più in generale, l'odio e la paura dell'alterità non sono esclusivi dei dominanti, ma si manifestano anche fra i dominati. Non esiste affatto qualcosa come una «buona natura dei dominati». La politica di civiltà non può assolutamente fondarsi su un'ideologia «vittimaria». Il diritto ai diritti deve essere ottenuto con nobili lotte, ma esso non tollera più, o tollererà sempre meno una dissociazione dell'«etica della convinzione» dall'«etica della responsabilità». 3) Si ammetterà, dunque, che la civiltà come politica dell'anti-violenza implica necessariamente uno sviluppo del diritto internazionale. | << | < | > | >> |Pagina 165» diventata un'abitudine, ormai, associare le incertezze della costruzione europea, nel contesto della nuova fase di mondializzazione, con l'idea di una crisi della sovranità. Molto spesso, però, tale formula viene intesa in senso restrittivo, perché si identifica a priori la nozione di sovranità con la sua forma nazionale e, allo stesso tempo, si suggerisce un'equivalenza fra crisi della sovranità e sviluppo di spazi politici sovra-nazionali, trans-nazionali o post-nazionali. Tale restrizione, a mio avviso, assumendo la forma di un'opposizione binaria, incorre in tre inconvenienti tra loro connessi. Le alternative alla sovranità che affliggono, in particolare, l'attuale situazione europea non sono riducibili ad un solo tipo. Se ne possono evocare almeno tre: la sussidiarietà, il federalismo e l' impero. Quanto alle loro origini, queste alternative non appartengono «alla stessa epoca». L'idea di sussidiarietà rimanda ad istituzioni premoderne, coeve della feudalità, delle franchigie medievali e delle gerarchie di competenze imperiali o ecclesiatiche. Nelle sue differenti concezioni (Saint-Pierre, Kant, Proudhon, Coudenhove-Kalergi, etc...), il federalismo ha costituito quasi il rovescio della sovranità nazionale moderna, pronto ad assumere una posizione di primo piano tutte le volte che la sovranità nazionale ha attraversato fasi di mutamento o di crisi nel corso degli ultimi quattro secoli. L'impero, infine, descrive, nell'accezione proposta da Hardt e Negri, il nuovo ordine politico, economico e comunicazionale nato dalla decolonizzazione, dalla fine della guerra fredda e dalla rivoluzione informatica. Esso, però, è continuamente alla ricerca delle proprie istituzioni sul crinale di conflitti dall'esito rischioso e, allo stesso tempo, rappresenta un'innovazione postmoderna del concetto stesso d'impero. Il fatto che queste alternative appartengano ad epoche diverse non pregiudica il loro avvenire e non impedisce affatto che possano esservi delle influenze reciproche, ma è evidente che privilegiare una forma o l'altra induca, di rimando, a punti di vista differenti sulla natura e sulle potenzialità storiche dello Stato-nazione «sovrano». La confusione propria delle attuali discussioni sul post-nazionale fornisce a riguardo un'esemplificazione eloquente. Inoltre, l'idea secondo la quale il ritrarsi della sovranità è essenzialmente causato da un fenomeno di disgregazione delle nazioni che abolisce le frontiere e rimette in questione la loro funzione politica, oscura il nesso problematico tra le nozioni di sovranità dello Stato e di sovranità del popolo. Pare, infatti, che, pur concettualmente ben distinta, la loro realtà sia simultaneamente affermata e negata. Derivano da ciò le attuali difficoltà nel discutere la pertinenza dell'idea di sovranità democratica al livello delle istituzioni sovranazionali, senza confonderla con una difesa dello Stato centralizzato e del nazionalismo (come fanno generalmente i «sovranisti»). Oggi più che mai vale l'avvertimento contenuto nell'allegoria di Nietzsche: «Io, lo Stato, sono il popolo!». Ogni volta che viene invocato il popolo, è piuttosto l'interesse dello Stato - di un certo Stato - a parlare. Ma resta altrettanto enigmatica, se non contraddittoria, l'idea di una sovranità popolare - decisione collettiva, rappresentanza degli interessi di massa dei cittadini e controllo dei governanti da parte dei governati - separata dalla forma statale Una genealogia della sovranità risulta, pertanto, piuttosto mascherata e non illuminata dall'alternativa corrente tra sovranità nazionale e «costellazione postnazionale».
Di qui la terza difficoltà. Sarà senza dubbio importante, nella fase
attuale, dare un contenuto chiaro e operativo alla
nozione di «popolo europeo». Bisognerà, per meglio dire, conferire un'esistenza
politica al «popolo in Europa» (senza la quale la cittadinanza europea rimarrà
una mistificazione), sia dal punto di vista dell'appartenenza e delle frontiere
sia da quello delle implicazioni sociali. », però, su questo piano che la
questione fondamentale della filosofia moderna, ovvero la rappresentazione
politica del popolo e l'incarnazione dello Stato nella potenza della
moltitudine, si ripropone in maniera irrisolvibile. Se non si dà mai, a livello
europeo (e aldilà di esso), un vero e proprio potere costituente democratico,
bisogna forse concludere, come facevo già qualche anno fa parodiando Hegel, che:
«Non c'è Stato in Europa»
(Es gibt keinen Staat in Europa)?
Sembrerebbe, a questo punto, che ci troviamo di fronte ad una strana aporia: la
nozione tipicamente europea di sovranità, prodotto secolare della storia
europea, nella quale si incontrano la costituzione del popolo e quella statale,
si rivela inapplicabile all'Europa stessa...
|