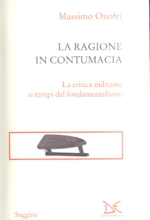
|
|
|
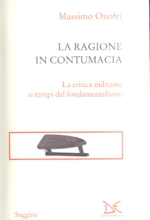
|
|
|
| << | < | > | >> |Indice
3 I. Una premessa e qualche domanda
13 II. Perché la critica?
37 III. Pensare la letteratura:
del giudizio, del gusto e del genio
73 IV. Fare letteratura:
la critica come genere letterario
99 V. La critica, il canone e la democrazia
117 Indice dei nomi
|
| << | < | > | >> |Pagina 3C'è un limite oltre il quale la critica letteraria diventa, tout court, critica della vita? C'è un punto in cui, per chissà quale metamorfosi, l'interpretazione di un'opera può diventare, in quanto tale, notizia del mondo, di un mondo abitabile, ben oltre la letteratura? Dico «opera», in quanto «costruzione simbolica» attuata dal lettore con l'atto della lettura, non «testo» come insieme di «tracce d'inchiostro», secondo la distinzione proposta da Franco Brioschi nella Mappa dell'impero (1983). Non importa granché adesso – e non varrebbe la pena nemmeno sottolinearlo –, se si tratta d'un mondo che sta dentro o fuori di noi. Marcel Proust, all'inizio del secolo, credendo di consegnare per sempre Sainte-Beuve e il suo metodo di lettura psicologico alla preistoria della critica, aveva drasticamente distinto l'io che vive, quello che continua a restare al di là dei libri che firma e autorizza, dall'io che scrive, virtuale e implicito in quegli stessi libri, consegnando soltanto il secondo ai fasti dell'ermeneutica letteraria. Il secolo e molti decenni di trionfante teoria della letteratura l'avrebbero a lungo assecondato: magari in nome dell'autonomia del significante, del mito della letterarietà, o magari dell'autosufficienza dell'estetica. Oggi, a un secolo esatto di distanza, sappiamo invece che le cose non sono così semplici come credevano, da sponde opposte, Proust e Sainte-Beuve. Quando è vero che l'autore, troppo presto dato per defunto — benché dai nostri tempi risuscitato persino con euforia —, s'è rivelato come un'entità non riconducibile, interamente, né alla vita, né alla scrittura, ma quale risultato, invece, della loro misteriosa contaminazione, da verificare volta per volta. Mentre ha saputo guadagnare un'aura di cui non ha mai goduto, forse, nemmeno ai tempi pionieristici della psicanalisi, laddove ogni testo cominciava a essere interpretato come il possibile documento d'una nevrosi. Si direbbe l'aura di un redivivo, insomma, con tutte le implicazioni teologiche — e autoritarie — del caso: George Steiner e Harold Bloom, in tal senso, docent. Qualora, però, ci si volesse mantenere a più laici intendimenti, e filologicamente corroborati, basterebbe pensare alla vicenda d'un saggista come Cesare Garboli: il quale, con l'eccezione di qualche classico — Dante, Molière, Pascoli — non ha fatto altro che cimentarsi coi libri scritti dagli amici, da quegli autori in carne e ossa che, cioè, sono fisicamente entrati nella sua vita, costituendola per quello che effettivamente è stata, contribuendo ad assicurarle il passo e il respiro che ha potuto avere. È vero: è difficile sottrarsi, oggi, alle pretese che l'autore, col suo ritorno, imperiosamente avanza. Persino il più brillante allievo di Roland Barthes (quel Barthes che, appunto, firmò, nel 1968, il saggio intitolato La morte dell'autore), Antoine Compagnon, partito per difendere dalle obiezioni del senso comune il suo maestro — e, con lui, la teoria della letteratura come disciplina in sé —, ha finito per consumare, nel suo bel libro Il demone della teoria (1998), un vero e proprio parricidio: non solo acconsentendo a molte di quelle obiezioni, sollevate non di rado proprio in nome della recuperata nozione di autore, ma arrivando addirittura a rivalutare quel Raymond Picard — grande accademico e fautore strenuo dell'intenzione d'autore, volontaria e lucida, come fondamento d'ogni opera letteraria — il quale, nel 1965, aveva accusato la nouvelle critique (e il suo capofila Barthes) d'essere niente altro che una nouvelle imposture. Ho però l'impressione che questo ritorno all'autore — e all'intenzione d'autore come fonte d'attribuzione di senso quanto agli eventuali significati dell'opera letteraria — non possa molto aiutarci relativamente alle domande che formulavo in apertura di queste pagine. In un memorabile saggio di Giacomo Debenedetti, Commemorazione provvisoria del personaggio-uomo (1965), un alter-ego, «nemico o vicario», viene incontro a chi legge, in migliaia d'esemplari, dalle pagine di tanti romanzi e racconti. Se gli domandiamo chi sia, questi, come un poliziotto in borghese, potrebbe sollevare il risvolto della giubba, esibendo quel distintivo dove sta inciso «il suo motto araldico», quello che ammette il «più capitale» dei suoi compiti: «si tratta anche di te». Ecco: benché l'io che scrive, supremamente dialogico lo sappiamo, torni a moltiplicarsi e polverizzarsi nella folla infinita dei personaggi di un'opera, e per quanto ogni personaggio-uomo resti, di fatto, una delle più concrete attuazioni delle intenzioni d'autore, chi legge sarà piuttosto interessato a ciò che quel personaggio avrà da confessargli, sulla vita e sul mondo, alla possibilità, insomma, di cogliere, nella sua vicenda narrativa, un crittogramma del proprio destino: perché, come osservava Debenedetti, si tratta anche di lui. Vengo al punto: benché siano passati alcuni decenni, da quando abbiamo prima assistito alla nascita dello strutturalismo e alla sua crisi irreversibile, quindi all'affermarsi della teoria della ricezione e del ruolo risolutivo del lettore, infine al trionfo di un'ermeneutica secondo cui non possono esistere fatti — né opere in sé — ma solo interpretazioni, la questione fondamentale non mi pare sia stata ancora posta sino in fondo. Il vero nodo da sciogliere non riguarda, infatti, il lector in fabula, ma il lettore in carne e ossa, quello che, mentre legge, continua a vivere, se interrompe la lettura o decide di prolungarla a piacimento, assecondando tutte le urgenze e i desideri, le necessità e i doveri che la giornata gli impone. E lo si dice con riferimento a una distinzione, questa sì, davvero cruciale: quella tra «il lettore implicito» (come lo chiamava Wolfgang Iser: ma avrei potuto parlare, con Michel Riffaterre, di «arcilettore», o, con Umberto Eco, di «lettore modello»), mera funzione semiotica che lo stesso testo postulerebbe, e il lettore che legge mentre vive, e proprio perché vive, mangia, dorme, sogna, odia e fa l'amore, insomma il lettore che, effettivamente, occupa il suo, il nostro, orizzonte quotidiano. Nel secolo appena trascorso, se c'è una figura che ha sempre, e naturalmente, garantito i diritti di questo lettore diciamo così dal volto umano, questa è il critico militante. E l'ha fatto confutando, col suo lavoro d'ogni giorno, tutti i dogmi che la teoria della letteratura quotidianamente celebrava. Non preoccupandosi, cioè, di dare ascolto, quando il caso, alle richieste del senso comune: e con la stessa ostinazione con cui non ci si rassegna a negare che c'è il sole, soltanto perché tutti hanno improvvisamente cominciato a dire che piove. Il critico militante lo sa bene: la sua, sui giornali dove scrive, sulle riviste cui collabora, è una funzione di servizio. L'autore sarà pure morto: ma il lettore non ha mai smesso di chiedere al critico notizie del caro estinto. Quando quel lettore poi incontrerà lo scrittore amato, in uno di quei festival oggi di grande fortuna popolare, là dove, magari, è andato proprio per conoscerlo di persona, non esiterà a chiedergli un autografo: una richiesta che non trova spiegazioni soltanto in una declinazione del fenomeno del divismo, ma che può valere anche come un'implicita presa di posizione critica. Del resto: l'opera di D'Annunzio e Pasolini avrebbe oggi lo stesso significato, se la loro vita, diversamente inimitabile, non vi proiettasse la sua lunga ombra? Carla Benedetti, nel 1999, ha scritto un libro appassionato per dimostrarlo. E poi: hai voglia a dire che la letteratura parla solo di se stessa: il lettore dal volto umano andrà a cercarvi, invece, una traccia della realtà, poco importa se per decifrarla o per imparare a sopportarla, quella vita, se in vista d'una conoscenza o d'una consolazione irrinunciabile. Il lettore legge perché ha a cuore soltanto la sua esistenza, non altro: e con riferimento al posto che la bellezza e la verità potranno avervi, agli impedimenti che rallentano o sconfessano l'affermazione di quegli stessi valori. Ecco perché resterà sempre grato a quel critico che, tra le righe d'un romanzo, o dentro i versi d'una poesia, gli abbia fatto scorgere le linee d'un oroscopo: così come ancora benedice il probo professore di liceo che, adolescente, lo convertì all'amore per la letteratura, ai suoi impensati benefici. Ci sono finalmente arrivato: al lettore dal volto umano non interessa la critica letteraria, se non in quanto critica della vita. | << | < | > | >> |Pagina 20Il critico militante lo sa bene: Dio è morto. Anche se oggi, in nessun luogo del mondo, ci si rassegna a fargli il funerale. Ma non crede certo, con la sua pretesa di giudicare, di potersi sostituire a Dio: come qualcuno ha scritto. Pensare è giudicare: non altro. Connettere un soggetto a un predicato in un giudizio e poi verificarlo. La proclamata necessità del giudizio nella critica vuole dire soltanto questo: che il critico non si rassegna a riconoscere, in letteratura, ma anche nella vita, altro tribunale che non sia la sua fallace, minuscola, problematica, incerta ragione. Ecco perché, a somiglianza d'una celebre definizione kantiana dell'Illuminismo, una possibile definizione della critica potrebbe suonare così: l'uscita degli uomini da uno stato di minorità a loro stessi dovuta. Laddove la minorità sta nell'incapacità di servirsi della propria ragione senza la guida di un altro. A loro stessi dovuta, questa minorità, se la causa che l'ha prodotta non è un difetto d'intelligenza, ma la mancanza della decisione e del coraggio di servirsene senza guida. Anche Foucault, in una brillante conferenza tenuta il 27 maggio 1978 alla Sorbona e pubblicata in italiano nel 1996 col titolo Illuminismo e critica, ha provato a tradurla così. Questo significa, ovviamente, che il critico militante non aspira, né potrebbe, a fare la guida del lettore. È, piuttosto, un lettore che vuole vederci più chiaro: e che, col lettore reale che a lui si rivolge, vuole dialogare in tutti i modi possibili. Il critico militante conserva — forse questo sì — un'unica suprema illusione: che la ragione sia l'unico luogo possibile d'una condivisione, intersessuale e interculturale, interclassista e internazionale. Il suo, insomma, è, diciamo così, un illuminismo trascendentale: nella convinzione che gli uomini e le donne di tutto il mondo o si dispongono al dialogo e all'intercomunicazione, senza false ipocrisie e retoriche politicamente corrette della tolleranza, o si combattono e si annientano per la conservazione degli spazi vitali, che l'inarrestabile sovrappopolazione del pianeta inarrestabilmente riduce. Si facciano pure sventolare le bandiere della rabbia e dell'orgoglio: ragioni non ne mancherebbero (e non ne mancheranno mai), ma si tratta di buone ragioni? Si continui pure a ritenere che la politica è quel territorio dell'esperienza regolato da una sola, implacabile, dialettica, quella tra amico e nemico, come vuole il Carl Schmitt oggi molto in auge soprattutto a sinistra: gli imperativi della diplomazia, in funzione magari d'un hobbesiano principio di autoconservazione — anche della specie umana, bisognerà dire dopo Hiroshima —, saranno sempre più vincolanti di quelli della guerra. Perché questo è il punto: il critico militante, col suo illuminismo trascendentale, dà per acquisito, dopo più d'un secolo di ricerca antropologica, che «l'Altro» non può e non deve essere mitizzato: né come soggetto da respingere e demonizzare, ma nemmeno come portatore indiscusso e indiscutibile di valore, comunque da giustificare; né come cristallizzazione di ancestrali paure prodotte dall'insicurezza, né come fantasma di perenni sensi di colpa e, per ciò stesso, da assecondare in ogni caso, da risarcire sempre e comunque. L'«Altro», in fin dei conti, siamo noi: l'interlocutore d'una conversazione che è prima di tutto un dialogo con se stessi.| << | < | > | >> |Pagina 26Credo ci siano ottime ragioni per sostenere, al contrario, che una rinnovata prospettiva illuminista — di illuminismo trascendentale, come si proponeva — debba necessariamente passare per una definitiva acquisizione del «relativismo culturale», proprio in quanto valore universalizzabile. Tanto più che nel discorso di Sternhell si trova una presupposizione del tutto indebita: la correlazione, che viene data per necessaria, tra universalità della natura umana e diritto naturale, come se postulare una certa uguaglianza tra tutti gli uomini, qualunque essa sia, significhi ammettere, per ciò stesso, l'esistenza di leggi naturali. Quelle leggi che oggi, in Occidente, vengono proclamate in ogni dove, senza nemmeno discussione, come la più pacifica verità, con l'avallo autorevole di due pontificati. C'era da essere orgogliosi, in quanto laici, se Wojtyla riabilitava Galileo Galilei e chiedeva perdono per la sua condanna da parte dell'Inquisizione? Nemmeno per idea, credo: perché Wojtyla non lo faceva di certo in nome della libertà della ricerca, ma nella constatazione che Galileo — tanto più filosoficamente sprovveduto del suo avversario, lo strumentalista Bellarmino — aveva ritenuto l'universo regolato da leggi universali e necessarie e che Dio parlasse in linguaggio matematico. Allo stesso modo Ratzinger, senza che quasi più nessuno abbia qualcosa da eccepire, parla con disinvoltura di leggi naturali, secondo un'idea di natura, normativa e ottimistica, che non ha più cittadinanza, da molto tempo, nella cittadella della scienza moderna, laddove natura vuol dire anche caos e disordine, aborto e stupro, violenza. Sternhell ha perfettamente ragione quando scrive che l'«Illuminismo voleva liberare l'uomo dalle costrizioni della storia, dal giogo delle credenze tradizionali e non verificate». Ma non si rende minimamente conto che tutto questo entusiasmo giusnaturalista, questo ritorno euforico alla teoria dei diritti naturali, propagandata come la più sicura panacea contro la deriva nichilistica della società contemporanea, dovrebbe essere rubricata, da un novello Bacone che volesse riscrivere il suo Novum Organum, come forse il più pertinace degli odierni idola theatri, e cioè quei perniciosi pregiudizi che nascono dalle dottrine filosofiche del passato, le quali, come vere e proprie scene di teatro, parlano soltanto di mondi immaginari. Viceversa, è proprio un autentico riconoscimento del «relativismo culturale» come «principio metodologico» — sto usando il termine in un'accezione che Nicola Abbagnano impiegava già nel 1962: proprio lui, sì, il rappresentante, insieme a Bobbio, di quel neoilluminismo che ebbe una qualche fortuna nell'Italia degli anni sessanta —, perfettamente coniugabile con un atteggiamento profondamente illuminista. Immaginate un attimo che il persiano di Montesquieu (ma sarebbe sufficiente anche il marziano di Flaiano: tale è la tristezza dei tempi) tornasse a percorrere l'Italia di oggi e si trovasse ad assistere, che so, alla celebrazione del sacramento dell'eucarestia. Ecco: credete che il suo stupore – la sua capacità di capire veramente, di accettare, di giustificare – sarebbe di natura diversa da quello di un occidentale che si fosse trovato nel 1878, in Papua Nuova Guinea, di fronte all'atroce spettacolo di quei cannibali che divorarono quattro missionari metodisti? Sacramento? Ma che cos'è un sacramento, si chiederebbe il persiano di Montesquieu: il pane e il vino che diventano qualcosa d'altro? Interrogativi da paralizzarlo di meraviglia.
Non vorrei essere frainteso su questo cruciale punto.
Cercare di capire in base a quale sistema di valori – e in
nome di quale distinzione tra ciò che sarebbe lecito, legittimo, e ciò che
invece non lo è – l'atto di cannibalismo
diventa spiegabile non significa, per ciò stesso, accettare
e giustificare. Si dirà: c'è una bella differenza tra il mangiare un uomo e il
mistero dell'incarnazione replicato attraverso la trasformazione del pane e
del vino nel corpo e nel sangue di Cristo. Certamente, ma, per dirla in altri
termini: in base a quale criterio, visto che il senso comune non ci potrà
aiutare (quand'anche poi fosse in grado d'aiutarci e non fosse determinato, come
invece è, dalla singola cultura che lo produce), dovremmo ritenere più
accettabile e giustificabile il rito dell'eucarestia del cavallo alato con cui
Maometto raggiunse Gerusalemme? La questione, insomma, è un'altra: in nome di
quale regola universalmente condivisibile – sul piano di un'eventuale
comunicazione interculturale, insomma di un dialogo
tra diverse civiltà magari in conflitto – un comportamento potrebbe essere
unanimemente, consensualmente, legittimato? Tanto più che rivendicare e
brandire, a questo proposito, un presunto diritto naturale sarebbe
quanto meno inopportuno, se è vero che quello
jus naturale
è stato, nel seno stesso della cultura occidentale, e
quasi da subito, radicalmente criticato, sino a ravvisarvi,
come fece Marx, l'apoteosi dei privilegi, non dell'uomo
naturale, ma d'un uomo storicamente determinato, il
borghese della vincente società capitalistica. Al di là di
tutto – e al di là delle ragioni o non ragioni marxiste: che
possono anche essere insussistenti – si sa come sono poi
andate le cose: le minoranze etniche, le classi storicamente subalterne, le
femministe hanno voluto alla fine
riconoscervi, in quella teoria del diritto naturale, la celebrazione, classista
ed eurocentrica, del maschio bianco
capitalista e occidentale. Si potrebbe invece sostenere – e
credo con un certo realismo, di sicuro non soggiogati da
chissà quale seduzione alcinesca dell'utopia – che lo sviluppo della critica
(insomma d'un eventuale illuminismo trascendentale) – sempre opera di pochi
coraggiosi, del resto – ha finito con l'ottenere successi insperati, nel corso
dei secoli, all'interno delle singole e diverse culture.
Ho detto prima dei cannibali della Papua Nuova Ginea, del loro feroce
crimine ai danni di missionari cristiani: ma può anche succedere – com'è
accaduto per esempio il 17 agosto 2007 – che i discendenti di quei cannibali
chiedano formalmente scusa per quanto commesso dai loro antenati e che
l'ambasciatore delle Figi in Papua Nuova Guinea le accetti con una pubblica
cerimonia. Lasciamo stare quanto di «politicamente corretto»
sembra ispirare tutta l'operazione. Ciò che conta, qui, è
la dimostrazione, la più chiara possibile credo, che le
culture non sono sistemi chiusi, monolitici, compiuti in
se stessi una volta per sempre, come vorrebbero certi
fautori filosofici – non metodologici – del «relativismo
culturale», e che l'intercomunicazione è, non soltanto
possibile, ma persino foriera di cambiamenti e di reciproci condizionamenti tra
le diverse comunità.
|